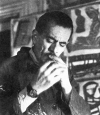MARIO SIRONI
- Genio Compositore -
VOL. IV
UNIVERSALITÀ DELLA MONTAGNA
Il "discorso" di Sironi, circa l’ontologia della montagna, continua ad evolversi incessantemente sino a raggiungere una lezione ultima che rappresenta, appunto, l’approdo di tutto il processo creativo. Mi riferisco all’"Universalità della montagna" (v. Vol. III, pag. 75), in cui Sironi, forse per la prima volta, non si pone più il problema della categoria-montagna, ma, semplicemente, si lascia sommergere da una dovizia di particolari (anche i più minuti), che costituiscono tutta la concretezza dell’immagine-montagna, con lo scopo preciso di riemergere prepotentemente, operando un’astrazione assoluta, geometrica, secondo uno schema del tutto nuovo: una natura altra, inventata e creata "ex nihilo".
L’uomo per sua tendenza naturale aspira all’assoluto e solo l’arte è in grado di fornirgli la grande occasione per avvicinarsi ad esso quanto più possibile. Un’arte, tuttavia, eterocosmica, un’arte che si libra al di sopra dei fenomeni fisici, sociali, politici, verso un’astrazione totale per mezzo della quale egli si rende alfine padrone del proprio destino, in un nuovo mondo, quello dell’arte, ove tutto è possibile perché tutto poggia sull’idea, sull’immaginazione, sull’invenzione. E Sironi proprio questo intuisce: la montagna è un assoluto naturale, che può diventare, in pittura, un assoluto ideale. In "Universalità della montagna" egli cerca per la prima volta (e forse l’ultima) un mondo ideale, che si forma su uno schema del tutto nuovo: una montagna completamente reinventata come fatto geometrico concettuale, ben al di là dei dati dell’esperienza e della riflessione critica. Due grandi lastre rosso-marroni, somiglianti a due libretti, con bordi bianchi spessi: uno inseguente l’altro, ma entrambi sospinti da una misteriosa irresistibile forza propulsiva, e non verticale, bensì di direzione obliqua, a tagliare un cielo, immediatamente giallo e più in alto azzurro, come due piatte astronavi. Entrambe attraversate, al centro del loro corpo, da due forti e spesse linee bianche.
Le due lastre poggiano su un’altra linea bianca che delimita un’informe, ma sfuggente (verso l’esterno) superficie di color ocra, molto levigata. Al di sotto delle lastre, diversi blocchi bianchi (non riconoscibili) puramente astratti e tuttavia molto pressanti, assolutamente necessari alla composizione, perché originalmente pittorici.
Tutta la rappresentazione fa pensare a Kant quando asserisce ("Critica della Ragion Pratica", 1788, A. 245): "Ogni uso della ragione concernente un oggetto (qui, appunto, la montagna) presuppone concetti dell’intelletto (categorie) in mancanza dei quali non è possibile pensare alcun oggetto".
E Sironi, attraverso molteplici rappresentazioni di montagne, ha creato alfine concetti puri, ossia categorie estetiche autonome, originali, non più naturalistiche. Quindi egli, proprio con l’opera "Universalità della montagna", può infine pervenire ad una nuova categoria della montagna, che (come sostiene Kant) avrà "sede nell’intelletto puro, indipendentemente e anteriormente ad ogni intuizione, in quanto facoltà di pensare (...)" (op. cit., A. 246).
Come abbiamo visto, con Sironi nasce una nuova idea della montagna: una forma ideale, quasi metafisica, parto libero del pensiero, sintesi somma che tutto trascende, giacché rappresenta una realtà eterocosmica, confrontabile e comparabile con l’oggetto quo ante, ma senz’altro autonoma e indipendente da esso, poiché è la base di enormi possibilità, poste e descritte col solo pensiero, con un’impronta estranea alla condizione dell’uomo della natura, ma che riproduce l’idea originale, in grado di diventare una nuova tipologia della funzione (montagna) artistica.

"Composizione di due catene montuose sovrapposte" (olio su tela, cm.58x88, A.1942 ca., Coll. privata, Roma) appartiene alla "categoria" dell’universalità della montagna, ossia al processo creativo sironiano che mira, attraverso l’entità-montagna, a raggiungere l’astrazione perentoria, assoluta, geometrica della categoria-montagna, ossia la montagna, che è un assoluto naturale, diventa, nell’immaginario sironiano, un assoluto ideale, universale.
L’opera qui presa in esame è un esempio calzante di tale assunto. Intanto perché l’Artista elimina per intero la "calligrafia" degli scoscendimenti rocciosi (picchi, valloni, cenge, strapiombi, pareti scoscese, tetti, ecc.), riducendo il tutto a masse-macchie di colore scuro e chiaro, in un susseguirsi volumetrico, grafico-pittorico, fatto di vuoti e pieni, dove i vuoti sono bianchi ed i pieni scuri. La composizione, inoltre, è resa in modo quasi fotografico, in bianco e nero. Due catene montuose, l’una superiore più ampia, l’altra inferiore più esigua, quasi ritagliata sul modello della prima. La superiore "ritaglia" in bianco e nero un imponente massiccio montuoso del tutto geometrico e volumetrico, un "monstrum" possente, estraneo, inaccessibile. La catena inferiore è, al contrario, molto più sottile, tagliata a metà, con le sole vette arrotondate, con larghi squarci bianchi sulle cime, contrappuntati da strisce compatte di nero. Il cielo in alto è una lastra bianca, piatta, somigliante ad una sorda esplosione scaturente dalle cime. Intorno, tutt’attorno, ai lati, così come sopra la catena inferiore, ed anche al di sotto della stessa, aleggia una sottile nebbiolina verde chiaro, proprio color "penicillina". Il tutto lascia pensare ad una visione onirica, molto stilizzata, eppur tuttavia molto presente, possente, epica, da cui ha origine la "concettualità" stessa della montagna.