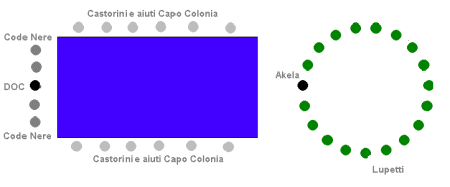|
|
 |
|

Il Castorismo nasce in Canada nel 1971 per rispondere all’esigenza dei molti genitori che chiedevano un’esperienza di scoutismo per i loro figli più piccoli. La sperimentazione, realizzata da vari gruppi secondo metodi diversificati, si protrasse fino al 1975 quando l’Associazione Scout Canadese sintetizzò in un unico progetto educativo le varie esperienze sperimentali e diede ufficialmente vita al castorismo canadese. Con metodologie simili esso si è sviluppato successivamente in molti Paesi (a volte assumendo nomi diversi), tra i quali la Gran Bretagna, l'Olanda, l'Australia, la Nuova Zelanda.
I positivi risultati ottenuti hanno fatto sì che in molti Paesi esso sia a tutti gli effetti una Branca ufficiale all’interno delle varie Associazioni Scout. In altri è ancora in fase di sperimentazione.
In Italia esso è ancora abbastanza sconosciuto malgrado i tentativi fatti da alcune associazioni di attivare un metodo Scout per questa fascia di età. E’ doveroso ricordare il lavoro svolto negli ultimi 10 anni dall'Associazione Italiana Castorini (che ha aperto colonie nell'ambito di Gruppi AGESCI pur mantenendo una struttura organizzativa separata) e dall'Associazione Giovani Esploratori Sardi che ha concluso la fase sperimentale ed ha ufficializzato la Branca Castorini proprio in questi ultimi anni.
Il progetto "castorini" in ARCISCOUT nasce nell'estate del 1997 in forma sperimentale, grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Giovani Esploratori Sardi (AGES). Un grosso contributo è arrivato anche da alcuni Capi dell'Associazione Scout Canadese che hanno messo a disposizione il materiale prodotto dai loro Gruppi e dall’Associazione. La Branca Castorini è divenuta ufficiale il 6 dicembre 1998 con l’approvazione da parte della Assemblea Generale.
Il metodo da noi adottato si ispira alla tradizione del Castorismo canadese Naturalmente il metodo è stato poi adattato alla tradizione della nostra associazione nell’ottica di garantire una continuità educativa nelle branche successive.
Prima di entrare nei dettagli del metodo è opportuno precisare che il Castorismo non deve essere visto come una sorta di “Lupettismo in miniatura”, bensì come un progetto pedagogico appositamente strutturato in funzione delle caratteristiche del bambino nell’età compresa tra i 5 e i 7 anni e con finalità proprie per questa fascia d’età.
A tal proposito è necessario delineare alcune caratteristiche del bambino nell’età compresa tra i 5 e i 7 anni.
Fermo restando il fatto che non è
possibile determinare un modello fisico "standard" valido per tutti i bambini,
in quanto lo sviluppo in questa fase di accrescimento è strettamente
soggettivo, si devono comunque tenere presenti alcune considerazioni di
ordine generale.
Il bambino in questa fase della crescita
presenta un accrescimento staturale non accompagnato né da un adeguato
accrescimento ponderale, né, tantomeno, da un adeguato irrobustimento
muscolare. In particolare si assiste ad un certo irrobustimento della muscolatura
degli arti inferiori mentre ritarda lo sviluppo muscolare delle dita ed
in generale della muscolatura fine.
Questo fenomeno implica alcune considerazioni:
1. Il bambino deve ricercare nuovi equilibri
spaziali al fine di adattarsi alle modificazioni staturali (allungamento
degli arti, modificazione della posizione del baricentro, ecc.); questa
ricerca di equilibrio, se non correttamente educata, può provocare
nel bambino para-morfismi (scoliosi, cifosi, ecc.). Particolare cura dei
Capi sarà dunque l'educare il bambino a posture e movimenti corretti;
2. E’ necessario avere coscienza
dei limiti strutturali del bambino per non sovraccaricarlo di sforzi eccessivi,
il bambino è, infatti, capace di sostenere sforzi intensi ma limitati
nel tempo;
3. Particolare cura va posta nel sottoporre
al bambino esercizi che gli consentano di sviluppare le attività
di coordinamento motorio e manuale.
E' importante che il bambino prenda coscienza di sé, dello spazio che lo circonda e di sé inserito nello spazio. E' altresì importante aiutare il bambino a sviluppare il coordinamento psicomotorio. E' perciò necessario che l'attività comprenda esercizi, svolti sotto forma di gioco, che permettano al bambino di acquisire i concetti di avanti-indietro, sotto-sopra, destra-sinistra, alto-basso e che gli facciano prendere coscienza dei propri movimenti e dell'interazione degli stessi con il mondo che lo circonda.
In questa fase il bambino è stimolato
a superare la precedente fase egocentristica tipica della prima infanzia
(l’ingresso nel mondo della scuola porta il bambino a separarsi dal nucleo
familiare e a rapportarsi necessariamente con il gruppo dei pari, e spesso
questo accade non senza traumi) ed è stimolato per curiosità
a rapportarsi con gli altri. In genere il confronto assume la connotazione
di scontro (aggressività). E' perciò importante, attraverso
il gioco strutturato, educare il bambino ad interagire con i propri compagni.
Questo può avvenire attraverso forme di gioco collaborative e non
competitive.
Inoltre la conoscenza, l'accettazione
e il rispetto delle regole faranno comprendere al bambino l'importanza
del gruppo come realtà strutturata.
Non va dimenticato inoltre che in questa fase d'età avviene un primo allontanamento del bambino dai genitori, egli supera, cioè, la fase della prima infanzia dove è coccolato, ed entra in una fase di maggiore autonomia (naturalmente guidata). E' dunque importante che il bambino trovi nel gruppo persone capaci di aiutarlo a rendersi autonomo, senza peraltro fargli mancare quella sicurezza che fino a poco prima era direttamente connessa alla diretta dipendenza dei genitori.
E' particolarmente importante educare il bambino all'attività manuale finalizzata non tanto ad ottenere particolari risultati concreti, quanto a sviluppare una corretta manualità in modo che egli acquisisca sicurezza nell'utilizzo degli strumenti elementari e si eserciti a rendere concreta, attraverso la materia, la propria fantasia.
E’ necessario che il rapporto che si instaura
tra il bambino e l’educatore (capo) sia quanto più possibile sereno
ed informale. Deve essere altresì chiaro il ruolo esercitato dal
Capo unità che non deve essere confuso con quello esercitato dai
genitori, ma altresì impostato sulla relazione del giovane castorino
con il "fratello maggiore".
I Capi avranno l'attenzione di non sgridare
il bambino in modo brusco e di non limitare la sua creatività. Eventuali
rimproveri dovranno avvenire preferibilmente in privato facendo leva sulla
responsabilità presa al momento del "Patto", facendo capire al bambino
che la sua corretta presenza è importante per tutta la colonia.
Eventualmente i rimproveri dovranno essere espressi in modo generalizzato, al momento del cerchio, coinvolgendo la colonia nella riflessione sulla necessità di mantenere un clima sereno e gioioso che permetta a tutti di stare bene assieme.
I punti brevemente sopra esposti saranno ripresi in seguito nell’analisi metodologica.
L’analisi del metodo che segue, prende
spunto dagli articoli del regolamento di branca (riportati in grassetto
inclinato) e sulla base di questi vengono sviluppate alcune considerazioni
di carattere pedagogico e metodologico.
Art. 1. E' costituita la Branca
Castorini allo scopo di raggruppare in un progetto educativo organico i
bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e i 7 anni, chiamati
"castorini", avente le seguenti finalità:
|
Posta all’inizio nel cammino Scout, la Branca Castorini rappresenta il primo ambiente dove il bambino inizia a vivere la propria Progressione Personale Scout attraverso la quale, di branca in branca, si tenderà ad uno sviluppo equilibrato ed integrale della persona nella sua dimensione fisica, morale e civica.
Per quanto riguarda i castorini possiamo
delineare alcuni obbiettivi minimi che il bambino dovrà conseguire
durante la sua permanenza in colonia:
| Dimensione fisica | Conoscere il proprio corpo, rapportarsi con lo spazio, acquisire sicurezza nella manualità e nei movimenti... |
| Dimensione morale | Imparare a vivere nel gruppo e a relazionarsi, imparare a rendersi utili, abbozzare una prima scala personale di valori... |
| Dimensione civica | Imparare il valore delle regole e il concetto di democrazia |
In quest’ottica il lavoro svolto nella Branca non deve essere considerato una semplice forma di animazione finalizzata ad intrattenere il bambino con giochi fini a sé stessi, ma come un progetto educativo organico che si proponga un suo sviluppo completo ed equilibrato. E’ perciò importantissimo che l’attività sia progettata accuratamente e non sia frutto di improvvisazione, e che le varie attività siano guidate da obiettivi chiari.
L’educazione al servizio e all’autonomia, realtà proprie di tutto il cammino Scout, si concretizzano per il castorino:
L’età 5-7 anni è anche un periodo di grandi cambiamenti per il bambino dal punto di vista emotivo. Egli scopre, infatti, progressivamente, una certa autonomia di pensiero, comincia a chiedersi il “perché” di ciò che accade e a motivare le sue scelte, cerca la compagnia di altri bambini, ma al tempo stesso continua a considerare sé stesso il centro dell’universo, trova inoltre difficile esprimere il proprio mondo interiore, ricco di immagini fantastiche, in quanto non abituato a relazionarsi con il gruppo dei pari, ed incapace, al tempo stesso, di farsi comprendere dall’adulto.
E’ questo il periodo nel quale il bambino si trova a vivere le prime esperienze di socializzazione all’interno della scuola.
E’ un periodo caratterizzato anche da mutamenti fisici e dalla necessità per il bambino di imparare a conoscere il proprio corpo, l’ambiente che lo circonda e, soprattutto, l’interazione tra sé e l’ambiente (acquisire padronanza dello spazio in cui muoversi).
E’ perciò necessario, innanzi tutto, che l’adulto-educatore aiuti il bambino ad imparare a relazionarsi con gli altri bambini e ad esprimere la propria ricchezza interiore. Per fare ciò è però necessario che si crei tra il bambino e l’adulto quel legame di fiducia che permette al bambino di esprimersi liberamente.
Troppo spesso l’adulto è portato a considerare il bambino solo come una sorta di “spugna” capace di “assorbire” le nozioni e i comportamenti imposti dal mondo degli adulti. Ma questo non significa “educare” quanto “addestrare” il bambino. Il cammino Scout è un cammino educativo e non di “addestramento”.
L’educazione del bambino deve perciò seguire una logica opposta. Educare è infatti un termine che in latino viene tradotto con ex-ducere, ovvero condurre fuori. Il compito dell’educatore è perciò quello di aiutare il bambino ad esprimere al meglio le proprie potenzialità e a formarsi delle “regole” autonome di comportamento che il bambino possa percepire come proprie perché nate dal gruppo dei pari.
Perché questo sia possibile, è necessario che l’adulto goda della fiducia del bambino; che il bambino apra all’adulto, la “porta” del proprio mondo interiore in modo tale che l’adulto poi possa intervenire non in forma impositiva, ma in forma propositiva. Questo può avvenire solo se è l’adulto a mettersi al livello del bambino e a cercare di comprendere il suo mondo vedendolo dal punto di vista del bambino.
L’adulto perciò non dovrà “travasare” sul bambino le proprie nozioni o i codici di comportamento, quanto fargli vivere quelle situazioni che gli permettano di scoprire ed affinare le proprie abilità e al tempo stesso di imparare a relazionarsi in modo positivo con il gruppo dei pari.
Il Capo Scout è per definizione un “fratello maggiore”, una persona che gode della stima del bambino in quanto considerato persona autorevole (non autoritaria) capace di “calarsi” nella realtà del bambino, comprenderne i bisogni e dare una risposta alle sue domande utilizzando il codice comunicativo proprio del bambino: il gioco, l’espressione, ecc..
Gli strumenti di cui disponiamo
Gli strumenti che il Capo potrà utilizzare sono:
1. Il gioco: esso rappresenta lo
strumento educativo per eccellenza. Attraverso il gioco il bambino vive
situazioni che lo stimolano a rapportarsi con gli altri e ad esprimere
il proprio mondo interiore. Il gioco non deve mai essere fine a sé
stesso ma deve rappresentare per il bambino un’occasione per scoprire le
proprie abilità e allenarsi a superare i propri limiti, in un clima
sereno, nel quale l’eventuale “errore” non venga considerata una
“colpa” ma un incentivo a migliorarsi con gradualità e costanza.
Inoltre la presenza di regole nel gioco aiuterà il bambino a relazionarsi
con gli altri ed ad acquisire, ad esempio il concetto di “democrazia”
(le “regole” possono, ad esempio, essere discusse e “inventate” dai bambini
stessi, prima dell’inizio del gioco, e applicate durante il gioco stesso).
Con i castorini il gioco non deve avere come finalità la “concorrenza”
quanto la “cooperazione”. E’ infatti assolutamente sbagliato, in un’età
in cui il bambino non ha ancora imparato a relazionarsi in modo positivo
con gli altri, inserire il bambino in un contesto competitivo che porterebbe
comunque ad aumentare la propria aggressività e il proprio egocentrismo.
E’ importante far comprendere al castorino che il proprio compagno
di giochi non è un concorrente da sconfiggere, ma un fratellino
con cui divertirsi e crescere. Il gioco rappresenta inoltre uno strumento
per imparare a conoscere il proprio corpo, ad acquisire sicurezza nel movimento,
ad entrare in contatto fisico con i propri compagni in modo naturale e
rispettoso. Nel preparare il gioco, si tenga presente che il bambino di
5-7 anni è capace di sforzi intensi ma limitati nel tempo (è
un tipo “esplosivo” ma non costante) mentre non riesce a reggere uno sforzo
prolungato. Il gioco inoltre deve essere fatto di regole semplici, spiegate
in modo chiaro, magari attraverso una dimostrazione fatta dagli stessi
educatori. Vanno inoltre evitati tutti i tempi morti tra la spiegazione
e l’inizio del gioco avendo cura che il materiale di gioco sia preparato
prima dell’inizio della spiegazione.
2. L’attività espressiva:
attraverso il disegno, la costruzione manuale utilizzando elementi semplici
(carta, cartone, foglie secche, materiale di recupero) e lo stesso utilizzo
del proprio corpo (attività di recitazione, mimica, ecc.) il bambino
può esprimere la propria interiorità e far partecipi
gli altri del proprio mondo fantastico. Al tempo stesso giocare a “comprendere”
l’espressione dell’altro aiuta i bambini ad imparare ad “ascoltare” e a
migliorare la propria capacità comunicativa. E’ inoltre un ottimo
strumento per l’educatore per cercare di comprendere eventuali situazioni
di disagio vissute dal bambino il quale può esteriorizzarle “trasferendole”
nell’oggetto da lui animato, disegnato o costruito.
3. L’attività manuale: permette
al bambino di acquisire sicurezza nella manipolazione degli oggetti e
affinare le proprie abilità manuali. In questa fase di crescita
il bambino presenta una certa difficoltà nell’utilizzo delle mani
dovuta ad un ritardo nello sviluppo della muscolatura fine (in pratica
è più semplice per il bambino calciare un pallone che tagliare
un foglio di carta seguendo una linea tracciata). Il bambino va perciò
incoraggiato, evitando di evidenziare bruscamente gli “errori” ma
invitandolo a riprovare in quanto “ciò che ha fatto è molto
bello, e sicuramente, se lo farà ancora, sarà ancora più
bello”. In pratica lo stimolo deve essere sempre positivo e il bambino
si sentirà incoraggiato a “sfidare” sé stesso nel migliorare
le proprie abilità. Come per i giochi si deve evitare ogni competizione
tra i bambini.
4. Il canto: la finalità
di questo strumento è quella di imparare ad essere parte del gruppo.
Non importa se il bambino è “stonato” è invece importante
che egli canti assieme agli altri, che si senta parte del gruppo. E’ uno
strumento che permette, inoltre, di creare un clima rilassato, ad
esempio prima di iniziare un racconto o una chiacchierata.
5. Il racconto: serve a creare
una ambientazione fantastica all’interno della quale collocare le altre
attività. Attraverso il racconto possono essere inviati al bambino
alcuni “messaggi” che possono poi essere ripresi e concretizzati nell’attività
di gioco. Il racconto, nella branca castorini, è uno strumento flessibile
e adattabile alla situazione, sarà incentrato sulla vita del bosco.
E’ in fase di preparazione un racconto ispirato al libro “Friends of the
forest” realizzato dall’Associazione Scout Canadese. E’ comunque possibile
utilizzare altre storie e favole del bosco.
6. Le nuotate di esplorazione (uscite):
sono i momenti forti per stimolare il bambino a scoprire il mondo che lo
circonda: la natura, ma anche il territorio in cui egli vive.
7. I momenti celebrativi: come
il Patto, il cambio delle code, la grande nuotata: sono momenti forti di
vita di gruppo nel quale vengono ribaditi l’appartenenza al movimento Scout
e le finalità che il Movimento si propone, che per il castorino
si concretizzano nel rispetto delle Regole della Colonia.
La programmazione delle attività deve tenere presenti gli obiettivi che di volta in volta la staff Capi si darà e su questi costruire una sequenza di attività che utilizzino in modo appropriato gli strumenti di cui si dispone.
E’ importante prevedere momenti di verifica dell’attività svolta al fine di valutare si gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti nella loro totalità, raggiunti in parte o non raggiunti e di conseguenza “tarare” la progettazione delle attività future.
Al tempo stesso è importante essere abbastanza elastici e comprendere se l’attività progettata fa presa nei bambini o se essa debba essere “aggiustata” in qualche modo. In sostanza si devono privilegiare gli obbiettivi che ci si prefigge e su questi saper adattare gli strumenti.
| Art. 2. La Branca Castorini è
costituita da unità denominate "Colonie" integrate territorialmente
nei Gruppi. All'interno della Colonia i bambini sono raggruppati in gruppi
di età eterogenea denominati "Capanne" chiamate con il nome di un
frutto. Ogni Capanna può comprendere un massimo di 5 o 6 bambini.
E' raccomandata la presenza di almeno un adulto ogni 5 bambini, oltre al
Capo Colonia. Una colonia non può comprendere più di 25 castorini.
Ogni Colonia assume un nome di fantasia ispirato alla vita o alle caratteristiche
dei castori.
3. Ogni Colonia è guidata da un Capo Colonia designato dalla Comunità Capi del Gruppo di appartenenza. Ad esso possono affiancarsi, con funzione di aiuto-capo, altri Capi e Rovers in servizio nonchè adulti, preferibilmente genitori, adeguatamente preparati allo scopo e che abbiano ottenuto parere favorevole alla presenza in Colonia da parte della Comunità Capi su proposta del Capo Colonia. Gli adulti presenti in colonia, che non hanno pronunciato la Promessa Scout indossano la stessa uniforme dei castorini. I Capi e i Rovers indossano l'uniforme Associativa. L’uniforme dei castorini è definita dal Regolamento generale ARCISCOUT. |
La terminologia utilizzata nella vita di branca è ispirata alla vita del castoro (animale) e si inserisce nell’ambientazione del bosco.
L’ambientazione del bosco si presta efficacemente all’inserimento di personaggi fantastici come fate, folletti e gnomi, che possono essere utilizzati per arricchire i giochi ed i racconti.
Si è scelto il castoro in quanto animale laborioso e socievole che vive in comunità.
La limitazione di 5 bambini per ogni adulto è data dalla necessità di assicurare una formazione il più possibile personalizzata dei bambini.
Il Capo Colonia non va contato nel determinare il numero di castorini, per cui, ad esempio una Colonia di 15 bambini richiederà la presenza di 3 aiuto capo (15 diviso 5) più il capo colonia.
Tra i bambini non esiste alcuna gerarchia, né la figura di “capo capanna” . Ogni aiuto capo avrà in “custodia” una delle capanne in modo da poter concentrare la propria attenzione su un gruppetto ridotto di bambini.
La figura del Capo Colonia, nel nostro metodo, è centrale. Egli assume il nome di “DOC” il castoro saggio. Ad esso si affiancano, assumendo nomi di fantasia ispirati all’ambiente bosco (nomi di alberi, di gnomi, di folletti o di fate) gli altri componenti della staff capi. Spetta a DOC chiamare il cerchio presiedere alle celebrazioni e organizzare, agli occhi dei castorini, la vita di colonia.
Il regolamento prevede la possibilità di inserire, a fianco dei Capi e dei Rovers, degli adulti, preferibilmente genitori (che non abbiano i figli nella colonia stessa), i quali assumeranno il ruolo di aiuti capo a fianco dei Capi o dei Rovers presenti in colonia, e collaboreranno con il Capo Colonia nella progettazione e nella realizzazione delle attività. Il Capo Colonia e gli aiuti capo formano la staff di colonia.
Gli adulti impegnati in tale ruolo dovranno
conoscere il metodo castorini e partecipare al “gioco” con lo spirito proprio
di ogni Capo Scout. La formazione metodologica degli adulti non scout presenti
in Colonia è affidata al Capo Colonia.
4. Il distintivo di Branca
è quello di seguito riportato e va cucito sull'uniforme all'altezza
del cuore.
 5. Il distintivo di Capanna è costituito da un quadrato di stoffa di lato 4-5 cm. sul quale è disegnato il frutto che rappresenta la Capanna e va cucito sulla spalla destra. |
Particolare importanza va data all’uniforme la quale dovrà essere indossata con cura sia dai Capi e Rovers, sia dai castorini e adulti in servizio. L’uniforme, nel metodo Scout, rappresenta l'appartenenza al gruppo, essa non è solo un segno esteriore ma anche uno strumento educativo in quanto pone tutti i bambini sullo stesso piano e, al tempo stesso, è studiata per permettere al bambino ampia libertà di movimento senza la paura di “rovinare” gli abiti.
E’ bene ricordare di tanto in tanto ai genitori e agli stessi bambini che all’attività si arriva con l’uniforme e senza portare con sé cose inutili all’attività che rischiano solo di creare confusione tra i castorini.
Il distintivo dei castorini è costituito da un castoro marrone posto sopra un triangolo verde e all’interno di un cerchio blu dove è riportata la scritta “ARCISCOUT”. I tre colori: marrone, verde e azzurro, rappresentano l’ambiente del bosco: l’azzurro dell’acqua e del cielo, il verde degli alberi e il marrone dei castori.
Il fazzolettone che i castorini e gli adulti non scout in servizio indosseranno sarà di colore azzurro (uguale per tutte le colonie dell’Associazione) con le bandine dei colori del gruppo di appartenenza.
La capanna rappresenta nel metodo castorini
uno strumento “logistico” per consentire una facile conduzione della Colonia.
Ogni capanna si compone di un massimo cinque o sei bambini e assume
il nome di un frutto del bosco. Le capanne comprendono bambini di età
eterogenea. Il distintivo di capanna sarà realizzato dalla staff
capi della Colonia, disegnando su quadrati di stoffa di 4-5 cm il frutto
da cui prende nome la capanna. La stoffa può essere di qualunque
colore, purché uguale per tutte le capanne all’interno della medesima
colonia.
| 6. La progressione personale si
basa esclusivamente sull'età anagrafica ed è rappresentata
dal colore della coda di castoro in panno secondo la seguente tabella:
- coda gialla fino ai 6 anni - coda arancione da 6 anni a 6 anni e mezzo - coda rossa da 6 anni e mezzo a 7 anni - coda marrone da 7 anni a 7 anni e mezzo - coda nera dai 7 anni e mezzo all'entrata in branco 7. All'ingresso in Colonia i bambini assumono il nome di "Cuccioli". Dopo un breve periodo di prova i Cuccioli sono invitati a pronunciare, davanti al Capo Colonia, il Patto, con il quale essi comunicano a tutta la Colonia il desiderio di farne parte. Il Patto è così codificato: "DESIDERO ESSERE UN BUON CASTORINO E RISPETTARE LE REGOLE DELLA COLONIA". Il castorino che ha pronunciato il Patto riceve il Capellino, il distintivo di Branca, la coda corrispondente all’età ed il fazzolettone dei castorini. Prima del Patto i Castorini possono indossare l'uniforme con il distintivo di Capanna, ma priva di fazzolettone, della coda e di distintivo di Branca. |

fino ai 6 anni |

6 anni - 6 anni e mezzo |

6 anni e mezzo - 7 anni |

7 anni - 7 anni e mezzo |

7 anni e mezzo in poi |
Il cambio della coda rappresenta per il
bambino un segno tangibile della propria crescita nella colonia. Man mano
che il castorino cresce, sarà cura della staff capi richiedere al
castorino un sempre maggiore impegno. Possiamo determinare, in questo senso,
nel cammino del castorino una serie di tappe, contraddistinte da particolari
verbi, che possono così essere riassunte:
Il Patto dei castorini esprime non tanto una promessa, ma un desiderio. Esso sarà ripetuto ad ogni cambio di coda.
Le Regole, il Saluto
e il Motto
| 8. Le "Regole della Colonia" sono
così codificate:
- Il castorino è felice assieme agli altri - Il castorino gioca, canta, lavora e rispetta la natura. 9. Il Saluto dei castorini:
10. Il Motto
|
Le regole della colonia più che “imporre” un certo comportamento, tendono a mettere in evidenza il “clima” che deve crearsi all’interno della colonia basato sull’idea che i castorini imparano a fare ogni cosa insieme.

LA CHIAMATA AL CERCHIO
La chiamata al cerchio viene fatta dal
Capo Colonia all’apertura delle attività e ogni qualvolta essa sia
necessaria per comunicare qualcosa ai castorini (ad esempio al passaggio
da una attività all’altra, per la spiegazione di un gioco, ecc.).
Il Capo Colonia emette un fischio prolungato con un fischietto bitonale per richiamare i castorini all’attenzione, dopo di che lancia il richiamo “CASTO-CASTORINI”. I castorini rispondono correndo verso il capo colonia e disponendosi in cerchio, tenendosi per mano (incrociando le mani), secondo il disegno sotto indicato.

I castorini si disporranno, raggruppati per capanna e intervallati da un aiuto capo. Al centro del cerchio sarà posto il Grande Castoro Marrone, un pupazzo a forma di castoro utilizzato come “totem” della colonia.
Conclusa la disposizione in cerchio il capo colonia griderà “CASTORINI” e i castorini all’unisono risponderanno “CRUNK” liberando le mani. Se si tratta del cerchio di inizio attività, il capo colonia rivolgerà alla colonia il saluto dei castori ed essa risponderà al saluto.
Per chiudere il cerchio (alla fine delle attività) il Capo Colonia grida "“CASTORI” e i castorini rispondono “CRUNK”, il Capo Colonia allora continua “CASTORI BIM-BUM” e i castorini battendo le mani simulando il suono della coda di castoro che batte, rispondono “CIAK”
I “COMANDI” (da utilizzare durante il cerchio):
Per far sedere i castorini:
COLONIA GIU’: tutta la colonia si metterà
in posizione seduta
Per far alzare in piedi i castorini:
CASTORI TUTTI …: i castorini risponderanno
“INSIEME” e si alzeranno di scatto rimanendo in cerchio
Per richiamare il silenzio:
Il capo Colonia alza l’indice della mano
destra e attende che tutti i castorini in silenzio facciano altrettanto,
oppure, se è il caso, grida forte “CASTORI” e i castorini rispondono
assieme “CRUNK” e poi si mettono in silenzio.
IL PATTO
Il Patto viene fatto dopo 1 o 2 mesi dall’ingresso
in Colonia.
Il Capo Colonia chiama il Cerchio e dopo
aver spiegato cosa si sta facendo, chiama ad uno ad uno i cuccioli, iniziando
con quelli più giovani.
Il castorino chiamato si presenta davanti
a DOC tenendo in braccio (a sinistra) il Grande Castoro Marrone e facendo
con la mano destra il saluto dei castorini. Assieme a DOC pronuncia la
formula del Patto e, a quel punto, DOC gli consegna il fazzolettone delle
colonia, la coda relativa all’età, il capellino associativo,
e gli appunta il distintivo di branca.
DOC saluta il nuovo castorino il quale
si gira verso il cerchio e saluta tutta la Colonia, la quale risponde al
saluto. Il castorino riprende il suo posto in cerchio.
IL CAMBIO DELLE CODE
Il cambio delle code va fatto due volte
all’anno: in ottobre (alla ripresa delle attività) e in primavera
(possibilmente durante un’uscita).
Il Capo Colonia chiama il Cerchio, ricorda
il senso del cambio della coda, e poi chiama ad uno ad uno i castorini,
iniziando con quelli più giovani.
Il castorino chiamato si presenta davanti
a DOC tenendo in braccio (a sinistra) il Grande Castoro Marrone e facendo
con la mano destra il saluto dei castorini. Assieme a DOC ripete la formula
del Patto e infine DOC toglie la vecchia coda e la sostituisce con la nuova,
rispondendo al saluto.
Il castorino riprende il suo posto in
cerchio.
E’ possibile svolgere contemporaneamente le cerimonie del Patto e del Cambio delle code in un'unica cerimonia: prima cambiano le code i castorini che hanno già fatto il Patto e di seguito fanno il Patto i nuovi cuccioli.
IL PASSAGGIO AL BRANCO
Il passaggio al Branco delle Code Nere
va preparato anzitempo, invitando, nelle riunioni precedenti il passaggio,
i Capi delle sestiglie del Branco Lupetti che accoglieranno i castorini
passanti, ad incontrare i castorini nel “Consiglio delle Code Nere”. Esso
sarà composto da DOC, Akela, le Code Nere e i Capi Sestiglia. In
questa occasione i Capi Sestiglia prenderanno il nome di “Keeo” e dovranno
raccontare ai castorini la storia di Keeo e della notte magica:
Keeo era un vecchio castoro dalla coda nera che viveva nella colonia situata vicino al Grande Fiume che divideva il Bosco dei Castori dalla Jungla. Spesso, di notte, Keeo usciva in esplorazione. Una notte avvicinandosi al Grande Fiume si accorse che sulla riva opposta si vedevano degli strani animali dagli occhi lucenti. La notte non prometteva nulla di buono, infatti stava per arrivare un gran brutto temporale e il Grande Fiume era già in piena da alcuni giorni e la corrente era fortissima. Tuttavia Keeo decise di sfidare il Grande Fiume per conoscere gli animali che si trovavano dalla parte opposta, e utilizzando un vecchio tronco come imbarcazione, iniziò la traversata del Grande Fiume. Arrivato al centro, dove la corrente era più forte, iniziò a piovere e i fulmini solcarono il cielo. Improvvisamente una grande luce lo avvolse ed egli credette di essere stato colpito da un fulmine, ma subito dopo si accorse che era accaduta una cosa molto strana: sentiva chiaramente la voce degli animali che erano presenti lungo l’altra riva e quelli che prima sembravano ululati senza senso, ora diventavano voci comprensibili: “forza fratello”, gridavano, “nuota più veloce che puoi”. Keeo si guardò e con meraviglia scoprì che il suo pelo e la sua coda erano cambiati, non assomigliava più ai fratellini della colonia, ma era diventato simile agli animali che si trovavano dall’altra parte del Grande Fiume. Nuotò con forza verso la riva, vincendo la corrente e giunse dall’altra parte, dove i Lupi gli corsero incontro e gli dissero: “benvenuto, fratello, tra il popolo libero che vive seguendo la Legge della Jungla, seguici.”. E lo portarono, tra la Jungla, fino ad arrivare ad un’alta rupe, dove lo attendeva un lupo anziano.
Aiutati da DOC i castorini rivolgeranno ad Akela ed ai Keeo varie domande sulla vita del Branco, sulla sua Legge, le sue abitudini, ecc.
Il giorno del passaggio (la “Grande Nuotata”) Akela chiamerà il cerchio dei Lupi poco distante da dove si trova la Colonia. Tra la Colonia e il Branco verrà steso un telo azzurro di nylon. I castorini, salvo le code nere, si disporranno lungo i bordi più lunghi del telo e lo solleveranno mentre DOC e le code nere saranno disposti in riga lungo uno dei due bordi corti e il cerchio dei Lupi si troverà dall’altra parte (vedi disegno).
Akela chiamerà i Keeo e li inviterà a risalire il fiume ed a prendere con loro le code nere. I castorini agiteranno il telo mentre i Keeo passeranno sotto fino a “riemergere” dalla parte dove si trovano DOC e le code nere. Presentandosi davanti a DOC, gli faranno il saluto dei Lupi ed egli risponderà con lo stesso saluto. Poi chiederanno di poter portare con loro nella grande nuotata le code nere. DOC, rivolgendosi alle code nere chiederà loro se vogliano andare ed essi risponderanno di si. DOC dunque saluterà con il saluto dei castori le code nere e le affiderà ai Keeo.
Le code nere e i Keeo ripasseranno sotto il telo (continuamente mosso dai castorini) e quando si troveranno al centro, i Keeo aiuteranno le code nere a togliersi il fazzolettone, la coda e l’uniforme dei castori e a mettere il maglione verde dei lupi, il fazzolettone dei cuccioli di lupo e il cappellino. Il nuovo cucciolo e Keeo usciranno dalla parte del Branco e prenderanno posto nella sestiglia. Alla fine il Branco si ritirerà per presentare i nuovi cuccioli ad Akela.