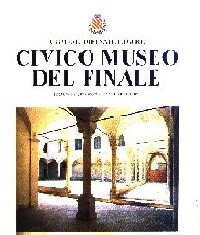23 febbraio 2000:
visita al museo di Finale.
Con la nostra classe, guidati dal professore Giacomo Bajada, siamo andati a visitare il Museo Civico di Finale Ligure per approfondire il nostro studio sulla vita dei nostri antenati.
Il museo era suddiviso in cinque sale, nelle quali erano illustrati i vari periodi storici, a partire dalla preistoria fino al Medioevo, raggruppando i materiali per oggetti e periodi.
Nella prima sala erano riportate le caratteristiche e la formazione del territorio finalese.
Si tratta di un paesaggio molto particolare: territori pietrosi e aridi, bucherellati da crateri, con vaste conche a forma di scodella, le doline, nel cui fondo l’acqua sembra scomparire improvvisamente. Sotto terra, invece, un mondo spettacolare: grotte, grandi cavità, lunghi fiumi e vasti laghi. È il cosiddetto paesaggio carsico, chiamato così perché è stato studiato per la prima volta proprio nel Carso, zona nel Friuli Venezia Giulia. Il paesaggio carsico è originato dall’azione di dissoluzione che l’acqua compie su rocce di tipo calcareo, quelle più “tenere” e friabili. L’acqua è capace di “sciogliere” anche 10 cm di roccia ogni mille anni. Sembra un’inezia, ma è sufficiente per scavare lunghi solchi nella roccia, allargandone le fessure fino a quando l’acqua riesce a scomparire sotto terra dove si raccoglie in vasti bacini o scorre per riemergere anche molti chilometri più in là.
Sulla costa si trovano le Arene Candide: rocce bianche, friabili, morbide, ricche di fossili; infatti nell’età arcaica il territorio finalese era sommerso dalle acque marine.
Osservando queste rocce possiamo ricostruire i climi che hanno caratterizzato determinati periodi storici, infatti sono stratificate.
I fiumi hanno portato a valle i detriti che si sono accumulati sul fondo del mare e quindi compressi e cementati. Quando il mare si è ritirato sono emerse queste rocce a strati, ricche di fossili, tipici di un determinato periodo, facendoci capire l’alternanza dei climi antichi: freddi umidi per certi mammiferi e certe piante, caldi per altri.
Nella seconda stanza, erano riportati oggetti del paleolitico di uso comune: anfore, coltelli, ciotole di pietra, tipici dell’età della pietra.
Altri fossili che ci sono rimasti impressi sono i denti di topo, le ossa di un orso.
Nella terza stanza c’erano tombe appartenenti a vari periodi: nel paleolitico: c’era l’uso di mettere i cadaveri supini (posizione eretta con mani lungo i fianchi a pancia in su); nel neolitico i cadaveri venivano sepolti rannicchiati, posizione che simboleggia il feto nel grembo materno.
Ricordiamo una donna morta, che non è sopravvissuta al parto, con il bambino in grembo; un ragazzo di circa venticinque anni con il cranio fracassato a causa di un sasso; un ragazzo di quindici anni, intorno al quale erano state poste pietre come tomba. Tutti i cadaveri del paleolitico e del neolitico venivano spalmati di polveri ocra e rosse.
Nella quarta stanza c’erano i romani in divisa, pronti a combattere per farci fuori!
C’era una grande tomba bianca romana con ornamenti maestosi, ricordiamo una giara utilizzata per contenere il vino e l’olio, un’anfora ormai deteriorata, le postate in metallo: forchette, cucchiai, coltelli. C’erano anche ampolle fatte di vetro sottilissimo e bellissimi monili romani.
Nella quinta sala c’erano le monete di tutti i periodi: dai romani al Medioevo.
Andrea, Lara e Sara.