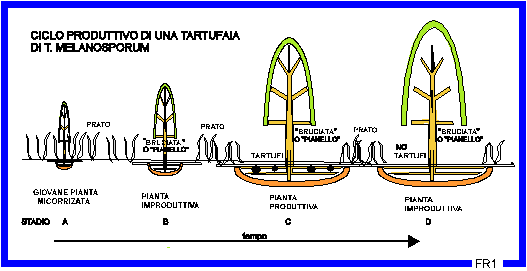 |
Vedi la figura - view of the picture
La
gestione delle tartufaie
artificiali
Associazione Nazionale
Conduttori Tartufaie, Aqualagna (PS)
E-mail: harald_letizi@libero.it
Articolo
presentato per il Convegno sul tartufo tenutosi a Camerino il 27/1/2001
1 - Aspetti generali
La
tartuficoltura è effettuata attualmente con l’impianto in ambiente vocato di
semenzali micorrizati in vivaio, cioè in condizione di simbiosi tra pianta e
tartufo. Nelle Marche è iniziata negli anni ’50 con la roverella (Quercus
pubescens Willd.) in simbiosi con T.
melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato di Norcia e del Périgord). Si è
espansa molto negli anni ’80 e ’90 raggiungendo oggi una superficie stimata
di circa 2000 ha., pari alla superficie attualmente coltivata a tartufi in
Spagna (Estrada, 1999). I risultati non sono sempre soddisfacenti, tuttavia sono
più che incoraggianti con il T.
melanosporum Vitt (Letizi, 1998).
I risultati produttivi sono interessanti anche con lo
scorzone o tartufo nero di Borgogna (T.
aestivum subsp. uncinatum Fischer, o T.
uncinatum Chat.), il nero di campo (T.
brumale Vitt.) ed il bianchetto (T.
albidum Pico). Queste specie, meno pregiate delle altre, hanno dato
risultati incoraggianti in alcune tartufaie sperimentali, ma non sono ancora
coltivate su larga scala. Esiste però poco interesse economico per farlo, perchè
il prezzo è minore ed il mercato meno ampio rispetto alle specie più pregiate.
Il T. brumale Vitt., tuttavia, è
prodotto come tartufo indesiderato in tartufaie impiantate con piante inoculate
con T. melanosporum Vitt. e
contribuisce positivamente al conseguimento del reddito dell’agricoltore
(Letizi, 1998; Letizi e al, 1999). Sporadici e occasionali sono i risultati
produttivi con il tartufo bianco pregiato in tartufaie artificiali (Giovannetti,
1988; Vignozzi e Mazzei 1992; Letizi, 1998; Letizi, 1999; Letizi e al., 1999).
I
fattori principali che ne influenzano la coltivazione sono: 1) specie vegetale e
di tartufo utilizzate, 2) ambiente pedoclimatico, 3) cure agronomiche apportate,
4) competizione di altri funghi e tartufi indigeni.
Il
ciclo produttivo della tartufaia è il seguente: una fase improduttiva iniziale
(quando le piante micorrizate sono ancora “giovani”); una fase produttiva di
corpi fruttiferi; una fase di declino e perdita delle produzioni (nonostante la
vita delle piante micorrizate continui). La durata di queste tre fasi varia
all’interno della stessa tartufaia con piante nelle medesime condizioni.
Esiste sfasamento produttivo per le piante micorrizate, cioè le piante non
entrano in produzione tutte insieme e non smettono contemporaneamente. Alcune
piante micorrizate non producono tartufo neanche dopo molti anni. La
fruttificazione cessa senza apparente rimedio, nonostante la vita della pianta
simbionte continui (fig. 1).
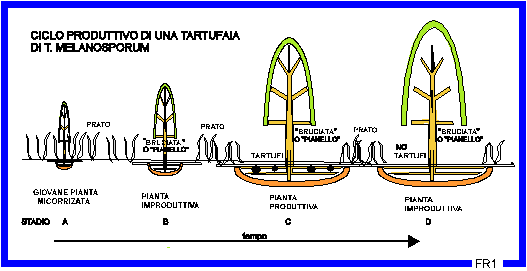
Vedi la figura - view of the picture
Fig.
1 – Modello di ciclo produttivo di una tartufaia artificiale. Nell’esempio
si considera in particolare il T.
melanosporum Vitt., con la tipica inibizione delle specie erbacee del prato
detta “bruciata” o “pianello”. I diversi stadi indicano quindi: A –
pianta micorrizata con T. melanosporum
Vitt; B – pianta micorrizata in stadio improduttivo che manifesta già la
“bruciata” o “pianello”; C – pianta in produzione con T.
melanosporum Vitt.; D – pianta che ha smesso di produrre T.
melanosporum Vitt. Lo stadio D può anche essere caratterizzato da
produzione di tartufi di altre specie. La bruciata non è necessariamente legata
alla produzione di tartufo, quindi può essere ancora evidente allo stadio D
oppure perdere la sua evidenza.
Durante
il ciclo produttivo della tartufaia esistono oscillazioni annuali delle
produzioni, legate anche all’andamento climatico. Quest’ultimo infatti
condiziona fortemente le produzioni di tartufo e quindi gli operatori sono
ricorsi all’irrigazione d’emergenza per far fronte alle estati
eccessivamente siccitose.
Tra
le caratteristiche intrinseche alla coltivazione di funghi ectomicorrizici quali
sono i tartufi, c’é la possibilità di inquinamento da parte di funghi o
tartufi locali indesiderati (fig. 2). Questo accade perchè
le radici in espansione non sono micorrizate e così possono essere inoculate
anche da spore di tartufi o funghi indesiderati presenti nel terreno sotto forma
di spore o micelio. Tali funghi competitori sono più virulenti quanto
meno l’ambiente è adatto al tartufo coltivato e quanto più è al termine la
fase produttiva. Tale fase è infatti riferita alla specie coltivata, ma può
anche essere seguita da una fase produttiva di una specie indesiderata. Il
declino della tartufaia è da imputarsi soprattutto all’ossidazione della
sostanza organica e alla stanchezza del suolo verso quella specie di fungo
(Zucconi e Letizi, 1998). Il recupero di tartufaie in declino, con potature di
arieggiamento, dà risultati sono momentanei e durano al massimo quattro-cinque
anni (Sourzat e al., 1981).

Fig.
2 – Specie prodotte da un campione di quaranta tartufaie marchigiane inoculate
con T. melanosporum Vitt. Le specie di
tartufo prodotte (T. melanosporum, T.
melanosporum + altre specie, altre specie) sono confrontate con le tartufaie
improduttive (nessuna specie). Le altre specie prodotte sono T.
albidum, T. brumale, T. aestivum, T. mesentericum. Le tartufaie che
producono solamente altre specie sono in realtà in produzione solo con T. brumale. La percentuale di tartufaie improduttive è elevata a
causa della presenza nel campione di tartufaie ancora “giovani” (da Letizi,
1999).
L’epoca di entrata in produzione del T. melansporum Vitt è anticipata da una elevata velocità di sviluppo
vegetativo della pianta simbionte, da specie vegetali arbustive e da andamenti
climatici favorevoli. Lo sviluppo vegetativo è a sua volta accelerato dalle
cure agronomiche e da un ambiente favorevole, quest’ultimo inteso come
ecosistema e andamento climatico. L’andamento climatico influenza inoltre la
fruttificazione del tartufo e quindi l’annata favorevole alle produzioni di
tartufi è una condizione importante perché la tartufaia, in condizioni di
sviluppo vegetativo sufficienti, inizi a produrre (fig. 3). E’ quindi evidente
l’influenza dello stato fisiologico della pianta simbionte, che entra in
produzione prima in situazioni che favoriscono il suo sviluppo vegetativo e
s’interrompe quando la pianta ha una stasi vegetativa.

Fig. 3 – Albero logico dell’inizio della produzione di
tartufo (da Letizi e al. 1999).
Velocità di sviluppo vegetale
Le
cure agronomiche che portano ad un maggiore sviluppo vegetativo della pianta
ospite sono quelle che favoriscono l’anticipo della fase produttiva. Questo è
stato osservato in campo su un campione di 32 tartufaie marchigiane. In base
alla capacità di crescita della data specie vegetale e l’età e le dimensioni
raggiunte è stato aggiudicato un grado di sviluppo (min 1 e max 4).
Parallelamente le cure agronomiche hanno influito positivamente sulla entrata in
produzione della tartufaia. In sintesi le cure agronomiche hanno logicamente
favorito lo sviluppo vegetale e queste condizioni hanno stimolato le piante
micorrizate ad iniziare la produzione di carpofori (da Letizi e al. 1999, fig. 4
e 5).
E’
significativo che la roverella alla quale sono state eseguite cure agronomiche
è capace di iniziare una produzione al quinto anno, mentre senza cure
agronomiche questa slitta nel migliore dei casi all’undicesimo anno (fig. 6 e
7).

Vedi la figura - view of the picture
Fig.
4 – Influenza delle cure agronomiche sullo sviluppo vegetativo della pianta
ospite. La correlazione mostrata è tra il grado di sviluppo delle piante ospiti
osservate e la % di impianti in cui si praticano cure agronomiche all’interno
della popolazione di tartufaie con il medesimo grado di sviluppo vegetale (da
Letizi e al. 1999).

Vedi
la figura - view of the picture
Fig.
5 – Correlazione tra grado di sviluppo della pianta ospite ed età media di
entrata in produzione della tartufaia (da Letizi e al. 1999).

Fig.
6 – Influenza delle cure agronomiche sull’epoca di entrata in produzione
delle tartufaie di T. melanosporum in
simbiosi con roverella (da Letizi e al. 1999).

Vedi la figura - view of the picture
Fig.
7 – Influenza delle cure agronomiche sull’entrata in produzione della
roverella micorrizata con T. melanosporum
Vitt. Le tartufaie possono ricevere più di una cura contemporaneamente. Le
percentuali sono calcolate su 22 casi per le lavorazioni superficiali, 12 casi
per lo sfascio e trinciatura, 3 dati per la pacciamatura, 9 dati per
l’irrigazione, 10 dati no cure o nessuna cura agronomica (da Letizi e al,
1999).
L’ambiente influenza spesso in maniera determinante il successo della
coltivazione e l’epoca di entrata in produzione. Per il tartufo nero pregiato
sono caratteristici, nella regione Marche, terreni ben drenati calcarei, sassosi
o sabbiosi, spesso in pendenza e con esposizione a sud. Le tartufaie artificiali
con questo tartufo hanno ottenuto risultati sia in aree in cui era già presente
allo stato spontaneo, sia in aree in cui non si raccoglieva spontaneo. I terreni
sabbiosi sono tendenzialmente favoriti per anticipare la produzione. Infatti
l’epoca di entrata in produzione è accelerata quando l’ambiente, favorevole
al T. melanosporum Vitt., permette
anche una rapida crescita delle piante micorrizate. I terreni sabbiosi
permettono l’approfondimento radicale e la possibilità di accedere a riserve
d’acqua durante i periodi siccitosi. Al contrario i terreni ciottolosi molto
superficiali, in cui lo strato roccioso si trova a dieci-quindici centimetri di
profondità, rendono estremamente lenta la crescita vegetale. In alcuni casi si
possono verificare anche dannosi ristagni idrici quando si non hanno pendenze e
la roccia sottostante non drena.
L’andamento climatico influenza l’inizio della fruttificazione agendo
sullo sviluppo vegetativo della pianta simbionte e sull’annata favorevole alla
produzione di tartufo. Infatti se la tartufaia può essere in grado di produrre
tartufi, ma l’andamento climatico è sfavorevole ad esso, la fruttificazione
è ritardata alle annate favorevoli successive. Nel 1996 il T. melanosporum Vitt. ha dato ottime rese nelle Marche e ciò ha
coinciso con la prima produzione di tartufaie di diversa età (fig. 8). Questo
è avvenuto anche per tre tartufaie in condizioni simili (roverelle nello stesso
ambiente) entrate in produzione lo stesso anno nonostante una differenza di età
di tre e cinque anni. E’ da sottolineare, inoltre, che la dimensione delle
piante era piuttosto simile a causa degli stress ambientali subiti dalle più
anziane.

Fig.
8 – Età di entrata in produzione della roverella micorrizata con T.
melanosporum Vitt. in funzione dell’annata. Ogni punto corrisponde ad un
caso. Tartufaie simili, ma con differenze di età fino a dieci anni, entrano in
produzione nella stessa annata. Le frecce indicano due annate particolarmente
favorevoli: il 1994 ed il 1996 (da Letizi e al, 1999).
Specie vegetali simbionti di mole inferiore generalmente anticipano la messa
a frutto della tartufaia. La specie più precoce e di mole inferiore é il cisto
(Cistus incanus L.) e quella più
tardiva e di mole maggiore è la
quercia (Quercus spp.). Il cisto è a volte produttivo al secondo anno, nocciolo
(Corylus avellana L.) al terzo, il
carpino nero (Ostrya carpinifolia L.)
al quarto anno e la roverella (Quercus
pubescent Villd.) al quinto. Tuttavia le specie più precoci entrano
comunque in produzione per la gran parte dopo cinque-sette anni e con quantità
generalmente inferiori alla quercia. Inoltre la fase produttiva della tartufaia
è migliore con la quercia (Quercus
spp.), grazie alla sua capacità di esplorazione e colonizzazione del terreno.
Questa è la specie vegetale più utilizzata in simbiosi con il T.
melanosporum Vitt. e con maggiore successo produttivo. La quercia, quindi,
se ben gestita nel suo sviluppo vegetale, è ancora la migliore scelta per una
tartufaia di T. melanosporum Vitt., sebbene siano interessanti consociazioni con
le specie vegetali simbionti arbustive.
3 – CONSIGLI PRATICI SULL’IMPIANTO E LA GESTIONE
DELLA TARTUFAIA DI T. MELANOSPORUM
Le piante micorrizate in vivaio costano dalle dieci alle
trentamila lire, a seconda si tratti di vivai pubblici o privati. Non esistono
certificati o promesse che giustifichino prezzi maggiori.
La presenza spontanea della specie di tartufo che
intendiamo coltivare è un ottimo indice di vocazionalità dell’ambiente,
sebbene non sia discriminante. Il terreno va preparato preferibilmente con una
rippatura ed una lavorazione superficiale (erpicatura) per preparare il terreno
ad ospitare la pianta micorrizata. L’aratura profonda per operare lo scasso
del terreno è sconsigliata in quanto riduce la fertilità superficiale del
terreno ed anche la velocità di crescita della pianta micorrizata. La
dimensione della buca per piantare la pianta micorrizata è limitata al volume
del pane di terra (circa un litro). L’impianto viene effettuato a fine autunno
o durante l’inverno, per far sì che le piante colonizzino il terreno con le
loro radici e non abbiano richiesta idrica dalla traspirazione.
Il sesto d’impianto deve tener conto della dimensione
da adulte delle specie vegetali messe a mimora: generalmente la quercia si
pianta a otto-dieci metri di distanza ed il nocciolo a quattro-cinque. Tenendo
conto che il nocciolo ha una vita di pochi anni rispetto alla quercia, si
possono alternare querce e noccioli sulla fila con sesto d’impianto di quattro
metri per quattro ed avere i noccioli a fine ciclo vitale quando le querce sono
diventate molto grandi. Il nocciolo, inoltre, necessita di terreni con uno
strato colonizzabile di almeno 50 cm per vivere bene e capita spesso che non
riesca ad adattarsi a certe aree marchigiane in cui è stato impiantato. Al
contrario le querce sono estremamente adattabili e capaci di produrre tartufi in
condizioni poco favorevoli.
Lo sviluppo vegetale accelera e la produzione di tartufi
si anticipa riducendo la competizione con le erbe e fornendo nutrienti ed acqua.
In pratica si zappetta o sarchia in superficie il terreno intorno alle piante
micorrizate, si irriga nelle annate molto siccitose, si effettua la pacciamatura
con materiale poroso, si apporta compost o letame molto umificati. Non si hanno
al momento studi sufficientemente approfonditi sull’utilizzo adeguato di
concimi chimici. Eccessi di lavorazioni o di umidità del terreno aumentano i
rischi di perdita delle produzioni di T. melanosporum Vitt.. Questo avviene spesso a favore di tartufi
meno pregiati, tipici di terreni umidi e lavorati.
La zappatura vicino alla pianta è consigliata per i
primi due-tre anni e poi può continuare all'esterno del pianello che si forma,
in modo da favorire l'espansione radicale e di conseguenza del micelio del
tartufo (fig. 9). Eccessive lavorazioni del pianello possono infatti risultare
dannose.

Fig. 9 – Modello di conduzione della zappatura della
tartufaia di T. melanosporum Vitt. e
influenza delle cure agronomiche sull’entrata in produzione e l’esplorazione
radicale. CA rappresenza la cavità non assorbente dell’apparato radicale e CO
la corona o zona assorbente (da Letizi 1997).
Il tartufo opera nel pianello una ossidazione accelerata
della sostanza organica. Quindi l’apporto di compost ben umificato è
generalmente positivo, a condizione che questo non contenga sostanze tossiche o
sia poco maturo. L’influenza è positiva sia sull’anticipo della messa a
frutto, grazie al maggiore sviluppo vegetale ottenibile, sulla produzione,
grazie al maggiore substrato da attaccare, sulla longevità, grazie al rinnovo
del substrato e della “nicchia” di suolo. L’apporto è consigliato
localizzato intorno alla pianta micorrizata e sopra il pianello che si forma,
magari interrandolo nei primi due-tre centimentri. Quantità sperimentate con
successo vanno da un chilogrammo fino a tre chili per metro quadrato di pianello
all’anno. L’epoca migliore per l’esecuzione è subito dopo la fine della
raccolta di tartufo, in Marzo. Per proteggersi da rischi eccessivi, lo si può
apportare su una frazione del pianello, lasciando così un testimone non
ammendato. Positiva è inoltre la presenza di piante erbecee o arbustive nel
pianello: la lupinella, il rovo, la ginestra tendono ad incrementare le rese e
la vita della tartufaia. Un tipo di sostanza organica poco favorevole per il
tartufo e per la pianta ospite è costituito dal pacciame di foglie che può
formarsi dalla pianta ospite stessa. La gestione della tartufaia deve quindi
evitare che si formi uno strato marcescente di foglie sui pianelli.
L’irrigazione del pianello è positiva quando evita
eccessivi stress idrici estivi. Questo fattore incide positivamente in quanto
riduce l’incertezza derivante dall’andamento climatico. Lunghi periodi di
caldo torrido in estate possono distruggere tutti gli abbozzi di corpi
fruttiferi formatisi in primavera, riducendo drasticamente le produzioni. Non
esiste, però, una ricetta sull’irrigazione che sia efficace in tutte le
condizioni e gli studi sono decisamente incerti. Eccessi d’irrigazione,
inoltre, potrebbero favorire tartufi competitori più adatti alle condizioni di
terreno umido.
La pacciamatura non è molto utilizzata ed ha
generalmente la stessa funzione dell’irrigazione. I materiali usati vanno
dalla paglia ai tessuti non tessuti, ai sacchetti in rete pieni di argilla
espansa. I film plastici possono essere molto dannosi per i pianelli, ma
talvolta vengono utilizzati fuori da essi per favorire la loro espansione.
La formazione di erbe all’interno del pianello non è
in sé dannosa, anzi da un positivo apporto di sostanza organica e favorisce il
mantenimento di una struttura porosa del terreno. Può essere però sintomo di
riduzione dell’inibizione verso le erbe dato da invecchiamento della
tartufaia, specialmente quando si sviluppino evidenti le graminacee. Questo
significa una di riduzione delle produzioni.
La potatura non è stata ancora studiata in maniera
approfondita, tuttavia si sconsiglia di non sconvolgere l’equilibrio
fisiologico delle piante. Quindi è meglio evitare di fare grossi tagli
invernali e puntare di più, eventualmente, sulla potatura verde (durante la
crescita dei germogli), specialmente se si tratta della spollonatura del
nocciolo.
Molte tartufaie non subiscono cure agronomiche,
specialmente durante la fase produttiva. L’unica attività rimane la raccolta
dei tartufi con il cane, in quanto le erbe e gli arbusti contribuiscono da sole
all’apporto della sostanza organica che viene ossidata dal micelio
all’interno del pianello. Tali tartufaie, sebbene inizino tardi la fase
produttiva, non necessariamente sono meno prolifere e longeve di quelle
lavorate.
Il T. melanosporum Vitt.
induce modificazioni importanti sul terreno, in particolare accelera l’ossidazine
della sostanza organica (Letizi, 1997). Questo influisce sulla durata della fase
produttiva della tartufaia. Tale durata aumenta quando l’ambiente è molto
adatto a questo tartufo, con piante di dotate di grandi capacità esplorative
del terreno (come le querce), con disponibilità di suolo nuovo da sfruttare
grazie alla distanza tra le piante, con presenza di arbusti non simbionti (es.
rovo, ginestra) in vegetazione attiva (grazie a potature) e di erbe resistenti
alla “bruciata” come la lupinella, con l’apporto di humus da letame maturo
o compost umificato (Zucconi e Letizi, 1998).
Si ringrazia della collaborazione gli Enti e le persone che hanno
collaborato a tale ricerca ed in particolare gli agricoltori per la loro
disponibilità e creatività.
Bibliografia
Bei G., Galli A. N., Marini U., Pensalfini
A. 1988 -
Funghi epigei ed ipogei. Ed. Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino, 141 pp.
Bencivenga
M., 1988 - Ecology and cultivation of T.
magnatum Pico. Atti del convegno
Ecology, physiology and cultivation of edible mycorrhizal mushrooms, Uppsala,
Svezia. pubblicato su internet: www.mycopat.slu.se/mycorrhiza/edible/proceed/proc.html
ESTRADA
j. 1999 – La trufficulture espagnole. Seminario durante la “giournè
ouverte” del “Quinto convegno sul tarfufo ed altri funghi commenstibili
ipogei”, Aix en Provence, 6-8 marzo 1999
Giovannetti
G. 1988 - Manuale per la coltivazione del tartufo bianco. Neos
Edizioni, 55 pp.
Gregori
G., 1993 - Tartufi e tartuficoltura nel Veneto. Regione Veneto, 177 pp.
Chevalier G., 1994 - Evolution des rechèrches sur les plants
mycorhizés par la truffe et perspèctives de dévèlopement. Giornale
Botanico Italiano (vol. 128),1, 7-16.
Letizi
H. C, Neri D., 1998 - Dalla micorriza al tartufo. Regione Marche Agricoltura, n° 2, 1998, ed. Giunta Regionale Regione
Marche, 15-20, 40
Letizi
H. C., 1997 - Ecologia della tartufaia. Tesi di laurea in Scienze Agrarie, Università di Ancona, 113 pp.
Letizi
H. C. e Neri D., 1998 - Dalla micorriza al tartufo. Regione Marche Agricoltura, vol. 2 ed. Assessorato della Regione Marche,
23 - 28
Letizi
H. C., 1998 - La produttività delle tartufaie artificiali.
Regione Marche Agricoltura, vol. 4 ed. Assessorato della Regione Marche, 25 –
29
Letizi
H. C., Neri D., Zucconi F., 1998 - Factors regulating T. melanosporum Vitt. cultivation. In ICOM2 (Second International Conference on Mycorrhiza) Uppsala,
Sveden, 5-11/7/98. Atti
del convegno su internet: http://www-icom2.slu.se
lETIZI h. c., 1999 – le aziende tartuficole marchigiane:
aspetti coltivativi, produttivi, evolutivi. Atti del “Quinto congresso
internazionale sul tartufo”, Aix en Provence, Francia, 6-8 marzo 1999.
lETIZI h. c., MARCHETTI A., RINALDINI E., 1999
- Il contributo della ”Associazioone Nazionale Conduttori Tartufaie” (A.C.T.)
di Acqualagna (PS) allo sviluppo della tartuficoltura.
Atti del “Quinto congresso internazionale sul tartufo”, Aix en
Provence, Francia, 6-8 marzo 1999.
Mannozzi-Torini L., 1988 - Il tartufo e la sua coltivazione. Edagricole Bologna, 105 pp.
Santi
S., Gregori G, Pensalfini A., Montesi B. 1995 - Indagine conoscitiva
sulle tartufaie presenti nella provincia di Pesaro. ESAM Pesaro.
Sourzat P., Chevalier G., Duval F., 1981
- Guide pratique de trufficulture. Délégation
départimentale des services d’agronomie du Lot.
Vignozzi
G., Mazzei T., 1992 - Ecologia del tartufo bianco in Toscana.
Osservazioni sulla produttività di una tartufaia sperimentale di T.
magnatum. Atti del terzo congresso internazionale sul tartufo. Tuber. L’Aquila.
Zucconi
F., Letizi H. C., 1998 - Ecophysiology of T. melanosporum Vitt., and impact of allelopathies on duration of
productive sites. In ICOM2 (Second
International Conference on Mycorrhiza) Uppsala, Sveden, 5-11/7/98. Atti del convegno su internet:
http://www-icom2.slu.se