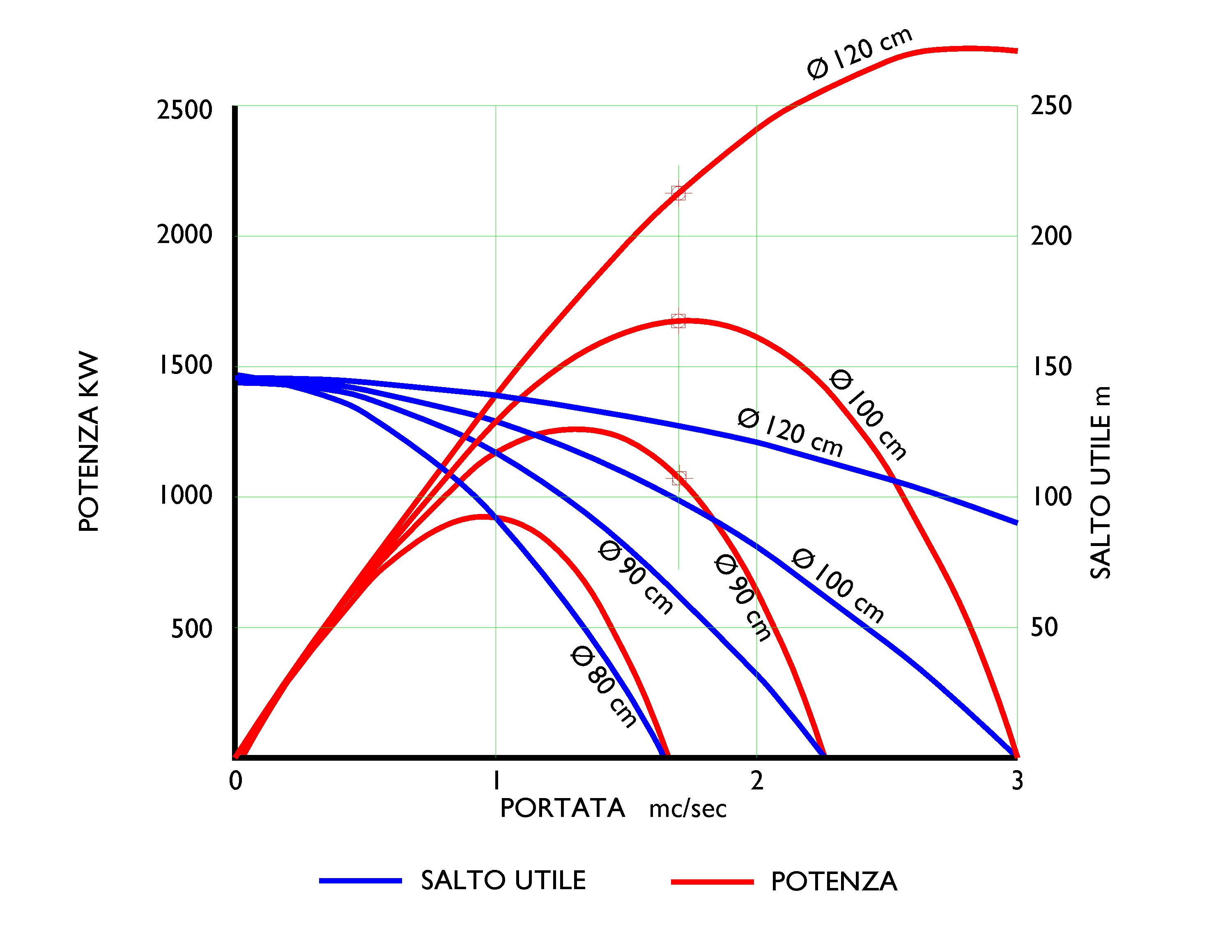L'UTILIZZAZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI
ACQUEDOTTISTICHE FUNZIONANTI A GRAVITA' PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA
Una modalità da non trascurare
per la produzione di energia elettrica dagli acquedotti è
senza dubbio quella inerente lo sfruttamento delle condotte di
adduzione che in molte servizi idrici effettuano il trasporto
di ingenti volumi a notevoli distanze e con dislivelli anch'essi
notevoli. Tipici esempi sono gli acquedotti che vengono alimentati
dai bacini artificiali di alta montagna posti lontano decine di
chilometri e a quote altimetriche di centinaia di metri maggiori
rispetto a quelle di consumo dell'acqua.
Bisogna però rilevare come di norma negli impianti già
realizzati non sussistano, almeno in linea teorica, possibilità
di funzionamento delle macchine di produzione idroelettrica per
il motivo semplicissimo che tutto il carico disponibile all'origine
viene dissipato nel trasporto dell'acqua fino al serbatoio di
arrivo. Ciò dipende dalle modalità correnti di progettazione
delle condotte stesse che, per ovvi motivi di economia nella costituzione
delle opere, prevedono che il carico disponibile sia totalmente
impiegato senza lasciare alcunché disponibile per altri
fini che non siano quelli prettamente acquedottistici.
Per rendere meglio comprensibili i concetti consideriamo l'esempio
di una condotta singola di adduzione del diametro di 80 cm, lunga
Km 10 che deve alimentare, con una portata assolutamente costante
per tutta l'annata tipo di 1,70 mc/sec, un serbatoio posto in
basso e ad un dislivello di circa 150 m esattamente corrispondenti
alle perdite di carico in gioco e quindi con nessun carico residuo.
Per gli scopi qui ricercati di produzione elettrica è necessario
modificare la condotta di adduzione e lo si può fare in
vario modo a seconda dei risultati che si vuole ottenere. Nel
caso si volessero seguire le modalità normalmente in uso
negli impianti idroelettrici si dovrebbe sostituire tale condotta
con un canale a pelo libero che, con una perdita di carico totale
di pochi metri per tutta l'estensione dei 10 Km, consentirebbe
di immettere nel serbatoio la richiesta portata di 1.70 mc/sec
ed al tempo stesso di produrre energia elettrica in notevole quantità
grazie ad un salto utile finale che in tale ipotesi ammonterebbe
a oltre145 metri. Ovviamente si tratta di una soluzione che non
è nemmeno ipotizzabile vista la normale conformazione dei
luoghi. Per ottenere comunque buoni risultati sarà sufficiente
aumentare il diametro, in origine pari a 80 cm sufficienti al
solo trasporto idrico. Ne deriva una struttura che ad una notevole
semplicità costruttiva contrappone complesse modalità
di esercizio con delle incognite di base.
E' ben noto come, al fine dare stabilità e sicurezza all'esercizio,
il salto utile dei normali impianti idroelettrici sia utilizzato
tramite una condotta forzata idraulicamente indipendente dal canale
di adduzione che funziona a pelo libero ed inoltre come sia sempre
presente la vasca di carico o di espansione posta in testa alla
condotta forzata stessa e che contribuisce in tal senso e molto
efficacemente con il notevole volume d'acqua ivi sempre presente.
Le cose sono totalmente diverse e più complesse nel caso
in questione essendo possibile derivare dalla lunga condotta in
pressione indifferentemente grandi portate con carichi esigui
oppure portate modeste con carichi molto elevati, il tutto in
funzione delle modalità di regolazione adottate ma comunque
con pericolo di instabilità di funzionamento.
Per una buona conoscenza del problema viene qui esaminato il comportamento
di una serie di condotte di diametro via via crescente determinando
perdita di carico, carico idraulico disponibile e potenza risultanti
per portate variabili da zero al valore massimo adducibile.
I dati principali sono elencati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate
mentre il diagramma della figura n. 1 riguarda la rappresentazione
grafica dei salti idraulici e della producibilità elettrica
per tubazioni di diametro variabile da 80 cm ad 1,2 m.
TABELLA 1 = DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA
CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL DIAMETRO DI m 0.90
|
DIAMETRO |
PORTATA |
PERDITA CARICO |
VELOCITÀ |
PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |
SALTO UTILE |
POTENZA |
|
M |
MC/SEC |
M/KM |
M/SEC |
M |
M |
KW |
|
0,90 |
0,200 |
0,113 |
0,177 |
1,129 |
43,871 |
287,742 |
|
0,90 |
0,500 |
0,706 |
0,442 |
7,056 |
137,945 |
689,723 |
|
0,90 |
1,000 |
2,822 |
0,884 |
28,222 |
116,778 |
1167,780 |
|
0,90 |
1,500 |
6,350 |
1,326 |
63,500 |
81,501 |
1222,508 |
|
0,90 |
2,000 |
11,289 |
1,768 |
112,888 |
32,112 |
642,240 |
|
0,90 |
2,200 |
13,659 |
1,945 |
136,594 |
8,406 |
184,921 |
TABELLA 2= DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL
DIAMETRO DI m 1.00
|
DIAMETRO |
PORTATA |
PERDITA CARICO |
VELOCITÀ |
PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |
SALTO UTILE |
POTENZA |
|
M |
MC/SEC |
M/KM |
M/SEC |
M |
M |
KW |
|
1,00 |
0,200 |
0,064 |
0,255 |
0,644 |
144,356 |
288,713 |
|
1,00 |
0,500 |
0,402 |
0,637 |
4,023 |
40,978 |
704,888 |
|
1,00 |
1,000 |
1,609 |
1,274 |
16,090 |
28,910 |
1289,100 |
|
1,00 |
1,500 |
3,620 |
1,911 |
36,203 |
108,798 |
1631,963 |
|
1,00 |
2,000 |
6,436 |
2,548 |
64,360 |
80,640 |
1612,800 |
|
1,00 |
2,500 |
10,056 |
3,185 |
100,563 |
44,438 |
1110,938 |
|
1,00 |
3,000 |
14,481 |
3,822 |
144,810 |
0,190 |
5,700 |
\
TABELLA 3= DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL
DIAMETRO DI m 1.20
|
DIAMETRO |
PORTATA |
PERDITA CARICO |
VELOCITÀ |
PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |
SALTO UTILE |
POTENZA |
|
M |
MC/SEC |
M/KM |
M/SEC |
M |
M |
KW |
|
1,20 |
0,200 |
0,024 |
0,177 |
0,243 |
144,757 |
289,513 |
|
1,20 |
0,500 |
0,152 |
0,442 |
1,521 |
143,479 |
717,394 |
|
1,20 |
1,000 |
0,609 |
0,884 |
6,085 |
138,915 |
1389,150 |
|
1,20 |
1,500 |
1,369 |
1,326 |
13,691 |
131,309 |
1969,631 |
|
1,20 |
2,000 |
2,434 |
1,768 |
24,340 |
120,660 |
2413,200 |
|
1,20 |
2,500 |
3,803 |
2,210 |
38,031 |
106,969 |
2674,219 |
|
1,20 |
3,000 |
5,477 |
2,653 |
54,765 |
90,235 |
2707,050 |
Risulta molto interessante l'andamento
della producibilità in funzione della portata addotta che,
in tutte le condotte esaminate, presenta valore zero Kw nel punto
iniziale a portata nulla ed in quello finale nel quale la portata
è massima ma tutto il carico è dissipato per il
suo trasporto, ma presenta soprattutto un culmine mediano di alta
produttività preceduto e seguito da brevi tratti a tracciato
sub orizzontale nei quali la produzione stessa si mantiene su
valori prossimi a quello massimo per una escursione abbastanza
notevole. E' su detto elemento ad alta resa idroelettrica che
è opportuno concentrare l'attenzione poiché se ne
possono ricavare indicazioni molto utili per la definizione della
soluzione ottimale.
La lista dei valori massimi di producibilità idroelettrica
è approssimativamente quella riportata nella seguente tabella
n. 4. Si nota immediatamente che, scartati i diametri 0.80 m e
0.90 m ed inoltre 1.20 m perché atti soltanto a trasportare,
ovviamente entro l'area di funzionamento ottimale, portate rispettivamente
inferiori e superiori di quella dell'esempio, la soluzione migliore
è senza dubbio quella con condotta da un metro di diametro.
Oltre a consentire lo sfruttamento del carico disponibile con
la massima producibilità elettrica ( portata 1.70 mc/sec,
salto utile m 98 e potenza KW 1670) essa
consente di modificare la portata da 1.30 a 2.10 mc/sec senza
apprezzabili variazioni di potenza il che consente di ottenere
quella stabilità effettiva di funzionamento e risolvere
quindi il problema di regolazione prima posto.
TABELLA 4= DATI CARATTERISTICI DELL'AREA
A FUNZIONAMENTO OTTIMALE PER I VARO DIAMETRI
|
Diametro condotta |
Punto di inizio area ottimale |
Punto di fine area ottimale |
Produzione idroelettrica
media KW |
|
|
Portata
mc/sec |
Carico utile m |
Portata
mc/sec |
Carico utile m |
|
|
0.80 m |
0.90 |
102 |
1.10 |
81 |
900 |
|
0.90 m |
1.00 |
117 |
1.60 |
73 |
1170 |
|
1.00 m |
1.30 |
118 |
2.10 |
74 |
1530 |
|
1.20 m |
2.50 |
107 |
3.50 |
85 |
2670 |
Fig. 1 = GRAFICO DI FUNZIONAMENTO PER
VARI DIAMETRI E PER TUTTA L'ESCURSIONE DI PORTATA
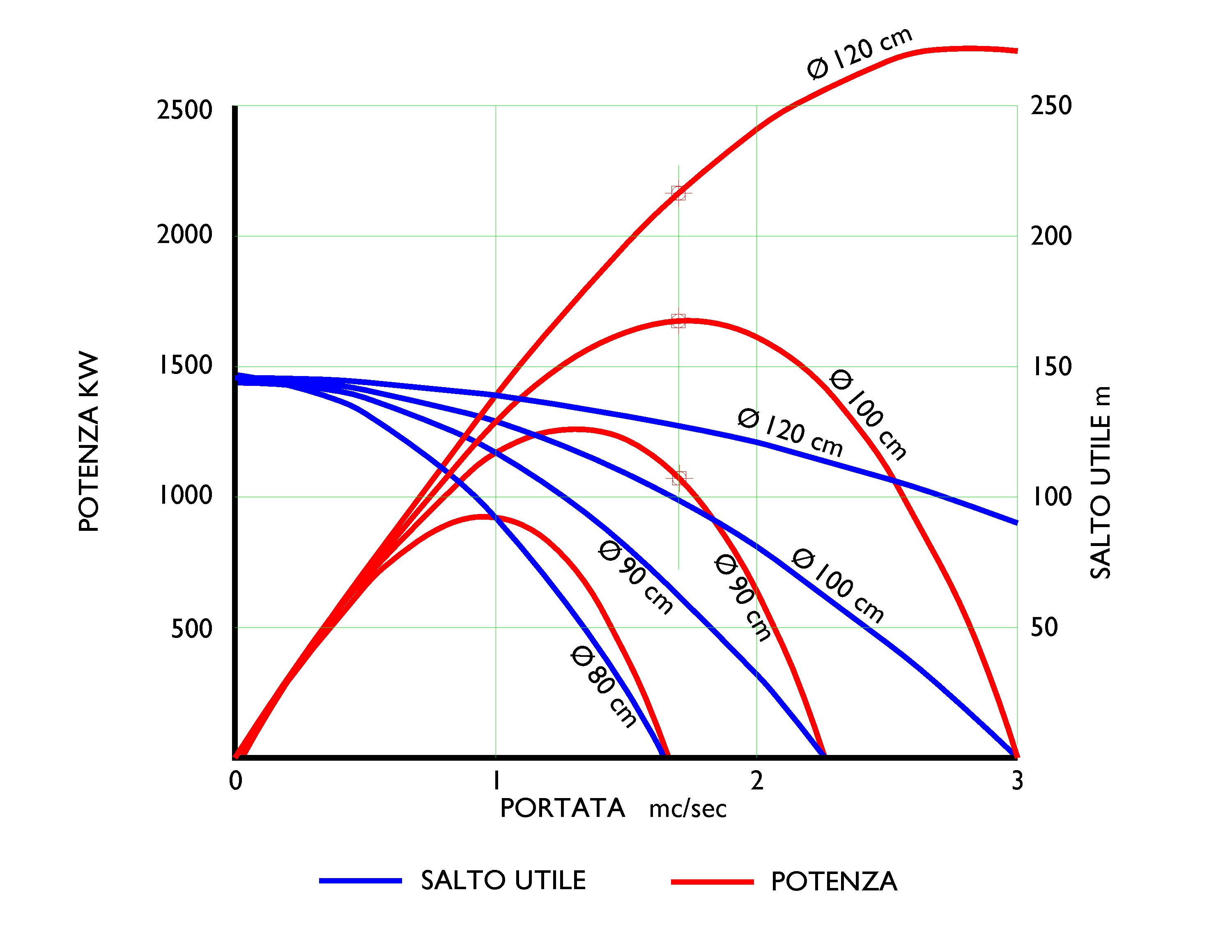
Le considerazioni conclusive sullo sfruttamento delle condotte
adduttrici degli acquedotti possono essere riepilogate come segue.
Esistono sicuramente delle situazioni molto favorevoli per la
produzione idroelettrica derivante da un razionale sfruttamento
dei carichi idrici però sussistono notevoli problemi di
regolazione degli impianti che, essendo costituiti da condotte
singole funzionanti in pressione, sono privi dei dispositivi di
stabilizzazione come le vasche di carico, le condotte forzate
idraulicamente separate dall'adduzione che sono generalmente adottate
negli impianti del genere. Per ovviarvi occorre una oculata scelta
delle condotte di adduzione che devono presentare una caratteristica
particolare prima definita "area ottimale a funzionamento
costante" ed inoltre delle apparecchiature automatiche di
regolazione che tramite opportuni dispositivi elettro-meccanici
come ad esempio una accurata modulazione della inclinazione delle
pale o del distributore della turbina assicurino piena stabilità
di funzionamento.
Vai all'indice