LOTTE
OPERAIE E POPOLARI NELLA RESISTENZA ROMANA
(Introduzione al Convegno "Il
mondo del lavoro per la libertà". Roma 27 aprile
2001)
Ben
presto il processo di normalizzazione imposto dal regime
totalitario investe anche le classi lavoratrici romane.
Nel corso del ventennio non mancano le manifestazioni di
dissenso e di protesta, ma si tratta più che altro di
iniziative sporadiche e isolate - dal volantinaggio
clandestino alle scritte sui muri - di pura testimonianza.
Dopo l'arresto, tra il 1930 e il 1933, dei membri della
struttura clandestina comunista romana, nulla sembra più
impensierire le autorità fasciste della Capitale nei
cosiddetti "anni del consenso".
Il rapporto tra il regime e una parte sempre più
consistente degli italiani comincia a incrinarsi con
l'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno 1940). Quando,
malgrado la censura e la propaganda, gli italiani
cominciano a rendersi conto in quale catastrofe il
fascismo abbia fatto precipitare il paese, la polizia
segnala a Roma, come altrove, numerose manifestazioni di
ostilità al regime. A leggere le motivazioni delle
condanne al carcere e al confino inflitte tra il 1941 e
il 1943 per "disfattismo politico", "offese
al capo del governo", "critiche al regime",
ecc. scopriamo che subire condanne non sono soltanto
oppositori politicizzati, ma tantissimi "apolitici"
che osano mettere in discussione l'esito vittorioso della
guerra e raccontare barzellette irriverenti. Il 17 marzo
1941 un impiegato "apolitico" è condannato a
due anni di confino perché racconta barzellette come
questa: Sai perché l'Italia rifiuta i carri armati
tedeschi? Perché non hanno la marcia indietro...
Tra la popolazione romana sta montando un malcontento che presto si trasforma in avversione al regime: non ha chiare motivazioni politiche e non è quindi riconducibile all'antifascismo militante, ma si alimenta giorno dopo giorno del disagio sociale, delle paure, delle privazioni di tanti romani. E' soprattutto nei luoghi di lavoro che questa ostilità si salda all'iniziativa antifascista dei gruppi clandestini organizzati. Ascolteremo tra poco la testimonianza di Agostino Medelina, all'epoca giovane operaio della Fatme, su un volantinaggio contro la guerra che provoca l'irruzione della polizia in fabbrica.
Occorre tuttavia sottolineare che nel complesso, anche
quando, con il delinearsi dell'imminente catastrofe, il
regime entra in crisi, il movimento operaio romano non
riesce ad esprimere qualcosa di lontanamente paragonabile
ai grandi scioperi che si svolgono al Nord nel 1943. Né
la situazione muta nel corso dei "quarantacinque
giorni", tra la caduta del fascismo e l'annuncio
dell'armistizio con gli Alleati (25 luglio - 8 settembre
1943).
Le ragioni di questa passività vanno ricercate nella
particolare composizione della classe operaia romana,
costituita per oltre un terzo da edili, gran parte dei
quali è impegnato nelle grandi opere promosse da regime,
come gli sventramenti nel centro storico, la creazione
delle borgate e dell' E 42 (l'attuale Eur) destinato a
ospitare l'esposizione universale per il ventennale della
marcia su Roma. Si tratta dunque di lavoratori soggetti
anche per il mantenimento del loro lavoro alle fortune
del regime, che subiscono pesanti contraccolpi
dall'arresto dei lavori pubblici determinato dalla guerra.
Alla grave crisi occupazionale si aggiunge una situazione
annonaria altrettanto grave, con la mancanza dei generi
di prima necessità e il prosperare del mercato nero.
Soprattutto nelle borgate e nei quartieri popolari, la
condivisione dei drammatici problemi di sopravvivenza
agisce da elemento aggregante della classe operaia e
finisce per favorire la maturazione di una coscienza
antifascista.
Con l'occupazione tedesca di Roma, dopo la coraggiosa
ma vana resistenza a Porta San Paolo, la situazione
economica, occupazionale e annonaria si aggrava
ulteriormente. Mentre al Nord i tedeschi vigilano perché
non si arresti la produzione, a Roma accade il contrario
e in poco tempo, dopo i cantieri, chiudono diverse
fabbriche, i cui impianti vengono trasferiti al Nord. Dei
30.000 metalmeccanici romani soltanto un migliaio riesce
a conservare il posto, ma a condizioni insostenibili.
Basti pensare che i salari orari variano tra le 3 e le 8
lire quando al mercato nero un chilo di pane costa 40-50
lire e uno di carne 160-180 lire.
Dopo la creazione della Repubblica di Salò i ministeri
vengono dislocati al Nord, ma solo una piccola parte dei
dipendenti pubblici accetta l'ordine di trasferimento,
mentre la maggioranza di essi resta senza lavoro. In
ottobre l'Istituto Poligrafico dello Stato, dove - come
sentiremo dalla testimonianza di Cesare Fredduzzi - il 25
luglio c'è stata una mezza rivolta contro i caporioni
fascisti, è completamente smobilitato e 6.000 operai
vengono messi sulla strada. Anche le piccole tipografie
non hanno più lavoro e molte si trasformano in luoghi di
stampa di giornali, volantini e opuscoli clandestini.
Malgrado ciò i lavoratori romani restano sulla
difensiva, sopportano licenziamenti, disoccupazione,
razionamento alimentare, ogni genere di privazioni e di
sacrifici sperando nella imminente liberazione della città.
 |
La notizia dello sbarco degli anglo-americani ad Anzio
(22 gennaio 1944) suscita in molti l'illusione che l'ora
della tanto attesa libertà stia per scoccare e induce a
proclamare lo sciopero generale insurrezionale. Ma poi lo
sciopero non viene neppure tentato e ci si rende invece
conto che la mancata travolgente avanzata degli Alleati
comporterà costi molto alti. E così avviene: la
resistenza è uscita allo scoperto ed ha messo in allerta
i tedeschi, che intensificano l'azione repressiva ed
effettuano numerosi arresti.
(Dato il carattere particolare della nostra iniziativa,
rivolta a mettere in risalto il contributo del mondo del
lavoro nella Resistenza romana, non approfondiamo in
questa sede gli aspetti politico-militari e diversi
tragici episodi accaduti a Roma durante l'occupazione
tedesca come il rastrellamento (16 ottobre 1943) degli
ebrei nel ghetto ( 1739, di cui 1625 moriranno nei campi
di sterminio), l'attentato di Via Rasella e la strage
delle Fosse Ardeatine (23-24 marzo 1944)
Per parare i colpi e attrezzarsi meglio alla lotta clandestina viene deciso di costituire in ogni luogo di lavoro dei Comitati sindacali di agitazione, coordinati da un Comitato sindacale cittadino, che dovrebbe funzionare "al momento della liberazione da Commissione provvisoria della Camera del lavoro romana, per riorganizzare la libera vita sindacale stroncata per vent'anni dall'oppressione fascista". Nei primi mesi del 1944 si verificano numerosi scioperi e agitazioni nelle fabbriche e nelle aziende municipalizzate, che oltre a esprimere una volontà di non collaborazione hanno un carattere più concretamente sindacale e vertenziale. Le agitazioni dirette clandestinamente dai Comitati sindacali si concludono generalmente con trattative che sono invece condotte da delegazioni elette per l'occasione /.../. Le richieste riguardano, sull'esempio del Nord; l'adeguamento salariale del 30%, la corresponsione delle cosiddette 192 ore (una specie di tredicesima), la concessione di prestiti di varia entità, e di indennità varie collegate al fatto che si lavora usualmente in situazioni di rischio e con mansioni diverse dall'ordinario.
Alla fine di aprile il fronte di Cassino comincia a muoversi e ai primi di maggio ha inizio la battaglia per la conquista della Capitale. Superate indecisioni e posizioni attendiste, il Comitato sindacale di agitazione e il Comitato di liberazione nazionale decidono di proclamare lo sciopero per la giornata del 3 maggio. Benché non abbia finalità insurrezionali, ma debba essere soltanto "uno sciopero generale economico politico di protesta" è chiaro che un'iniziativa del genere mira a creare ulteriori difficoltà agli occupanti tedeschi nel momento in cui essi già sentono sul collo il fiato degli Alleati.
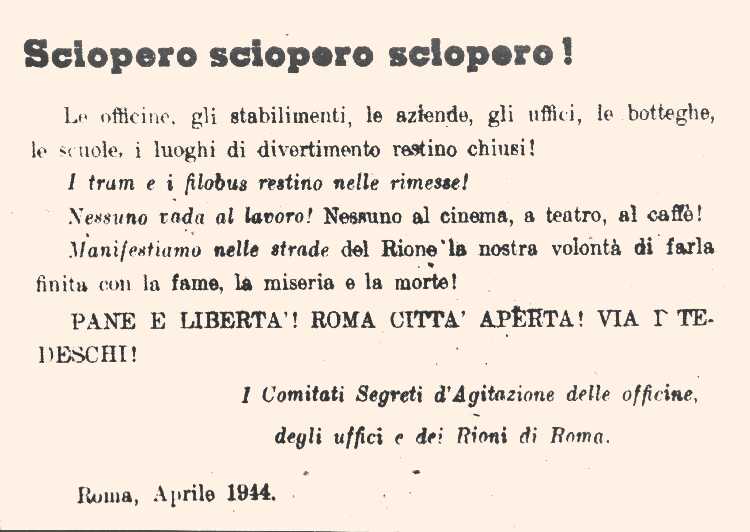 |
Le modalità di attuazione dello sciopero mirano soprattutto a coinvolgere quelle categorie come i tipografi e i tranvieri, la cui astensione dal lavoro, impedendo l'uscita dei giornali e dei mezzi pubblici darebbe grande visibilità all'agitazione. Avuto sentore di quello che si sta preparando, nella notte tra il 2 e il 3 maggio reparti della guardia repubblicana e di tedeschi occupano i depositi dei mezzi pubblici, trattenendo il personale smontante e obbligandolo a riprendere il servizio il mattino del 3. In questo modo le vetture escono dai depositi, ma in diverse zone della città gruppi di dimostranti riescono a bloccarle, asportando le leve di manovra dei tram e danneggiando i comandi. I tipografi del Messaggero non si recano al lavoro e il giornale arriva nelle edicole solo nella tarda mattinata, stampato alla meglio dal personale che il direttore Spampanato riesce a racimolare. Fedelissimo della RSI, Spampanato si vendica consegnando ai tedeschi l'elenco degli operai assenti, facendo arrestare 19 di loro. Alla Manifattura Tabacchi, in Trastevere, circa 800 tra operaie e operai iniziano il lavoro con un'ora di ritardo, dopo aver manifestato davanti all'edificio ed essere stati convinti ad entrare dalla promessa di aumenti di paga e dalla minacciosa presenza di numerose guardie.Significative adesioni allo sciopero si hanno anche al Mattatoio e in diversi luoghi di lavoro a San Lorenzo e al Tiburtino. In varie parti della città, soprattutto in periferia, si verificano manifestazioni popolari con comizi volanti e assalti ai forni, negozi e depositi alimentari.
 |
Per quanti sforzi facciano di minimizzare l'accaduto
tedeschi e fascisti sono costretti a fare alcune
significative concessioni: i lavoratori ottengono viveri
e il formale impegno ad un sensibile aumento dei salari.
Ma il risultato più importante è la rinuncia delle
autorità a diminuire la razione giornaliera del pane da
100 a 75 grammi.
Il mese di maggio è il più aspro dei nove mesi
dell'occupazione tedesca di Roma e impone ai romani
sofferenze e sacrifici sempre meno sopportabili. Mentre
l'attesa per l'arrivo degli Alleati diventa spasmodica, i
tedeschi si predispongono ad abbandonare la città
cercando di razziare tutto quello che si può portar via
(riserve alimentari, macchinari) e distruggendo il resto.
I patrioti organizzano allora pattuglie di sorveglianza
per impedire il danneggiamento e la distruzione degli
impianti industriali. Prima di abbandonare Roma i nazisti
non rinunciano ad attuare un'ultima feroce rappresaglia:
la notte del 3 giugno prelevano dal carcere di via Tasso
14 prigionieri e li fucilano in località La Storta. Tra
loro c'è Bruno Buozzi, dirigente sindacale e artefice
con Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi di quel Patto
di Roma che sancisce la nascita della Cgil unitaria.
Il giorno dopo, il 4 giugno 1944, Roma viene liberata e
subito si ricostituisce la Camera del Lavoro. Il 22 e 23
aprile 1945, mentre al Nord è in atto l'offensiva finale
delle forze partigiane, si riunisce il primo congresso
camerale che rende omaggio a quanti nella clandestinità
hanno tenuto le fila dell'organizzazione sindacale.
Ma il merito per la riconquistata libertà va oltre i
recinti dell'appartenenza a un sindacato o a un partito e
vede accomunati donne e uomini di diverse origini
sociali, fedi religiose e idee politiche.
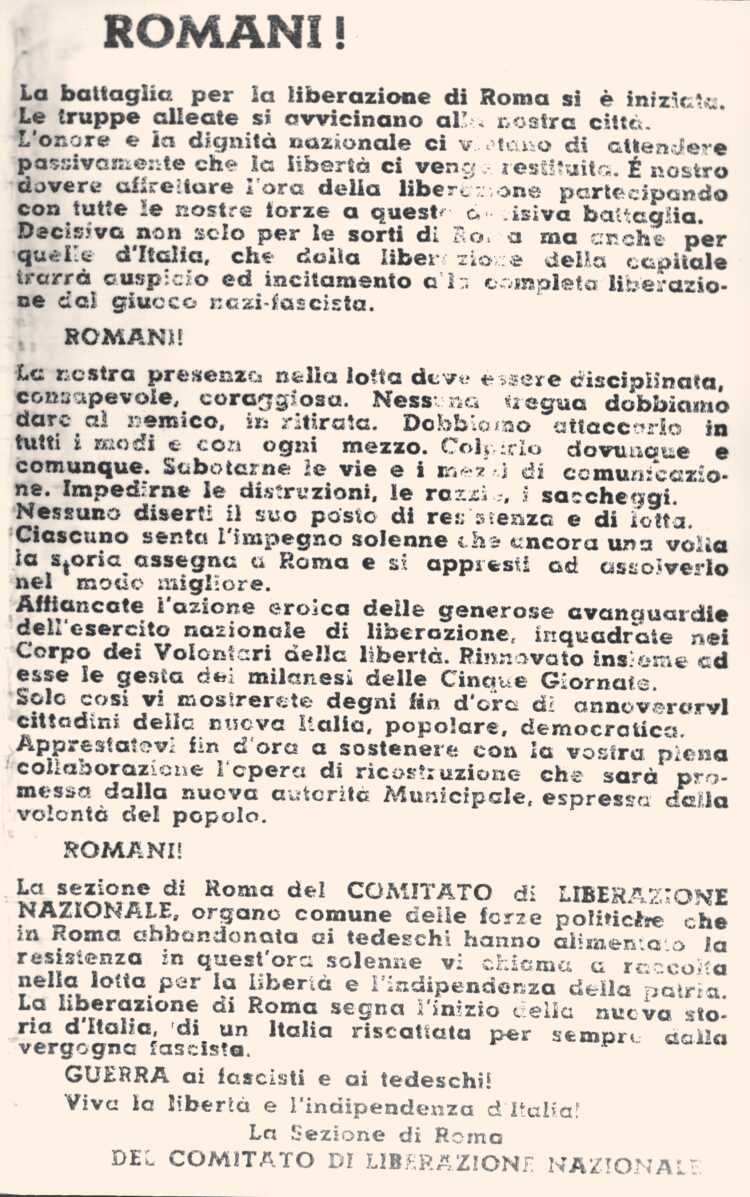 |
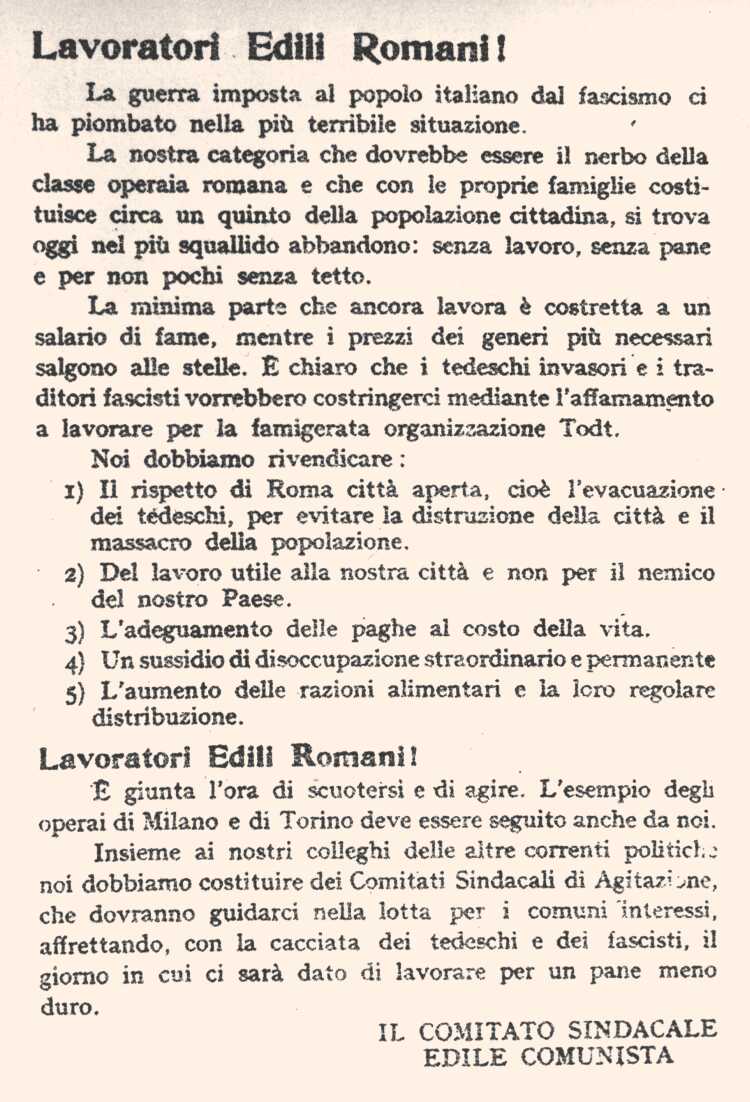 |
 |
 |
 |
© Archivio
Storico della Cgil di Roma e del Lazio. 2001
