Archivio Documenti --
Archivio
News-- Home
Documenti
Ultime notizie:
Fonte: http://www.sciam.com/
Data : 29.06.04
CRITTOGRAFIA
IL MISTERO DEL
MANOSCRITTO VOYNICH
Nuove analisi del
criptico documento medioevale suggeriscono che contiene nient’altro che
scarabocchi.
 Nel
1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una
vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di
circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente
illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.
Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.
Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi
medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le
figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,
suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il
1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che
era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel
1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di
decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino
appunto a che Voynich lo ritrovò.
Nel
1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una
vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di
circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente
illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.
Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.
Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi
medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le
figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,
suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il
1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che
era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel
1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di
decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino
appunto a che Voynich lo ritrovò.
Voynich
chiese ai principali crittografi dei suoi tempi di decodificare lo strano
scritto, che non corrispondeva ad alcun linguaggio conosciuto. Ma a dispetto dei
90 anni di sforzi da parte dei maggiori decifratori del mondo, nessuno è stato
in grado di spiegare il cosiddetto Voynichese, ed il contenuto dello scritto
rimane ignoto.
La
natura e l’origine del manoscritto sono anch’esse un mistero. Il fallimento
dei tentativi di decifrare il codice hanno levato il sospetto che non vi sia
alcun codice da codificare. Il Voynichese potrebbe non contenere affatto un
messaggio, ed il manoscritto potrebbe essere semplicemente un elaborato
imbroglio.
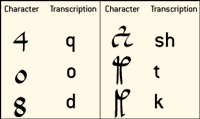 I
critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo
complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre
230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della
distribuzione delle parole?
I
critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo
complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre
230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della
distribuzione delle parole?
Recentemente
Gordon Rugg (l’autore di questo articolo N.d.T.) ha scoperto che è possibile
duplicare molte delle principali figure del Voynichese, usando un semplice
strumento di codifica disponibile nel XVI secolo. Il testo generato da questa
tecnica sembrerebbe molto simile al Voynichese, ma condurrebbe a semplici
scarabocchi, scritte senza senso, senza alcun messaggio nascosto. Questa
scoperta non prova che il manoscritto Voynich sia uno scherzo, ma sostiene la
teoria di lungo tempo secondo cui un avventuriero inglese di nome Edward Kelley
possa aver concepito il documento per defraudare Rodolfo II. (L’imperatore pagò
una somma di 600 ducati -
l’equivalente di 50,000$ di oggi, per il manoscritto).
Forse
più importante, il metodo usato nell’analisi del mistero del Voynich può
essere applicato ad altre questioni di difficile soluzione in campi del sapere.
Affrontare questo antico puzzle richiede esperienza in diversi settori, ad
esempio la crittografia, la linguistica, e la storia medioevale. Come
ricercatore nello studio dei processi mentali applicati a problemi complessi,
Gordon Rugg vede il suo lavoro sul manoscritto Voynich come un modello
applicabile anche ad altre questioni scientifiche di lungo periodo.
L’OCCHIO DEL DIO BAMBINO?
La
prima decrittazione proposta per il manoscritto Voynich si ebbe nel 1921.
William
E. Newbold, professore di filosofia all’Università di Pennsylvania, sostenne
che ogni carattere dello scritto conteneva piccoli segni di penna che potevano
essere visti solo sotto ingrandimento, e che questi segni formavano un’ antica
stenografia greca. Basandosi sulla sua lettura del codice, Newbold dichiarò che
il manoscritto Voynich era stato scritto dal filosofo e scienziato del XIII
secolo Ruggero Bacone, e che descriveva scoperte come l’invenzione del
microscopio. Entro und decennio, però, le critiche demolirono la soluzione di
Newbold, dimostrando che i segni microscopici sulle lettere non erano altro che
naturali spaccature nell’inchiostro.
Il
tentativo di Newbold fu solo il primo di una serie di fallimenti.
Negli
anni ’40 due appassionati, di decifrazione, Joseph M. Feely e Leonell C.
Strong, usarono cifre sostitutive che assegnavano lettere romane ai caratteri
del Voynichese, ma le traduzioni proposte avevano poco senso.
Alla
fine della II Guerra Mondiale, i crittografi militari statunitensi, che avevano
decifrato il codice imperiale dell’esercito Giapponese, si cimentarono nel
tempo libero con i testi cifrati dell’antichità, e riuscirono in tutti i
casi, eccetto che con il manoscritto Voynich.
Nel 1978 il filologo
amatore John Stojko sostenne che il testo era scritto in ucraino con la
rimozione delle vocali, ma la sua traduzione – che comprendeva frasi tipo
“Il Vuoto è quello per cui l’occhio del Dio bambino combatte” non ha
nessuna attinenza né con le illustrazioni né con la storia ucraina.
Nel 1987 un medico
di nome Leo Levitov sostenne che il documento era stato prodotto dai Catari, una
setta eretica che fiorì nella Francia medioevale, ed era scritto in una
commistione di parole di varie lingue. La traduzione di Levitov, ad ogni modo,
non si trovava d’accordo con la ben documentata teologia Catara.
Inoltre, tutti
questi schemi usavano meccanismi secondo i quali la stessa parola Voynichese
doveva essere tradotta in un modo in una parte del manoscritto ed in un modo
differente in un’altra parte. Ad esempio, un passo della soluzione di Newbold
implicava la soluzione di anagrammi, che è notoriamente imprecisa:
l’anagramma di ADER per esempio, può essere interpretata come in inglese READ,
DARE o DEAR.
La maggior parte
degli studiosi sostiene che il tentativo di codificare il manoscritto Voynich
sono viziate da un’inaccettabile grado di ambiguità. In più, nessuno di
questi metodi poteva codificare un messaggio leggibile in un testo cifrato con
le proprietà del Voynichese.
Se il manoscritto
non fosse un codice, potrebbe essere un linguaggio non identificato? Pur non
riuscendo a decifrarne il contenuto, sappiamo che mostra una serie straordinaria
di regolarità. Per esempio, la parola più comune spesso si ripete per due o più
volte in una riga. Per rappresentare le parole, Rugg ha usato l’Alfabeto
Europeo Voynich (EVA), una convenzione per traslitterare i caratteri del
Voynichese in lettere romane. Un esempio dal folio 78R del manoscritto si
potrebbe leggere: qokedy qokedy dal qokedy qokedy. Una simile ripetizione
di parole non si trova in alcun altro linguaggio. Viceversa, il Voynichese
contiene molte poche frasi dove due o tre parole diverse ricorrono regolarmente
insieme. Queste caratteristiche rendono improbabile il fatto che il Voynichese
sia un linguaggio umano – è semplicemente troppo differente da tutti gli
altri linguaggi.
La terza possibilità
è che il manoscritto sia un gioco o uno scherzo realizzato per conseguire
denaro, o che sia una sorta di divagazione senza significato di qualche
alchimista pazzo. La complessità linguistica del manoscritto sembra però
andare in senso opposto a questa teoria. In aggiunta alla ripetizione delle
parole, vi sono numerose regolarità nella struttura interna delle parole. La
comune sillaba qo, per esempio, ricorre solo all’inizio delle parole.
La sillaba chek può apparire all’inizio della parola, ma se ricorre
nella stessa parola con qo, allora qo viene sempre prima di chek.
La comune sillaba dy di solito appare alla fine di una parola e
occasionalmente all’inizio, ma mai nel mezzo.
Un semplice trucco
del tipo “prendo e mischio” che combina le sillabe in modo del tutto casuale
non potrebbe produrre un testo con così tante regolarità.
Il Voynichese è
molto più complesso di qualsiasi altra forma di linguaggio studiata nel
discorso patologico causato da danni cerebrali o disordini psicologici. Perfino
se un alchimista pazzo avesse costruito una grammatica per un linguaggio
inventato, e quindi trascorso anni del suo tempo scrivendo qualcosa che
impiegasse questa grammatica, il testo risultante non avrebbe condiviso le varie
figure statistiche che si riscontrano nel manoscritto Voynich. Per esempio, la
lunghezza delle parole del Voynichese forma una distribuzione binomia –
ovvero, le parole più comuni hanno cinque o sei caratteri, ed il ricorrere di
parole con un numero di caratteri maggiore o minore scende bruscamente dal
picco, nella rappresentazione su una parabola di simmetrie. Questo tipo di
distribuzione è estremamente insolita in un linguaggio umano. In quasi tutti i
linguaggi umani, la distribuzione delle lunghezze dalle parole è ampia ed
asimmetrica, con una ricorrenza maggiore di parole relativamente lunghe. E’
molto improbabile che la distribuzione binomia del Voynichese possa essere stata
una deliberata parte dello scherzo, perché si ritiene che questo concetto
statistico non fosse ancora stato inventato allora, e non lo sarebbe stato che
secoli dopo la creazione del manoscritto.
TECNICO
DEL RAGIONAMENTO
In sostanza, il
manoscritto Voynich sembra essere un codice estremamente insolito, un linguaggio
strano e sconosciuto o un sofisticato scherzo, e non vi è un modo ovvio per
risolvere l’impasse.
Rugg, e la sua
collega Joanne Hyde hanno cercato, qualche anno or sono, di risolvere questo
enigma. Hanno tentato di rivalutare le tecniche di ragionamento usate
nell’indagine ed i problemi connessi alla difficile ricerca.
L’affermazione che
le strutture del Voynichese non corrispondono ad alcun linguaggio umano, è
stata basata sulle tecniche di ragionamento applicate dai linguisti. Questa
conclusione è apparsa fondata, così Rugg ha proceduto a vagliare l’ipotesi
dello scherzo. La maggior parte degli studiosi che si sono dedicati al
manoscritto Voynich si è trovata concordi sul fatto che il Voynichese fosse
troppo complesso per essere uno scherzo. Rugg riteneva, ad ogni modo, che questa
dichiarazione fosse basata su un’opinione piuttosto che su ferme evidenze. Non
esistono esempi di riferimento.
Vari ricercatori,
come Jorge Stolfi dell’Università di Campinas in Brasile, si è domandato se
il manoscritto Voynich non fosse stato prodotto utilizzando tavole casuali di
generazione del testo. Queste tavole hanno celle che contengono caratteri o
sillabe; l’utente seleziona una sequenza di celle – forse in modo del tutto
casuale – e le combina a formare una parola. Questa tecnica potrebbe riuscire
a generare alcune regolarità all’interno delle parole del Voynichese. Secondo
il metodo di Stolfi, la prima colonna della tavola potrebbe contenere sillabe
prefissate, come ad esempio qo, che ricorre solo all’inizio delle
parole; la seconda colonna poteva contenere le sillabe che appaiono nel mezzo
delle parole, come chek, e la terza poteva contenere sillabe suffisse
come y. Scegliendo una sillaba da ogni colonna in sequenza, si sarebbero
prodotte parole con la struttura caratteristica del Voynichese. Alcune delle
celle potevano anche essere vuote, così che si sarebbero potute creare parole
mancanti di prefisso, di sillabe centrali o suffisso.
Altre strutture del
Voynichese, invece, non sono riproducibili in modo così semplice. Per esempio,
alcuni caratteri sono individualmente comuni, ma raramente ricorrono vicino
l’uno all’altro. I caratteri trascritti come a, e ed 1 sono
comuni, come lo è la combinazione al, ma la combinazione el è
molto rara. Questo effetto non può essere prodotto mischiando casualmente i
caratteri dalla tavola, così Stolfi ed altri hanno respinto l’approccio.
Il termine chiave
qui, è “casualmente”. Per i moderni ricercatori, la casualità è un
concetto prezioso, ma si ritiene sia stato sviluppato molto tempo dopo che il
manoscritto è stato creato. Un burlone medioevale probabilmente avrebbe usato
un modo differente di combinare le sillabe, che non potrebbe essere stato
casuale nel senso stretto del termine. Rugg ha così iniziato a domandarsi se
alcune delle strutture del Voynichese potessero essere state prodotte da uno
strumento ormai considerato obsoleto.
LA
GRIGLIA DI CARDAN
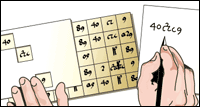 Sembrava
proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo
successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti
si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?
Sembrava
proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo
successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti
si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?
La risposta
dipendeva in larga misura dalla data in cui era stato prodotto il manoscritto.
Avendo lavorato in archeologia, un campo nel quale la datazione dei reperti ha
un’importanza notevole, Rugg ha verificato l’opinione corrente dei
ricercatori sul fatto che il manoscritto fosse stato creato prima del 1500. Era
illustrato nello stile del tardo 1400, ma questo attributo non fissa in modo
conclusivo la data della sua origine; le opere artistiche sono spesso prodotte
nello stile di un periodo precedente, sia innocentemente o anche per far
sembrare il documento più antico. Pertanto Rugg ha ricercato una tecnica di
codifica disponibile nel corso della gamma più ampia possibile delle date di
origine – tra il 1470 ed il 1608.
Una possibilità
promettente era la griglia di Cardan, creata dal matematico italiano Girolamo
Cardano nel 1550. Essa consiste di una cartella con tagli apribili su essa.
Quando la griglia viene sovrapposta ad un testo apparentemente innocuo, prodotto
con un’altra copia della stessa cartella, le aperture rivelano le parole del
messaggio nascosto. Rugg comprese che una griglia di Cardan con tre aperture
sarebbe potuta essere usata per selezionare le permutazioni dei
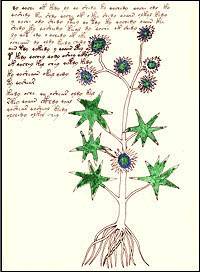 prefissi,
delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di
stile Voynichese.
prefissi,
delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di
stile Voynichese.
Una pagina tipica
del manoscritto Voynich contiene da 10 a 40 linee, ognuna consistente da 8 a 12
parole. Usando il modello a tre sillabe del Voynichese, una tavola singola di 36
colonne e 40 righe, avrebbe contenuto abbastanza sillabe per produrre
un’intera pagina manoscritta con una singola griglia. La prima colonna
elencherebbe i prefissi, la seconda le sillabe centrali e la terza i suffissi;
le colonne seguenti ripeterebbero il percorso. Si può allineare la griglia
all’angolo sinistro della tavola per creare la prima parola del Voynichese e
quindi muoverla di tre colonne a destra per creare la prossima parola. O si può
spostare la griglia ad una colonna successiva a destra, o ad una fila inferiore.
Posizionando successivamente la griglia sulle parti differenti della tavola, si
possono creare centinaia di parole di Voynichese. E la stessa tavola potrebbe
quindi essere usata con una griglia differente per creare le parole sulla pagina
successiva.
Rugg ha tracciato le
tre tavole a mano, impiegando non meno di tre ore per ognuna, e due o tre minuti
per incidere ogni griglia. Fatto questo, ha potuto generare il testo in meno di
quanto non fosse necessario per trascriverlo. In tutto, ha prodotto tra 1,000 e
2,000 parole in questo modo.
Rugg ritiene che
questo metodo potrebbe facilmente riprodurre la maggior parte delle strutture
del Voynichese. Per esempio, ci si può assicurare che alcuni caratteri non
ricorrano mai insieme disegnando attentamente le tavole e le griglie. Se i tagli
nelle griglie successive si trovano sempre su file differenti, allora le sillabe
in celle orizzontali adiacenti sulla tavola non si verificheranno mai insieme,
seppure possano essere molto comuni individualmente. La distribuzione binomia
delle lunghezze delle parole può essere ottenuta unendo sillabe corte,
medio-lunghe e lunghe sulla tavola. Un’altra caratteristica del Voynichese –
che le prima parole di una riga tendono ad essere più lunghe delle successive
– può essere riprodotta semplicemente mettendo la maggior parte delle sillabe
più lunghe sul lato sinistro della tavola.
Il metodo della
griglia di Cardan appare pertanto essere un meccanismo per il quale potrebbe
essere stato creato il manoscritto Voynich. Le ricostruzioni di Rugg
suggeriscono che qualcuno potrebbe avere prodotto il manoscritto, incluse le
illustrazioni, in solo tre o quattro mesi. Ma rimane una questione cruciale: il
manoscritto contiene solo scarabocchi senza senso o un messaggio codificato?
Rugg ha trovato due
modi per impiegare le griglie e le tavole per codificare e decodificare il
testo. La prima era una cifra sostitutiva che convertiva i caratteri del testo
delle sillabe centrali che sono così incastrate tra prefissi e suffissi senza
senso usando il metodo descritto sopra. La seconda tecnica di codifica assegna
un numero ad ogni carattere del testo e quindi usa questi numeri per specificare
la posizione della griglia di Cardan sulla tavola. Entrambe le tecniche ad ogni
modo producono gli scritti con molte meno ripetizioni di parole del Voynichese.
La scoperta indica che se la griglia di Cardan fosse stata usata, in effetti,
per creare il manoscritto Voynich, l’autore intendeva probabilmente non
intendeva elaborare un testo, quanto riprodurre un metodo articolato ed
intelligente. Rugg non ha trovato evidenza alcuna che il manoscritto celi un
messaggio codificato.
Questa assenza di
prove non prova che il manoscritto sia uno scherzo, ma il lavoro di Rugg mostra
che anche la costruzione di uno scherzo è un’operazione complessa, quasi come
la creazione di un testo cifrato. Questa spiegazione trova corrispondenza in
alcuni interessanti fatti storici: lo studioso elisabettiano John Dee ed il suo
socio Edward Kelley, di dubbia reputazione, visitarono la corte di Rodolofo II
nel corso del 1580. Kelley era un noto falsificatore, mistico ed alchimista,
piuttosto familiare con le griglie di Cardan. Alcuni esperti sul manoscritto
Voynich hanno a lungo sospettato che Kelley potesse esserne l’autore.
La studentessa di
dottorato di Rugg, Laura Aylward sta attualmente indagando se strutture
statistiche più complesse ricorrenti nel manoscritto possano essere riprodotte
mediante l’uso della tecnica della griglia di Cardan. Rispondere a questa
domanda richiederà la produzione di una grande quantità di testo mediante
l’uso di differenti tavole e griglie, così si sta studiando un software per
svolgere la procedura in automatico.
Questo studio ha
svelato numerosi indizi sulle tecniche di approccio concettuale a problemi
complessi, per determinare se sia stata trascurata alcuna soluzione possibile.
Ad esempio, si è riesaminato il processo logico impiegato dagli scienziati per
comprendere la causa della malattia di Alzheimer. Rugg intende verificare se il
suo approccio possa essere usato per rivalutare precedenti ricerche sui
disordini cerebrali. Intende cioè scoprire se gli investigatori abbiano
trascurato qualche aspetto di ragionamento rilevante. Ovvero: gli assunti chiave
sono stati testati sufficientemente? Vi sono state sottili incomprensioni tra le
differenti discipline coinvolte in questo lavoro? Se possiamo usare questo
processo per aiutare la ricerca sull’Alzheimer, il manoscritto medioevale che
sembra un manuale dell’alchimista pazzo, potrebbe provarsi in realtà un
trattato di medicina moderna.
Gordon Rugg ha
iniziato ad interessarsi al manoscritto Voynich circa 4 anni or sono.
Inizialmente visto come un enigma intrigante, lo ha in seguito considerato un
caso chiave per riesaminare problemi complessi.
Rugg ha ottenuto il
suo PhD in psicologia all’Università di Reading nel 1987. Ora lettore senior
nella Scuola di calcolo e Matematica all’Università di Keetle in Inghilterra,
Rugg è capo editore della rivista “Expert Systems: The International Journal
of Knowledge Engineering and Neural Networks”. La sua ricerca include la
natura delle competenze, ed i modelli di informazione, conoscenza e formazione
del pensiero.
Altri Documenti...
Home
 Nel
1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una
vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di
circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente
illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.
Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.
Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi
medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le
figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,
suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il
1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che
era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel
1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di
decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino
appunto a che Voynich lo ritrovò.
Nel
1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una
vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di
circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente
illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.
Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.
Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi
medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le
figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,
suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il
1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che
era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel
1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di
decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino
appunto a che Voynich lo ritrovò.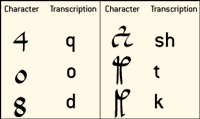 I
critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo
complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre
230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della
distribuzione delle parole?
I
critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo
complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre
230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della
distribuzione delle parole?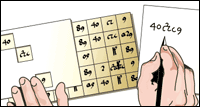 Sembrava
proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo
successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti
si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?
Sembrava
proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo
successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti
si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?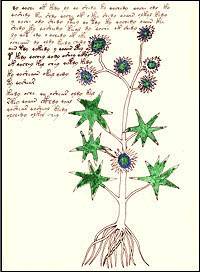 prefissi,
delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di
stile Voynichese.
prefissi,
delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di
stile Voynichese.