|
|
|
Non è compito da poco tracciare una evoluzione del mercato discografico negli ultimi dieci anni (da quando, più o meno, il CD ha smesso di essere un ‘formato sperimentale’ e si è affermato come ‘supporto di massa’ e Internet è entrato, bene o male, in tutte le case).
Ho deciso di introdurre in breve lo sviluppo delle telecomunicazioni in generale e, all’interno di questo contesto, una ‘storia dell’industria discografica’ che non può, oltrepassata la soglia del 2000, non trattare le etichette ‘indipendenti’, che stanno assumendo un ruolo fondamentale non solo per la rilevanza nel settore (oramai hanno la ‘struttura’, se non la ‘grandezza’, delle multinazionali), quanto per il materiale proposto (solo da lì viene, per così dire, il ‘nuovo’, e nel contempo il recupero di tutti i possibili ‘passati’), e dell’evoluzione del loro rapporto con le ‘sorelle maggiori’, che nel bene e nel male detengono ancora (per quanto?) l’80% del mercato.
Iniziamo dunque a vedere come dai primi anni ’90, con la diffusione di massa di Internet, si è riconfigurato il mercato musicale, frammento del più ampio settore delle telecomunicazioni dal quale non può essere trattato a parte, poiché si inserisce in una strategia ben precisa di cui vedremo ora i termini.
MULTINAZIONALI E TELECOMUNICAZIONI
Sul numero di maggio 2002 di “Le Monde Diplomatique” vi sono ben 4 pagine dedicate ad una attenta analisi di quella che forse è oggi la maggiore delle multinazionali impegnate nel settore delle telecomunicazioni, la Universal-Vivendi. Ignacio Ramonet, in un articolo intitolato “I signori delle reti”, sottolinea la vera e propria rivoluzione portata da Internet, ovvero la convergenza dei tre sistemi di segni a nostra disposizione per comunicare (scrittura, suono e immagine), cui corrispondono i vari settori della comunicazione (editoria; telefono, radio, disco; pittura, fotografia, cinema). La possibilità di riunire questi tre segni in bit (la più piccola unità di misura della memoria di un PC), ha determinato un doppio movimento nell’industria delle comunicazioni: da un lato, la tensione a raggiungere le più grosse dimensioni possibili attraverso logiche di fusione-assorbimento a livello azionistico di altre società; dall’altro, tramite queste logiche, diversificarsi in tutti i settori della comunicazione, con “l’obiettivo di divenire l’unico interlocutore dei cittadini”. “Questo obiettivo,” prosegue Ramonet, “è realizzabile solo a condizione che le comunicazioni possano circolare senza ostacoli attraverso il pianeta. Ecco perché gli Stati Uniti (inventori di Internet, primi produttori delle nuove tecnologie e sede delle principali aziende) si sono lanciati con tutto il loro peso nella battaglia della deregulation”.
La vera rivoluzione nel settore ci è indicata dall’importanza di sistemi come l’Auditel o il conteggio degli accessi ai siti Internet. Più aumenta l’utenza, più aumenta il costo della pubblicità e, di conseguenza, il capitale a disposizione delle multinazionali: se in passato, dunque, ” le aziende dell’industria culturale, vendevano informazione o intrattenimento ai cittadini, ora preferiscono vendere i consumatori (lettori, ascoltatori, telespettatori, internauti) agli inserzionisti”.
Il caso Universal/Vivendi citato nell’articolo è, in questo senso, realmente emblematico: la società è proprietaria di 16 marchi nel settore Cinema e Televisione (tra cui Universal Studios, Canal+, Telepiù), 17 nel settore Musica (tra i quali Decca, Deutsche Grammophon e Polygram), 9 nel settore Internet (tra cui MP3.com), 28 case editrici (comprese Larousse, Groupe Express e Sierra Entertainment) e 11 società di telecomunicazione, di cui due francesi e le altre sparse tra Europa e Africa del Nord.
IL MERCATO MUSICALE E LE ETICHETTE INDIPENDENTI
Al di là delle crisi di vendite, dei costi dei dischi, dei generi musicali, di MTV, attualmente l’industria musicale si configura come un mercato frammentatissimo.
Oltre alle ‘cinque sorelle’ (Sony, Universal/Vivendi, Time-Warner, BMG ed EMI), che assieme controllano quasi l’80% del mercato mondiale, esistono una infinità di etichette indipendenti. Sarà di queste ultime che ci occuperemo qui.
Il ‘fenomeno’ delle etichette indipendenti e delle autoproduzioni, nel mercato della musica popolare (esclusi dunque il jazz e la classica, che meriterebbero un discorso a parte) nasce, grosso modo, alla fine degli anni ’70, quasi in contemporanea con la ‘nascita’ del punk e della new wave. L’esigenza è quella di pubblicare materiale che nessuna casa discografica ha la minima idea di come produrre e promuovere, salvo cercare di accaparrarsi poi i nomi di maggior ‘successo’ (tipo R.E.M. e Nirvana, giusto per fare qualche esempio limitando il campo agli Usa tra metà anni ’80 e primi ‘90). La maggior parte di esse vengono poi ‘rilevate’, più o meno in contemporanea con l’avvento del CD (i cui costi di produzione, inizialmente, non erano così alla portata di tutti come oggi).
Ci tengo a sottolineare che però, da dieci anni a questa parte, è proprio quest’ultimo ‘anello di congiunzione’ ad essersi totalmente ridefinito. Se, ancora nel ’91, i Nirvana potevano ‘passare la mano’ e, dopo un esordio discografico promettente, incidere un album ‘epocale’ come ‘Nevermind’ per una multinazionale, oggi le ‘indipendenti’, sia per l’oggettiva difficoltà di rendere ‘di massa’ musiche sempre più sperimentali e/o introverse (ricordiamoci che nel frattempo le ideologie sono cadute, e con esse le speranze di ‘cambiamento’...), sia per l’abbassamento dei costi di produzione dei dischi, riescono a garantirsi una vita autonoma, fatta di passaggi ‘carbonari’ ma ‘sicuri’. Ovviamente si tratta di nicchie di mercato che, da un lato, non troveranno mai una esposizione mediatica ‘forte’ (da MTV, tanto per capirci, anche perché un videoclip da 5 minuti muove molti più capitali di un disco di un’ora e mezza…), mentre, dall’altro, evitano o cercano di evitare l’autismo comunicativo e l’autoreferenzialità grazie a collaborazioni (e contaminazioni fecondissime) tra artisti spesso molto diversi tra loro. Di necessità, virtù: non sempre, e qui si rileva ‘en passant’, l’importanza della stampa musicale, ‘filtro’ ormai necessario tra produttore e consumatore per evitare l’acquisto di dischi incisi più per istinto di sopravvivenza che per ‘divina ispirazione’. Che poi sia in questa scena che avvengano comunque le cose più interessanti, è solo la dimostrazione di quanto sia ormai moribonda, finalmente, quella visione adolescenziale e romantica della musica (l’’artista’ che produce ‘il bello’ di fronte alle ‘brutture del mondo’…) che ha fatto la fortuna più del mercato che non della musica, e quanto la necessità spesso sia più prolifica della purezza… Ma stiamo divagando, forse.
Entreremo ora nello specifico di alcune etichette indipendenti, cosa che ci dà modo di ‘toccare con mano’ le differenze di cui parlavo più sopra.
Il “caso” Island ci può dimostrare come la voglia di ‘passare la mano’ (o i musicisti) alle major non sia sempre stata stimolata artificialmente, ma sia andata spesso semplicemente incontro ai desideri degli stessi manager/musicisti indipendenti. La Island viene fondata da Chris Blackwell in Inghilterra nei ’60, e quasi subito viene ‘baciata dalla fortuna’. Un giovane giamaicano e la sua band, che non sanno a chi proporre la propria musica, trova in Blackwell un vero e proprio sostenitore e fan. Dato che il ragazzo si chiama Bob Marley e che il suo successo è di dimensioni planetarie, il conto in banca del fortunato manager sale alle stelle, al punto che egli stesso preferisce consociarsi con la Polygram, cedendo a quest’ultima gli aspetti promozionali e contabili della propria etichetta e concentrandosi sulla propria ‘vocazione’ di manager e ‘talent scout’. Il catalogo Island si arricchirà di artisti di nicchia ma ‘classici’ come Nick Drake e Tom Waits, oltre che di quella ‘gallina dalle uova d’oro’ che corrisponde al nome di U2. Nel 2000, a fusione avvenuta tra Polygram/Universal e Vivendi, a Blackwell verrà dato il benservito. Assieme a lui si ritroveranno sulla strada sia Waits che Tricky, due artisti non facili da maneggiare e che di certo non rendono quanto i nuovi tempi impongono. Si ritroveranno tutti e tre alla ANTI/Epitaph, etichetta fattasi un nome nell’ambito del revival del punk di metà anni ’90 e che ora, esaurita quella spinta, cerca di puntare su altri territori sonori, recuperando vecchi e dimenticati astri del firmamento blues (R. L. Burnside) o soul (Solomon Burke, l’autore della “Everybody needs Somebody to Love” cantata dai Blues Brothers).
Un altro personaggio che, in tempi più recenti (primi anni ’90) ha ‘creduto’ nella musica indipendente dedicandole tempo e anima (e anche un pizzico della propria vena di follia) è Alan McGee, leader della label inglese Creation. Capace di staccare un assegno da un milione di sterline a Kevin Shields, chitarrista dei My Bloody Valentine, per fargli produrre il disco ‘Loveless’ solo perché convinto della genialità di quell’uomo (e infatti il disco, immerso sul mercato nel ’92, oggi è un classico, ma all’epoca non vende una mazza…), si risolleverà dalla bancarotta con l’inaspettato successo mondiale degli Oasis (ennesimo caso di ‘nuovi Beatles’, che ciclicamente affligge la scena britannica…). Ora il catalogo della sua etichetta è ristampato dalla Sony.
La WARP invece, nasce negli anni ’90 e vanta un catalogo di tutto rispetto nell’ambito della ‘elettronica di confine’ (in primis Aphex Twin e Autechre, la cosiddetta ‘intelligent techno’); come tante altre etichette, sta ora ampliando il proprio catalogo, rinunciando ad una non più funzionale settorialità con produzioni quali l’esordio di Vincent Gallo (l’attore-regista di Buffalo ’66), l’ultimo disco dei Tortoise (‘inventori’ del post-rock ora in declino), e, novità delle novità, l’Antipop Consortium (rap su basi elettroniche).
Merita di essere raccontata più estesamente la storia della Anticon, etichetta creata nel 1998 da un manipolo di ‘rimatori’ (primi tra tutti Sole, autore di un paio di album solisti, collaborazioni svariate e tra le menti, assieme a Why? e Odd Nosdam, del progetto cLOUDDEAD, finito l’anno scorso in testa alle preferenze del New Musical Express) che non hanno trovato altro modo per veder pubblicate e distribuite le proprie strane creazioni che quello di pubblicarsele da soli.
Due sono, dunque, le caratteristiche delle ‘indipendenti’ attuali: innanzitutto, sebbene il ‘fenomeno’ nasca agli albori degli ’80 con il punk, oggi poco si trova di quell’etica (e di quell’estetica), se non in una indipendenza a livello di produzione, di scelta degli artisti e dei rapporti ‘umani’ con essi; secondo, la consapevolezza della necessità di coniugare la creatività con capacità manageriali non inferiori a quelle delle multinazionali (pubblicità su riviste specializzate, visibilità su Internet, promozione, interviste, concerti, ecc.).
Rispetto agli anni ’80, queste etichette sono senz’altro più ‘indipendenti’ in senso stretto (economico), e questo per una precisa evoluzione del mercato. Con l’avvento di Internet e con la possibilità di produrre CD a costo bassissimo, lo ripeto, miriadi di musicisti o manipolatori del suono che sanno benissimo non raggiungeranno mai il successo di massa possono comunque contare su un mercato con una forte identità, per quanto ridotto; spesso basta pubblicare più dischi a proprio nome e moltiplicare le collaborazioni, e in alcuni casi rinunciare alla vendita dei propri lavori in negozio: basta un sito internet da cui scaricare il materiale o a cui richiedere il CD per posta (e del resto le autoproduzioni sono sempre esistite, vedi Sun Ra o John Fahey… che poi siano state proprio le ristampe in CD — sempre da parte di piccole etichette, magari specializzate in ristampe di materiali ‘storici’ - a toglierli dall’oblio e restituirli alle ‘masse’, è tutto dire).
Le multinazionali, del resto, non hanno la minima intenzione di ‘rischiare’ in ‘nuove proposte’ come, ad esempio, era successo fino alla metà degli anni ’90 (quando su MTV potevi vedere anche video di artisti come Beck o Radiohead): di fronte a un mercato come dicevo frammentatissimo, cercano ancora di imporre strategie di marketing basate su assunti validi forse ancora 10 anni fa (quanti artisti sono stati scaricati negli ultimi due anni?). Infatti, di U2 e Madonna, fenomeni cioè capaci di esulare dai wahroliani 15 minuti di celebrità e di divenire ‘fenomeni di costume e culturali’, sembrano non essercene molti in giro (l’ultimo, forse anche discretamente interessante, è il rapper bianco Eminem…).
Forse per questo, i primi mesi di quest’anno, in alcuni megastore britannici è stato sperimentato il VIRTUAL MUSIC STORE. Si tratta della possibilità di entrare in un negozio e, anziché comprare un disco, inciderne uno con dentro i brani che si desidera, pagando un prezzo a canzone da 1 a 1,5 sterline (da 1,6 a 2,4 euro). “I brani — dice Adam Turner, gestore della società che ha creato il sistema — sono conservati in un computer centrale a Londra e, quando richiesti, vengono inviati via satellite ai terminali che si trovano nei negozi. Una macchina posta vicino alla cassa fornisce anche una copertina con i titoli dei brani” (fonte della notizia: Blow Up, giugno 2002). Universal, BMG e Emi hanno già aderito entusiasticamente. Non solo per tagliare le gambe alla pirateria (alla fine non un problema serio, solo un semplice specchietto per le allodole, a parere di chi scrive), ma soprattutto perché, in futuro, gli artisti potranno produrre solo gli ‘hit’ per la stagione e non un intero album con due successi e 7 o 8 ‘riempitivi’ (si tornerebbe così agli anni ‘60 dei 45 giri...). Se il sistema avesse successo, i negozi si trasformerebbero in qualcosa tipo ‘agenzie’, e la distribuzione indipendente sarebbe relegata ad Internet, togliendo ad essa così quasi ogni possibilità di rendersi visibile al di fuori della rete telematica.
|

Kevin Shields, mente e chitarra dei
My Bloody Valentine

Beck
cantautore 'postmoderno'

L'esordio di Vincent Gallo:
da Buffalo 66 al fantasma di
Chet Baker

cLOUDDEAD: i beniamini
del New Musical Express

.... no comment ....
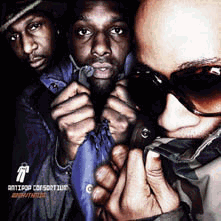
Hip hop e avanguardia:
Anti Pop Consortium

Tortoise, i pionieri del post rock dal vivo

Radiohead: quando la 'sfiga' porta
in classifica......
|
|
INTERVISTA A GABRIELE BRAMANTE
(WIDE RECORDS)
La Wide Records è stata fondata nel 1988 da Alessandro Favilli, Gabriele Bramante e Andrea Penco, provenienti da esperienze musicali nella scena dell’hardcore-punk dei primi anni ’80. Attualmente distribuiscono in esclusiva sul territorio italiano alcune delle più interessanti etichette indipendenti americane ed europee, tra cui Dischord, Touch and Go, Kranky, Too Pure, Matador, Sonic Youth Records, Def Jux ( e queste sono solo una piccola parte…)
Prendere contatto con etichette indipendenti, e distribuirne il materiale sul territorio nazionale: quali ‘ostacoli’ ci sono al vostro lavoro?
Ci sono soddisfazioni e collaborazioni positive ma se proprio dobbiamo vedere le difficoltà (non poche) esse consistono essenzialmente nel fatto che noi operiamo in un mercato molto piccolo ma che necessita di un grosso supporto da parte delle etichette che distribuiamo. In molti casi su questo terreno emergono le maggiori incomprensioni, spesso ci rendiamo conto che le etichette hanno difficoltà a capire come far funzionare i propri artisti in un territorio come l’Italia, probabilmente per differenze sostanziali di carattere etico, economico e strutturale.
Differenze tra una etichetta che produce e una etichetta che distribuisce (in termini di strategie commerciali, ritorni economici, etc.)
Le etichette hanno come unico obiettivo quello di far funzionare i propri artisti e si concentrano su quello, chi invece distribuisce più etichette deve lavorare su più piani in base ai diversi marchi gestiti. Tendenzialmente l’etichetta mira molto alla qualità ed alla cura dei propri artisti, mentre il distributore oltre a fare tutto ciò deve provvedere alle vendite coniugando qualità e quantità.
Strategie di marketing e ricezione del pubblico: cosa differenzia una multinazionale da una indipendente?
Le multinazionali sono molto burocratizzate, poco elastiche, svolgono un lavoro decisamente più “automatico” ed usano strategie impositive e pubblicitarie imponenti.
Spesso però non hanno persone in grado di prevedere l’emersione di fenomeni underground. Viceversa le indies si occupano proprio di scoprire talenti e marchi per farli emergere il più possibile ed operano in maniera più elastica, dinamica e creativa sia pur disponendo di minori mezzi.
Distribuzione via internet o in negozio: cosa ‘rende’ di più? Internet è veramente il futuro?
Internet è una nuova vetrina per esporre le proprie proposte, serve molto in questo senso a far conoscere le tue proposte in ambiti ampi ed aperti. Il negozio è una realtà che lavora sul locale, fornendo servizi e consigli ai propri utenti. Ci sono le ovvie differenze tra persone e computer ma sono in questo senso due attività complementari e parallele, l’una che lavora in maniera tradizionale chiamando la propria utenza, l’altra che usa nuovi metodi e raggiunge persone direttamente a casa.
Perché i dischi distribuiti dalle etichette indipendenti nei negozi costano, salvo rari casi, più o meno come le produzioni di una multinazionale (17-21 euro)?
Perchè sono meno le persone ad occuparsene e non hanno bisogno di strutture elefantiache e parcellizzate per lavorare. Le indipendenti sono mediamente strutture più piccole e quindi meno costose. C’è però da dire che le indies hanno costi per produzione molto più alti mentre le major li dividono tra le varie sedi. In sostanza le indies costano meno nella gestione ma hanno alti costi di produzione, mentre le majors hanno costi di produzione bassissimi ma costi di amministrazione e gestione spaventosi.
Perchè artisti come Waits o Tricky abbandonano le multinazionali e scelgono un’etichetta indipendente come la Anti?
Perchè hanno capito che con le indies si può lavorare con delle persone stimolanti e propositive ottenendo ottimi risultati.
E per tutte le ragioni sopra accennate.
|
INTERVISTA A MAX STEFANI ("IL MUCCHIO SELVAGGIO")
Max Stefani è il direttore del settimanale di musica “Il Mucchio Selvaggio”, tra le riviste ‘storiche’ degli appassionati di musica rock quella che ha mostrato più curiosità per la musica al di là dei generi (ma non solo: hanno fatto discutere le copertine dedicate al G8, all’11 settembre e le interviste a Francesco Saverio Borrelli o Giorgio Bocca)
Crisi di vendite: sembra che alcune multinazionali vogliano ‘sperimentare’ prezzi differenziati ma devono prima accordarsi... esperimento o utopia? I prezzi alti influiscono sulle vendite più dei prodotti scadenti?
Prezzi differenziati? Ci sono sempre stati e non saranno certo due euro di differenza e far tornare la gente nei negozi di dischi. Dovrebbero costare non più della metà. Indubbiamente anche il fatto della bassa qualità della musica proposta ha la sua influenza.
Cosa ne pensi del recente esperimento in un megastore inglese di poter registrare un cd con canzoni scelte da un database pagando un tot a brano (il Virtual Music Store)? Nuova ‘democrazia’ o un tentativo di eliminare i costi di produzione dei supporti? Può avere successo?
Secondo me può funzionare. Indubbiamente i costi a monte diminuirebbero, ma allora non ci sarebbe più bisogno delle case discografiche visto che potrebbero essere gli stessi musicisti a mettere a disposizione i loro brani. Dubito che si suicideranno.
Frammentazione del mercato: una ‘indipendente’ che strategie attua per vendere i propri prodotti? Qual’è o come crea un ‘target’? Qual è la differenza rispetto al rapporto coi propri artisti in confronto alle multinazionali (dal punto di vista contrattuale, del ritorno economico, i master a chi vengono affidati? All’etichetta o al musicista?)
Non c’è tutta questa differenza, almeno a livello contrattuale. L’unica differenza sta nel fatto che in queste realtà minori esiste ancora un rapporto umano. Non sei solo un numero. I canali, il target, etc. sono i medesimi.
I prodotti ‘indipendenti’ sono più validi di quelli delle ‘major’?
Diciamo che le indie possono permettersi di rischiare di più e di avere più tempo a disposizione perché l’artista possa avere successo. Spesso quindi la qualità è migliore, ma quasi sempre appena hanno successo gli vengono rubati da una major. Anche i musicisti devono campare e ai soldi è difficile dire di no.
Sembra che anche le indipendenti stiano diversificando la propria offerta (la Warp che fa incidere Vincent Gallo o Antipop Consortium, la Anti che pubblica Tom Waits, Tricky e RL Burnside)... paura di essere troppo di nicchia o necessità commerciale di ampliare il proprio bacino di utenza?
Ripeto. A parte gli inizi o qualche eccezione, stanno tutti lì per fare più soldi possibile. Purtroppo più sei di nicchia e più rischi la morte.
Ho acquistato in negozio, l’anno scorso, Ghost Tropic dei Songs:Ohia a 40.000 lire, poi ho scoperto che richiedendolo alla Secretly Canadian lo avrei pagato 9 dollari + spese postali: sono i costi di distribuzione o i negozianti che fanno salire il prezzo?
C’è il distributore che lo compra alla Secretly e che a sua volta lo vende al negoziante. Ambedue ci devono guadagnare. Sono due passaggi in più.
Perchè artisti come Tom Waits, Joe Strummer o Tricky abbandonano le multinazionali e passano alle indipendenti? Che cosa trovano? Più libertà artistica? Contatti più diretti? Contratti meno vincolanti? e le royalties?
Alcuni ci passano perchè non hanno altre alternative, perchè magari non vendono più un disco. Altri perchè se ne fregano dei soldi. Indubbiamente c’è anche più libertà artistica e più contatti umani.
|