|
|

Tom in un momento di particolare ispirazione...
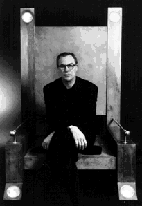
Robert Wilson
 
A sinistra: Waits, Wilson e Burrougs durante una conferenza stampa. A destra: Tom Waits e William Burroughs
      
Un disegno di Wilson per la scenografia di "Alice"
 |
Papà mi teneva sulle ginocchia
E mi raccontava tante cose
E diceva, piccolo mio
Ci sono un sacco di cose in questo mondo
Che non servono a niente”
(da “Lucky Day”)
NON PUOI SEPARARE LA ROSA DAL ROVO SENZA SENTIRTI UN PROIETTILE NEL CUORE
La 'metamorfosi' di Tom Waits tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 è ormai nota a tutti, ed è stata trattata in tutte le salse. Quindi ci limiteremo a dire che la svolta di "Swordfishtrombones" è già segnata dal rapporto col cinema e col teatro, non fosse altro che per Kathleen Brennan, colei che collabora da quasi due decenni con il nostro, non solo in ambito domestico e famigliare, ma, cosa che ci interessa di più in questa sede, compositivo.
La Brennan, infatti, prima di lavorare per Coppola (lei e Tom si incontrano sul set di "One from the heart"), aveva composto musiche per teatro, ed è lei a fargli conoscere il mondo delle sonorizzazioni per gli spettacoli scenici, insieme a una delle figure più importanti della musica contmporanea, quell'Harry Partch cui di recente John Zorn, guru del downtown newyorchese, ha dedicato un album.
Se vi riascoltate "Sworfishtrombones", "Raindogs", "Frank's Wild Years", non potrete fare a meno non solo di ascoltare una marea di strumenti 'non ortodossi', ma anche di trovarvi presi tra le maglie di una trama narrativa fatta di frammenti (i frammenti della vita di Frank, un reduce dal Vietnam di cui Waits, tra incubi del passato, disadattamenti, sogni, sbronze, amori perduti, rimpianti, guai, finestrini di treno, ci mostra l'inarrestabile deriva), una 'trilogia' fatta di infiniti flashback, il cui unico paragone cinematografico ci sembra essere, al momento, "C'era una volta in America" di Sergio Leone (solo molto più frammentato e schizzato).
Era quindi forse logico che il buon Tom, prima o poi, 'ci provasse' anche con una delle più antiche e nobili delle arti: il Teatro.
Il caso vuole che sia Robert Wilson il predestinato (ma qui ci sarebbe da chiedersi: chi dei due?). Wilson è uno dei più noti registi d'avanguardia (consci ormai del fatto che oggi questo termine vuol dir tutto e niente…); tra le sue opere più famose citiamo "Einstein on the beach", con musiche composte da Philip Glass, e, in ambito rock, le opere “Time Rocker” e “POEtry”, in collaborazione con Lou Reed.
Le rappresentazioni di Wilson sono caratterizzate da architetture sceniche minimali, fatte di linee e colori uniformi e monotoni, quasi a dare il senso di un destino ineluttabile in cui i personaggi non sono altro che comparse (e se pensiamo, ad esempio, al "Woyzeck", il cui protagonista è, per motivi che vedremo, tutt'altro che conscio di ciò che gli sta attorno, siamo sicuramente sulla strada giusta…).
Vediamo adesso di entrare nei particolari dell'opera, o meglio delle opere che Wilson ha portato in scena con Waits.
"The Black Rider" è un'opera composta a sei mani: la terza firma è quella di William S. Burroughs, l'autore de "Il pasto nudo" e 'guru' della beat generation (ma non solo, dato che molti musicisti si sono ispirati a lui, almeno in alcuni momenti della propria carriera: dal compianto Geoffrey Lee Pierce dei Gun Club ai pionieri del noise Sonic Youth, da Lou Reed a Laurie Anderson, giusto per fare qualche nome).
La trama dell'opera è molto semplice, parzialmente ispirata alla leggenda tedesca del "Franco cacciatore" e al "Faust", come a un episodio autobiografico dello stesso Burroughs.
Un giovane impiegato si innamora della figlia di un cacciatore, e, per poter aspirare alla sua mano, deve partecipare a una battuta di caccia e risultarne vincitore. Il ragazzo non è certo un esperto con la carabina, ma ad un crocicchio incontra PegLeg, il Diavolo Gambadilegno, che gli regala delle pallottole dorate magiche, dicendogli soltanto "qualcuna di queste pallottole è per te, qualcun'altra è per me". E così, il giorno della gara, l'apprendista cacciatore inforca la carabina e spara. Ma il proiettile, con una strana traiettoria, colpisce proprio l'amata, e il giovane cacciatore fuggirà nel bosco in preda alla follia.
Notiamo, en passant, una differenza fondamentale con tutte le storie di diavoli di cui sicuramente avrete sentito parlare: dal Faust goethiano che promette eterna giovinezza al demonio che, così vuole la leggenda, insegna a suonare la chitarra a Robert Johnson, tutti i protagonisti di queste storie scelgono consapevolmente di barattare la propria anima per stringere il patto. Questo, al protagonista di "The Black Rider", non succede. "Voglio solo che tu sia contento", dice PegLeg al suo sprovveduto 'protetto'. Da questo punto di vista, possiamo dire senza timore di smentita che la 'favola' raccontata dai tre 'orchi' (regista, scrittore e musicista) è una favola sull'alienazione, e non sulla dannazione. Non c'è consapevolezza nel giovane impiegato che si improvvisa cacciatore. Non c'è traccia di soggettività; al di là dei momenti puramenti narrativi, o dei monologhi di Peg Leg, ci sono dei brani ("November", "The briar and the rose") che somigliano molto agli effluvi lirici e sognanti di Frank (l'estasi nel sogno o nel desiderio, come un residuo del soggetto che tuttavia non riesce a tradursi nell’esperienza); c'è, sempre in "The briar and the rose", l'unico frammento in cui assistiamo a un'esprienza reale del protagonista, quella dell'inscindibilità della bellezza e del dolore ("Cercai di separarli [la rosa e il rovo]/Mi sentii un proiettile nel cuore"), e l'immagine successiva di quella canzone è già un presagio di morte ("Quando sarò nella tomba/Parlami e saprò/Che le tue lacrime scendono/Per far crescere l'amore/Il rovo e la rosa"), una morte che peraltro, con quella chiusura sull'immagine del rovo e della rosa, non scioglie la frattura che l'ha provocata. Potremmo, anzi, dire che, di fronte alla scoperta dell'inscindibilità di amore e morte, il protagonista rinuncia (e non solo alla fine, quando, uccisa inaspettatamente l'amata con la pallottola magica, impazzisce: l'aver accettato da PegLeg quelle pallottole 'gratis' è, forse, il primo gesto di rinuncia a sé).
Anche il ‘crossroad’, il crocicchio, che nell’inconscio collettivo è proprio il luogo dove si cede l’anima al diavolo in cambio di qualche particolare abilità (pensate alla leggenda di Robert Johnson, per dire la più famosa di tutte), è qui un luogo completamente differente. A George, il protagonista, non viene data nessuna capacità particolare, solo delle pallottole magiche, e Peg Leg, più che a un Diavolo, somiglia ad un vecchio e furbo spacciatore a caccia di sprovveduti. “Crossroads” è sicuramente il brano più vicino ai temi cari a Burroughs (“Tu credi di poterle usare quando vuoi, vero? / Di tenertene un po’ da parte per i giorni brutti / Be’, tutti abbiamo di quei giorni in cui non ne azzecchi una / Più pallottole magiche usi / Più giorni brutti hai senza di loro”), e anche lo stile narrativo e tipico del padre della beat generation. Ma le pallottole dorate sono metafora della droga solo in quanto, come la droga, comportano l’illusione di poter controllarne l’uso:
“Alcune di quelle pallottole hanno un bersaglio speciale
Un cervo particolare, una certa persona
Non importa dove miri
Il proiettile colpirà dove vuole
E mentre prendi la mira il fucile sarà come un bastone da rabdomante
E punterà dove la pallottola vuole andare”
(da “Crossroads”)
Non è la prima volta che Waits fa uso di temi cari alle arti letterarie o visive caricandoli di nuovi significati: pensate, ad esempio, al treno (dalle ballads di Woodie Guthrie ai libri di Steinbeck), col loro carico umano di persone in cerca di lavoro e di nuova vita (sogni poi puntualmente infranti dalla durezza della vita, ma vissuti con partecipe speranza); a come viene stravolto a livello di significato in “Frank’s Wild Years”, dove Frank, il protagonista (uno dei tanti personaggi che vivono ‘dalla parte sbagliata della strada’, per dirla con Tom…), osserva il mondo ‘dal finestrino ingiallito di un treno’, fuggendo da una delle sue tante vite precedenti (o, meglio, da uno dei suoi tentativi di riaggiustare la propria vita…).
Alienazione, dicevamo prima: in “The Black Rider” ne viene esplorato un aspetto particolare. Privo del libro di istruzioni per l’uso del mondo — qualcuno di voi ricorda il ‘Talking Book’ di un vecchio brano di Lou Reed? - , e soprattutto di un mondo particolare, quello della caccia, che non gli appartiene, il nostro sfortunato protagonista, è destinato al fallimento per eccesso di ambizione e penuria di strumenti (anche mentali: in fondo, il ‘peccato’ di George è la scarsa consapevolezza di se stesso).
Musicalmente, "The Black Rider" è il disco più 'roboante' di Waits, da molti giudicato 'inascoltabile'. Era da tanto che il vecchio Tom ci aveva abituato a suoni e strumenti particolari (o utilizzati in modo atipico): passi per il megafono ad amplificare la voce, per il calliope (un organo a canne che, però, mette vapore come un vecchio battello…), per gli archi e i violini da orchestra balcanica ubriaca; tuttavia qui, a parte l'assenza delle chitarre (e di un chitarrista come Marc Ribot che aveva marchiato a fuoco molti dei dischi precedenti), tutto è portato all'estremo. A brani 'pieni' di suoni e rumori (l'iniziale ouverture di "Lucky Day", con tanto di rullo di tamburi e Waits al megafono che ci presenta, come un vecchio imbonitore da circo, tutte le 'meraviglie delle meraviglie' che popoleranno il palcoscenico….) se ne alternano altri scarni come "November", solo voce che ulula malinconia, sostenuta da due note di fisarmonica e banjo e da un basso continuo di harmonium che si insinua nella melodia, piuttosto che delinearla. E se in "Just the right bullets" un demonio ubriaco, più che luciferino, tesse le lodi delle proprie pallottole magiche su un contrappunto pianistico, alternando le strofe con percussioni martellanti e furiose (ci sono poche percussioni in questo disco, ma quando ci sono la fanno da padrone… sentitevi anche la straziante "Russian Dance", dove una marcia di scarponi logori e consunti drammatizza una straziante melodia…), i brani 'cantati' da Burroughs sono forse l'eredità più inquietante di tutto il disco, assieme a "That's the way", preludio alla già citata "The Briar And the rose" che è probabilmente il baricentro emotivo del disco. Siamo giusto a metà dell'opera (i brani sono 18 in tutto), e possiamo già capire come finirà la storia ("Non piangere per me/ perché me ne sono andato/ un bel giorno ritornerò"), in un bosco con una scatola di fagioli e l'ultima rosa dell'estate che sfiorisce. C'è ancora tempo per il richiamo del "Gospel Train" ("abbiate solo fede nel Signore… salite a bordo/ sul treno di Gesù/non ascoltate il Diavolo/lui sa come commuovervi") e per il consumarsi della tragedia.
GIOCARE ALLA ROULETTE RUSSA
CON LA PROPRIA TESTA
PER TROVARE UN UOMO BUONO
Non è difficile affermare che "The Black Rider" sia l'opera più complessa di Waits, e, probabilmente, il suo punto più alto. Tanto che in molti anno osservato come i suoi dischi successivi siano, forse, solo (splendida) routine.
Personalmente concordo (soprattutto sull'aggettivo), tant'è vero che anche "Blood Money", pubblicato l'anno scorso assieme a "Alice", segue le medesime coordinate stilistiche e tematiche di "Black Rider", pur risultando più uniforme stilisticamente. Come se l'esperienza precedente (ma anche quella di "Alice", che, pubblicazione discografica a parte, risale ai primi anni '90), fosse stata capitalizzata e messa a fuoco per presentarsi in una forma più omogenea. Lascio ad altri le disquisizioni sull'equazione 'maturità' = 'meno ispirazione'.
Sta di fatto che anche "Blood Money" nasce da una collaborazione con Brian Wilson. Il testo, stavolta, è il "Woyzeck" di Georg Buchner, rivoluzionario tedesco dell'800 che, deluso dalla politica, si dà alla professione medica e alla scrittura (tra le sue opere, citiamo almeno "La morte di Danton"). Anche in Buckner l'alienazione è la tematica principale (Woyzeck è un soldato sofferente di schizofrenia - o aberratio mentalis, come si sarebbe detto all'epoca che, vessato dai compagni e dal medico della caserma, arriverà al delitto). Ma in Buchner, per la sua coscienza sociale, la domanda sull'origine del male nell'uomo non è mai disgiunta dalla condanna della società, dei suoi meccanismi perversi: per Buchner è la società a schiacciare il soldato Woyzeck fino a frantumarne l'identità; tuttavia, come nasca e si faccia strada nell'individuo - seppur pressato da quella società che lo scrittore seziona senza alcuna pietà - l'alienazione, e come questa si possa trasformare in lacerante violenza, è un mistero che lo stesso Buchner lascia intatto sotto i nostri occhi (e in questo senso, Woyzeck e Danton, protagonista di un altro suo dramma, e agli antipodi della scala sociale, sono comunque speculari).
Musicalmente, "Blood Money" è il canzoniere perfetto di Waits, il disco dove tutti gli strumenti si amalgamano perfettamente e i singoli brani, pur vivendo di luce propria, trovano nell'insieme il proprio compimento. Un bilanciamento che ha del miracoloso, o che, forse, ha più a che fare con la sapienza del 'mestiere' (ammesso che sia un delitto…). Dalle iniziali "Misery River" ed "Everything Goes To Hell", dove piano, strumenti a fiato e percussione forniscono il giusto tappeto sonoro alla voce cupa e cavernosa del Nostro, alle delicate "Coney Island Baby" e "All the world is green", dall'amara "Another man's vine" al blues malato di "Starving in the belly of a whale", intercalato tra le struggenti "Lullaby", solo sussurri di voce, violoncello e violino, e "The part you throw away". In chiusura, una "Good man is hard to find" dove Waits interpreta un Louis Armstrong ubriaco.
Tutti I testi sono narrati dal punto di vista del protagonista (che, all’opposto, nel dramma di Buchner è l’unico ad avere una voce frammentata, disorientata, tanto che l’impressione è che, più che parlare e agire, sia ‘parlato e agito’ - dalla propria malattia, oppure per riflesso condizionato rispetto agli stimoli che riceve dal proprio ambiente). Del resto, proprio nel linguaggio di Buchner, che quasi ‘viviseziona’ la lingua e la logica dei personaggi per mostrarne tutta l’ambiguità (dai compagni di caserma alla moglie allo psichiatra), risiedeva la modernità e l’originalità di un’opera scritta a metà dell’800. Una peculiarità difficile da riproporre, su un palco come su supporto fonografico. Per questo, probabilmente, Waits ha optato per un altro punto di osservazione. In questo modo, però, il soldato Woyzeck finisce per assomigliare troppo a Frank e ad altri personaggi che Waits ci ha già descritto nei minimi dettagli. E per questo, va detto, forse scade un poco nella maniera. Evidentemente, la complessità del testo originario ha messo in soggezione sia Wilson che Waits.
Chi ha potuto assistere, il 13 settembre 2002 a Roma, alla rappresentazione di Wilson (nel corso della manifestazione "RomaEuropaFestival") ha confermato le mie note introduttive sul lavoro del regista. Una cattedrale di linee e colori freddi, glaciali. Anche qui, si è parlato di manierismo, sottolineando come la musica di Waits fosse comunque riuscita a 'scaldare' la freddezza della messa in scena. Sicuramente, quelle coreografie fatte di luci fredde e linee spezzate contribuiscono a rendere minuscoli i protagonisti che in esso si muovono. La scelta del regista di portare in scena un’opera a metà tra il lied e il musical non è, forse, tanto un omaggio a Kurt Weill (l’autore dell’”Opera da tre soldi”, su testo di Bertold Brecht, costretto sotto il nazismo a emigrare negli Stati Uniti dove si è poi dedicato, appunto, ai musical), quanto una modalità espressiva che Waits ha, forse, sintetizzato in uno dei testi composti per l’opera: “If you live in hope you’re dancing on a terribile tune” (Starving in the belly of a Whale).
SEMI DI MELA SUL PAVIMENTO PER AMORE
DI UNA BALENA E DI STRAVINSKI
Diverso il discorso per "Alice", che con “The black rider” è, forse, l’opera più riuscita dal sodalizio tra i due artisti. Forse, perché entrambe non nascono da un testo già ordinato, ma da un tema cui dare forma in massima libertà. Ecco “Alice” nelle parole di Robert Wilson:
“Ho creato un’opera con quattordici scene. In “Alice” ci sono due atti, ognuno basato sui due libri di Alice (“Nel paese delle meraviglie” e “Attraverso lo specchio”, ndr) […] Il primo atto si svolge in una stanza, uno spazio interiore con oggetti presi dalla natura. Il secondo si svolge in una foresta, uno spazio esterno, con oggetti di forma umana. Tutta l’opera è incentrata sulla figura di Charles Dodgson, ovvero Lewis Carrol, il matematico, scrittore e fotografo, che amava fotografare ragazzine. Una di esse era Alice Liddel, per la quale ha scritto le storie di “Alice nel paese delle meraviglie”. Dodgson, che è anche il Bianconiglio e il Cavaliere Bianco, guida Alice attraverso l’opera. Nella prima scena vediamo Dodgson fotografare Alice che, sfuggendogli, precipita nel Paese delle meraviglie. La scena che sta a metà di ogni atto ha la funzione di prospettiva autobiografica, ed è piena di colori. La quarta scena ci mostra Alice Liddel, ora cresciuta, sola, mentre beve. La settima scena mostra Charles Dodgson solo, privo di aiuto.
La scena finale di ogni atto (la settima e la quattordicesima), sono le scene in cui i protagonisti vengono messi alla prova, risultando entrambi colpevoli della propria relazione”.
La musica che Waits crea per quest’opera è malinconica e triste, notturna, scura. I temi portanti sono la tristezza, la follia, la decomposizione e la morte, come in No one knows I’m Gone e Flower’s Grave (“nessuno posa dei fiori sulla tomba di un fiore”) Il tutto ricomposto in una prospettiva dove, accanto a siparietti ironici e divertenti che bilanciano l’atmosfera complessiva (Kommienezuspadt, un brano recitato in falsetto e in un improbabile tedesco, e Tabletop Joe, la storia di un ‘freak’ dotato solo di testa e mani che finisce per suonar il piano in un circo, sebbene potesse ‘suonare Stravinski con la mano sinistra’ e il suo sogno fosse quello di entrare, appunto, nell’orchestra di Tabletop Joe…), spiccano una galleria di personaggi e veri e propri racconti nel racconto, tra una ‘Poor Edward’ di straniante tristezza che sembra uscire da un film tedesco degli anni ’30 (“dietro la testa aveva un volto, di donna o di ragazza, non ricordo bene… la notte gli raccontava cose che si sentono solo all’inferno”) e il racconto del marinaio del passerotto che si innamora di una balena (Fish and Bird), fino al dolce sogno di Watch Her Disappear, dedicato da Waits alla moglie Kathleen. Episodio centrale del disco è sicuramente ‘Reeperbahn’ (quartiere a luci rosse di Amburgo), con la sua galleria di personaggi disperati e quei versi che forse sono tra i più belli di tutto il songbook waitsiano:
“Se hai perso la tua eredità
E tutto ciò che hai perso è il senso comune
E non sei troppo pignolo verso le persone cui sei legato
O il materasso dove dormi
Dietro ogni finestra, dietro ogni porta
La mela è andata ma c’è sempre il torsolo
E i semi si spargeranno su tutto il pavimento” ,
sintesi ideale di tutta la galleria di falliti e reietti della vita tratteggiati finora dalla penna del cantautore di Pomona. Anche la musica per “Alice” non sfugge al manierismo (c’è chi dice sono anni che Waits si limita a reinterpretare se stesso…), tuttavia, se i risultati sono questi, speriamo di poterci nutrire ancora per molto tempo di questa ‘maniera’, e che Waits ci regali ancora per molto tempo sogni fuori tempo massimo e ci racconti a volontà le sue storie dal lato sbagliato della strada.
|