 Il
fronte degli obiettori
Il
fronte degli obiettori
Dopo undici anni di travaglio
parlamentare, la nuova legge sul servizio civile è stata approvata.
Storia di un diritto
negato, ma anche strumentalizzato, che ormai interessa cinquantamila giovani.
Grandi speranze e piccoli
abusi.
Che san Massimiliano, martire renitente alla leva,
protegga la nuova legge sull'obiezione di coscienza. Nuova fino a un certo
punto: il testo approvato al Senato due settimane fa vagava per il Parlamento
da undici anni.
Il santo patrono dei nonviolenti dovrà vigilare alacremente:
sono molti i pericoli che insidiano obiezione ed obiettori. Negli anni
recenti, per esempio, si è dovuto constatare che la prima e gli
ultimi possono essere facilmente strumentalizzati. Il servizio civile è
diventato per troppi ragazzi una comoda alternativa al servizio militare:
non scelto per convinzioni etiche e religiose, ma perché appare
meno faticoso. E anche quell'esercito di quasi cinquantamila obiettori
che fornisce manodopera a costo zero a 3531 enti pubblici e privati è
diventato un affare: può succedere che gli interessi di bottega
prevalgano sugli ideali di pace.
| In Italia poi, dal punto di vista politico, l'obiezione di coscienza soffre di una tara congenita, che potremmo definire sindrome della patata bollente: nessuno vuol prenderla in mano. Nel '92, Francesco Cossiga pensò di avvalersi di una prerogativa presidenziale mai utilizzata prima: rifiutò di firmare la legge che aveva miracolosamente ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento. E la rimandò alle Camere. Anche oggi, non è che i funzionari dello Stato abbiano una voglia matta di gestire l'obiezione, finora amministrata dalla Difesa. |
Le uniche buone novità sono quattro: l'obiezione è ora un diritto e non più un beneficio concesso dallo Stato; l’amministrazione del servizio civile viene smilitarizzata; gli obiettori partecipano anche a missioni internazionali; l'articolo 8 auspica la creazione di forme di difesa non armata. |
Un dubbio da chiarire subito è che questa legge non introduce particolari novità: gran parte delle ingiustizie contenute nella prima legge sull'obiezione, del 1972, sono state abolite o corrette da sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato.
La durata del servizio militare e civile era già stata equiparata; mitigati gli interrogatori stile Inquisizione dei carabinieri agli aspiranti obiettori; giudicata inammissibile la competenza in materia dei tribunali militari. Le uniche buone novità sono quattro: l'obiezione è ora un diritto e non più un beneficio concesso dallo Stato; l’amministrazione del servizio civile viene smilitarizzata; gli obiettori partecipano anche a missioni internazionali; l'articolo 8 auspica la creazione di forme di difesa non armata.
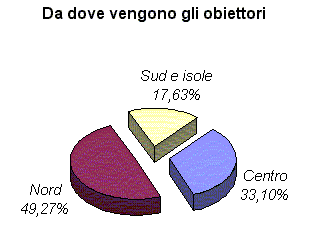
«Ma per certi versi questa legge è un passo indietro», dice Massimo Paolicelli, portavoce dell'Associazione Obiettori Nonviolenti. «Dal primo gennaio '99, i termini per la presentazione della domanda sono abbassati da 60 a 15 giorni dalla data di arruolamento: con la disinformazione che c'è, molte domande verranno respinte perché fuori termine. Per alcuni settori del servizio civile sono ammessi i periodi aggiuntivi di formazione, da definire, e questo è anticostituzionale: il servizio civile tornerebbe ad essere più lungo di quello militare. È giusto che non possa esercitare il diritto di obiezione chi possiede il porto d’armi, ma è ingiusto precludere questo diritto a chi è condannato con sentenza di primo grado per possesso d’armi e atti violenti. Primo grado non è un giudizio definitivo. Non si applica la stessa severità con i medici obiettori contrari all'aborto».
Forse gli obiettori hanno un latente complesso di persecuzione, ma è vero che anche nel nuovo testo di legge riaffiora un certo intento punitivo. Un sospetto di colpa ha sempre accompagnato chi, per degni motivi, rifiutava di impugnare le armi. Certi interrogatori dei carabinieri sono entrati nella leggenda. Un classico era il caso della sorella violentata: all'obiettore si domandava come avrebbe reagito vedendo un bruto che gli stuprava la sorella. Se l'interrogato riaffermava il suo rifiuto di ricorrere alla violenza, il carabiniere minacciava cataratte di disprezzo sociale. Ma se il ragazzo ammetteva l'eventualità di picchiare il bruto, l'astuto appuntato decretava che era un nonviolento fasullo. Arruolabile.
Ma la vera punizione, per gli obiettori e per la società, è quella di sprecare questo considerevole patrimonio umano e culturale. Il 93 per cento degli obiettori ha un grado di istruzione superiore o universitaria. Sacrificare dietro la fotocopiatrice di una Asl o nella portineria di un istituto religioso le competenze, l'impegno, la spirito di solidarietà di un ingegnere, di un musicista, di uno psicologo, è una forma di stupidità, più o meno crudele. Oliviero Bettinelli, responsabile del settore educazione – pace – mondialità della Caritas, dice che il ministero della Difesa non ha mai ottimizzato l'utilizzo di queste risorse. Forse per scoraggiare l'incremento del servizio civile, che ha comunque registrato un'escalation incontenibile: dalle 29 mila domande del '93 alle quasi 55 mila del '97. Per la maggior pare presentate nel Centro e Nord. Nel Sud, la percentuale di richieste d'obiezione scende al 17 per cento: amor patrio o disinformazione?
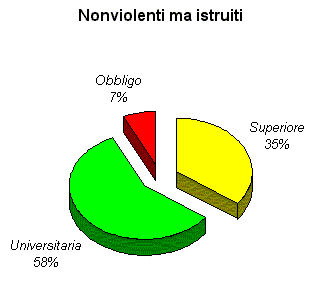
Bettinelli sostiene che la popolazione di 5000 obiettori impiegati annualmente dalla Caritas si può dividere in tre fasce equivalenti: «Ci son quelli che non gliene frega niente, difficile cavarne qualcosa. Ci sono i motivati che hanno buone energie ma non hanno ancora deciso se spenderle per se stessi o per gli altri: su di loro si lavora bene. Ci sono poi i ragazzi che hanno avuto esperienze politiche o ecclesiali e con quelli il più è fatto. Ma tutti devono affrontare un tirocinio, anche prima del servizio: è impensabile mandare allo sbaraglio un ragazzo tra i malati di Aids».
Come dire che per fare l'obiettore ci vuole più iniziativa che per fare il militare. Bisogna organizzarsi, trovare l'ente in cui si vuole prestare servizio, chiedere informazioni ad amici e organizzazioni giovanili, i tam-tam più ascoltati. E una volta in servizio, negli enti che non ti sfruttano come manodopera gratis, bisogna darsi da fare: non si è parte di un organico ma un qualcosa in più, potenzialmente prezioso. Quindi è bene essere disponibili, affidabili, creativi. Non si direbbe, ma il fronte più difficile è quello culturale: un cineforum in comunità montana è impegno da eroi.
Alla Caritas cercano di smistare gli obiettori “coerentemente”. I medici negli ambulatori; chi ha studiato lingue, diritto internazionale, scienze politiche, sulle problematiche degli immigrati; gli ex boy scout a fare animazione con i minori. Ma può sempre capitare un perito chimico difficile da piazzare.
Licio Palazzini, presidente dell'Arci servizio civile, 2500 obiettori l'anno, non si preoccupa troppo della "coerenza di percorso": «Il servizio civile è per molti ragazzi un'opportunità di conoscere una parte di sé e del mondo che altrimenti non avrebbero mai scoperto. È una sfida a mantenere aperto questo rapporto con la solidarietà anche dopo. Il vero problema, se si vuole applicare correttamente la legge, è la formazione. Noi ci investiamo 600 milioni l'anno».
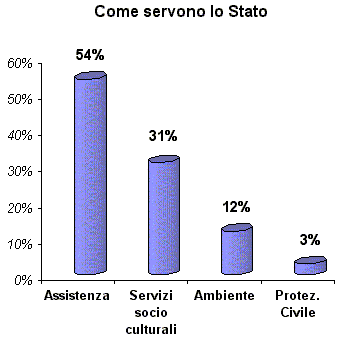
Oltre la metà degli obiettori è impiegata nella pubblica amministrazione: comuni, provincie, comunità montane, Asl, carceri, musei. Per il resto, enti privati di servizio e assistenza, spesso scollegati fra loro, tante gocce nell'oceano. «Anche nel servizio civile ci vuole un po' di aziendalità, sennò si disperdono le forze», continua Palazzini «Il ministero della Difesa non approvava la collaborazione, forse temeva che troppi obiettori insieme facessero la rivoluzione. Invece bisogna consorziarsi, creare strutture comuni, controllare l'andamento delle attività. E ridiscutere i criteri di assegnamento delle convenzioni. Per esempio, che ci fanno degli obiettori nel Centro italiano turismo sociale di Alleanza nazionale? Non era il partito che si è battuto di più contro l'obiezione?».
Paola Zanuttini
|
Nonviolenti d'Italia
|
| L’anno ufficiale di nascita dell'obiezione
italiana è il 1948. Nel mese di maggio, Pietro Pinna, un giovane
che non è riuscito a dimenticare gli orrori della Il Guerra mondiale,
si rifiuta di prestare il servizio di leva e di entrare in qualsiasi struttura
militare.
Viene ovviamente incarcerato e condannato, ma getta i semi di un movimento d'opinione che germoglierà negli anni a venire, grazie anche al lavoro del filosofo Aldo Capitini: è lui a divulgare in Italia il pensiero nonviolento di Gandhi. Chiariamo subito che, anche in seguito a una discussione parlamentare, la parola nonviolenza (con i suoi derivati) va scritta tutta attaccata. Perché afferma un principio e non una mancanza. Fino alla fine degli anni ’60, gli obiettori sono bestie rare difese da ancor più rari supporter, come Don Milani e Giorgio La Pira. Nel '68, divampa anche la loro protesta. Molto impegnativa. Fino alla legge del '72 che legalizza l'obiezione, l'espiazione della pena per non aver prestato il servizio di leva non esonera dagli obblighi militari: quindi gli obiettori escono ed entrano dal carcere militare. La legge dei '72 non è un capolavoro di democrazia: l'obiezione di coscienza è un beneficio concesso a discrezione di una commissione nominata dal ministero della Difesa. Il servizio civile dura 20 mesi. La magistratura militare giudica anche in materia di obiezione. Nel '73 nasce a Roma la Lega Obiettori di Coscienza e avvia la campagna per riformare la legge. Che nel corso degli anni viene notevolmente migliorata. |
[inizio pagina] [nonviolenti d'Italia] [la nuova legge 230] [home]