
Il futuro è imprevedibile e ambiguo. La "nebbia della pace" ha sostituito quella della guerra – per usare una espressione di Clausewitz. Le certezze della guerra fredda sono finite, insieme alle eleganti semplicità della dissuasione nucleare, al prevalere della componente militare nelle politiche di sicurezza e alla prevalenza in queste ultime delle dimensioni "dure" o tecnologiche i cui impatti sono per loro natura misurabili, su quelle "morbide" o umane, dagli effetti meno prevedibili.
La politica.
La strategia si è politicizzata, mentre la forza militare
è sempre più spesso impiegata in combattimento. Le sue capacità
effettive hanno più importanza di quelle virtuali che invece dominavano
durante gli anno del confronto bipolare...
La non-guerra non è più separata dalla guerra. Ne
è un esempio la Bosnia, laddove solo i bombardamenti della Nato
hanno ripristinato la capacità di dissuasione e di coercizione della
comunità internazionale. Le minacce non sono più sufficienti,
in quanto vengono ritenute un semplice bluff, che si può impunemente
sfidare. Non si può più fare affidamento sulla razionalità
dell’avversario, come era avvenuto per decenni tra Washington e Mosca.
I mass media.
Lo sviluppo dei mezzi di informazione aventi una copertura globale e capaci di diffondere notizie in tempo reale ha fatto sì che le opinioni pubbliche siano divenute un fattore centrale in ogni calcolo, non solo politico ma anche strategico e, in futuro, anche tattico. Il politico e lo stratega si trovano spesso nelle condizioni di un chirurgo che debba effettuare un intervento in una sala operatoria piena di parenti emotivi e vociferanti. Ormai si combattono sempre due battaglie: una sul campo, l’altra sui mass-media. Il consenso è necessario, ma la "Cnn-politics" abbattendo le frontiere fra politica interna ed estera, comporta il rischio di subordinare la seconda alla prima.
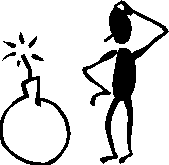
Il pacifismo
È sciocco pensare di evitare la guerra esorcizzandola, soprattutto
ora che la guerra è più probabile, sebbene molto meno pericolosa
– anzi è più probabile proprio perché meno pericolosa
-. Tale atteggiamento è anche rischioso. La pace non si difende
da sola! Va difesa. La presenza dei soldati è essenziale per l’ordine
internazionale come quella di carabinieri e magistrati per l’ordine interno.
Come la forza militare, questi ultimi non promuovono la giustizia,
ma solo l’ordine, che tuttavia rappresenta il presupposto necessario per
la realizzazione di qualsiasi giustizia.
Le nuove insidie.
I presupposti per mantenere la pace sono due. Il primo è il
possesso da parte di chi desidera salvaguardare lo status quo di una potenza
superiore a quella dei possibili sfidanti e della volontà di servirsene
quando è necessario. Il secondo è la capacità di gestire
lo status quo, ad esempio in campo economico, politico e psicologico, così
da renderlo tutto sommato accettabile.
I vincitori della guerra fredda sono insidiati da un Terzo Mondo
insoddisfatto, da trasformazioni molto rapide negli equilibri economici
e militari da tendenze alla frammentazione e alla disgregazione degli Stati,
che potrebbero portare ad un nuovo Medioevo, privo però dei principi
regolatori di cui erano garanti il Papato e l’Impero. La globalizzazione
e la conseguente competizione economica mondiale e, soprattutto, i trend
demografici obbligano gli Stati occidentali a contrarre i costi dello Stato
sociale, quindi a concentrare l’attenzione sulla politica interna.
Italia ecumenica.
In Italia alle limitazioni oggettive alla nostra sovranità, determinate dall’interdipendenza mondiale e dalle forze transnazionali, se ne aggiungono altre che ci siamo autoimposti, per l’erosione del senso di identità nazionale perseguita, in parte volutamente, da correnti culturali e politiche "ecumeniche" e per la profonda crisi, politica e istituzionale, che lo Stato attraversa. Ciò impedisce addirittura agli italiani di avere la consapevolezza di essere tra i vincitori della terza guerra mondiale – cioè della guerra fredda – e li rende incapaci sia di cogliere le opportunità che si sono aperte sia di assumere quei ruoli e responsabilità da cui dipenderà la possibilità futura di far parte del governo del mondo o almeno di quello dell’Europa.
Diplomazia della violenza.
A differenza della seconda guerra mondiale, conclusasi con la debellatio
del nemico e l’imposizione di una resa incondizionata, attualmente l’uso
della forza di per sé non risolve i conflitti. Serve solo a far
ritornare la situazione a un punto in cui sia possibile ricominciare a
trattare. L’intervento non ha per scopo la giustizia, ma il ristabilimento
di un certo ordine, cioè di condizioni di tregua. Un successo militare
non determina la soluzione di un conflitto interno, crea solo una gamma
di opzioni, sbloccando una situazione senza via d’uscita. La forza facilita
i processi politici. Non è un loro sostituto. È un presupposto
necessario, ma non sufficiente per la pace.
Per essere impiegata efficacemente essa ha bisogno, quantomeno,
di sapere che tipo di pace vogliono i politici. La strategia della gestione
delle crisi si identifica così con la "diplomazia della violenza".
Se non esiste una potenza leader in grado di dare unitarietà
agli interventi multinazionali, sarà ben difficile gestire efficacemente
azioni preventive. La gestione di interventi preventivi a livello globale
– da parte dell’ONU – appare quasi impossibile sotto il profilo pratico.
Solo gli Usa o al limite alleanze di difesa come la Nato, possono garantire,
oltre a forze e capacità operative, l’indispensabile unitarietà
e tempestività decisionale.
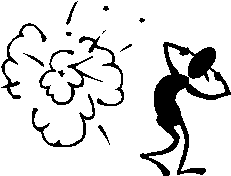
Cultura della guerra.
Le difficoltà attuali derivano anche dal fatto che, dopo cinquant’anni
di demonizzazione della guerra, l’Occidente ne ha perso la cultura. Invece
di una cultura della pace, bisognerebbe ripristinare quanto prima una cultura
sulla guerra.
Sarà difficile, ma se lo si riuscisse a fare, ci si renderebbe
conto che cosa significa intervenire militarmente e si saprebbe agire efficacemente,
senza limitarsi a lamentose prediche o a condanne retoriche.