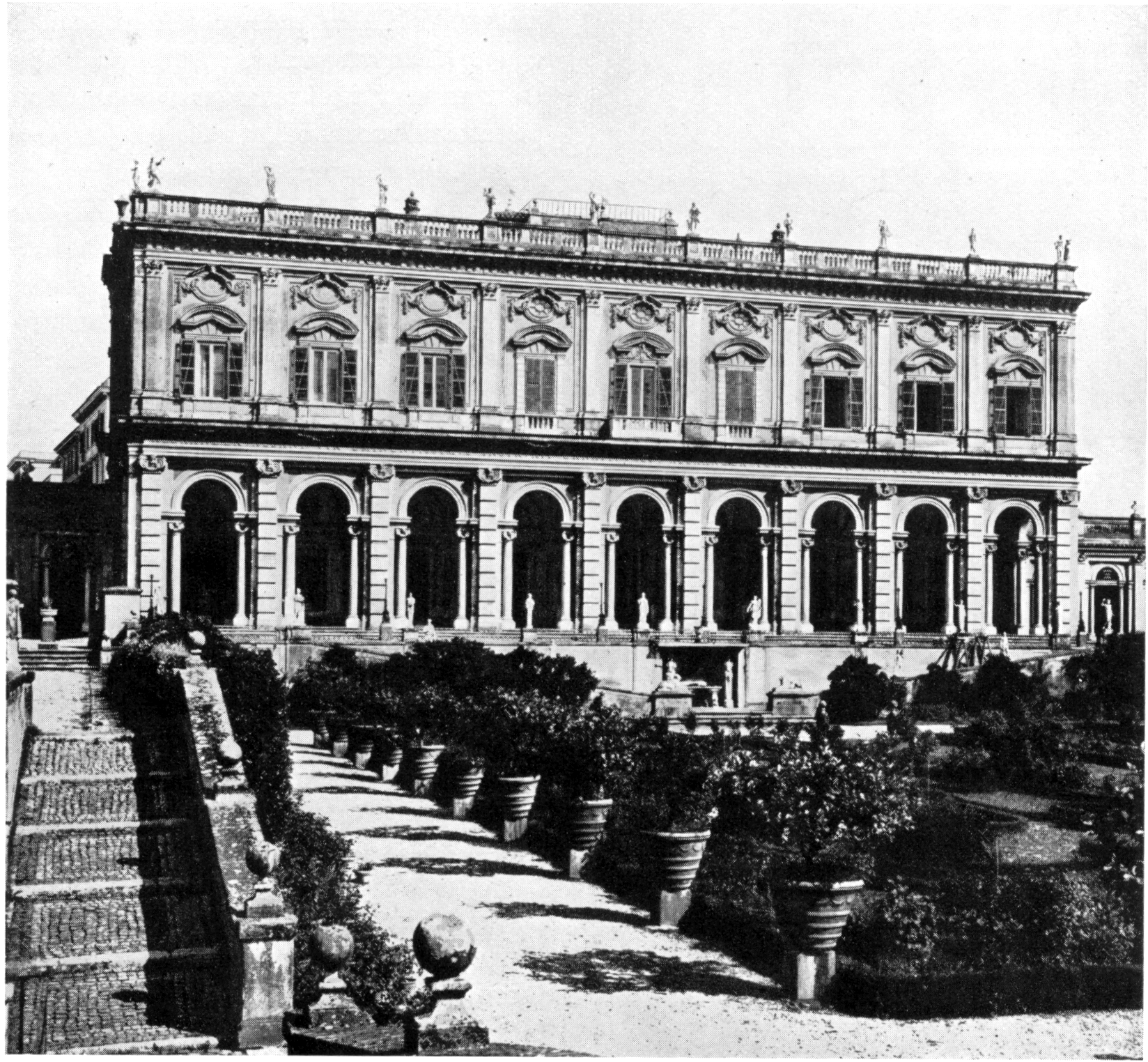
ASPIRAZIONI CLASSICISTE NEL LAZIO
Personaggio di prima piano nell'ambiente artistico e culturale romano ai tempi di J.J. Winekelmann fu Carlo Marchionni, architetto, scultore, caricaturista. Nato ad Ancona nel 1702, aveva un po' stentato a farsi notare, ma dopo aver compiuto, intorno al 1760, la Villa del Cardinale Alessandro Albani, come si è detto gran collezionista di sculture antiche, nonché protettore del Winckelmann, acquistò fama ed autorità. Così dopo aver dato i disegni del monumento a Benedetto XIII in Santa Maria Sopra Minerva fu creato Principe dell'Accademia di S. Luca nel 1775 mentre per conto di Pio VII, fra il 1776 e il 1784, costruiva la Sagrestia di S. Pietro. Morì il Marchionni ormai ottantaquattrenne a Roma nel 1786. Il Winekelmann ne aveva detto un gran bene dichiarando la Villa del Cardinale suo ospite munifico " la più bella fabbrica del nostro tempo ", ma, nel 1787, esaltando il Monumento a Clemente XIV nella famosa lettera allo Zulian, il Milizia poneva i Marchionisti con i Michelangiolisti, i Berniniani ed i Borroministi, fra i reazionari oscurantisti per aver ritenuto "il capolavoro del giovane Canova opera esecranda ". Che il Marchionni fosse un tradizionalista fedele al gusto del barocchetto romano lo dimostrano in pieno i lavori che abbiamo sopra citato. Il suo è un linguaggio architettonico di sapore quasi internazionale; è quello in voga nelle Corti d'Europa, con accenti alla Carlo Fontana di un borrominismo cioè, un po' diluito e tuttavia pieno di grazia e di eleganza nelle forme lunghette, nei pilastri slanciati, nei capitelli compositi adorni di festoncini di fiori e frutta. Nei giardini di Villa Albani vi sono balaustrate, erme, vasi di pietra certamente suoi, gustosissimi di disegno, e si vedono nel palazzo grande, e nella palazzina che è dietro l'emiciclo, e nei portici, certe soluzioni di dettaglio da ammirare senza riserve anche perchè rivelano le vivaci risorse di un mestiere posseduto fino al virtuosismo. Abile, elegante, raffinato doveva essere certamente un po' scettico Carlo Marchionni se si mostrò lieto di ostentare i portati di una erudizione d'accatto, con il suo fare un po' lezioso, inserendo, forse con qualche ironia, all'estremo delle ali del portico del Palazzo grande un prospetto con quattro antiche colonne scanalate e un timpano composto in gran parte con pezzi di scavo e coronato dì statue, pur esse antiche. Un prospetto di sapore addirittura archeologico che dovette molto piacere al Winckelmann per i cui sogni, lo stesso Marchionni, tra il verde del giardino, costruì perfino i ruderi di un tempietto preludendo ad un gusto dichiaratamente romantico, in armonia sia col Piranesi sia col più tardo Mario Asprucci.
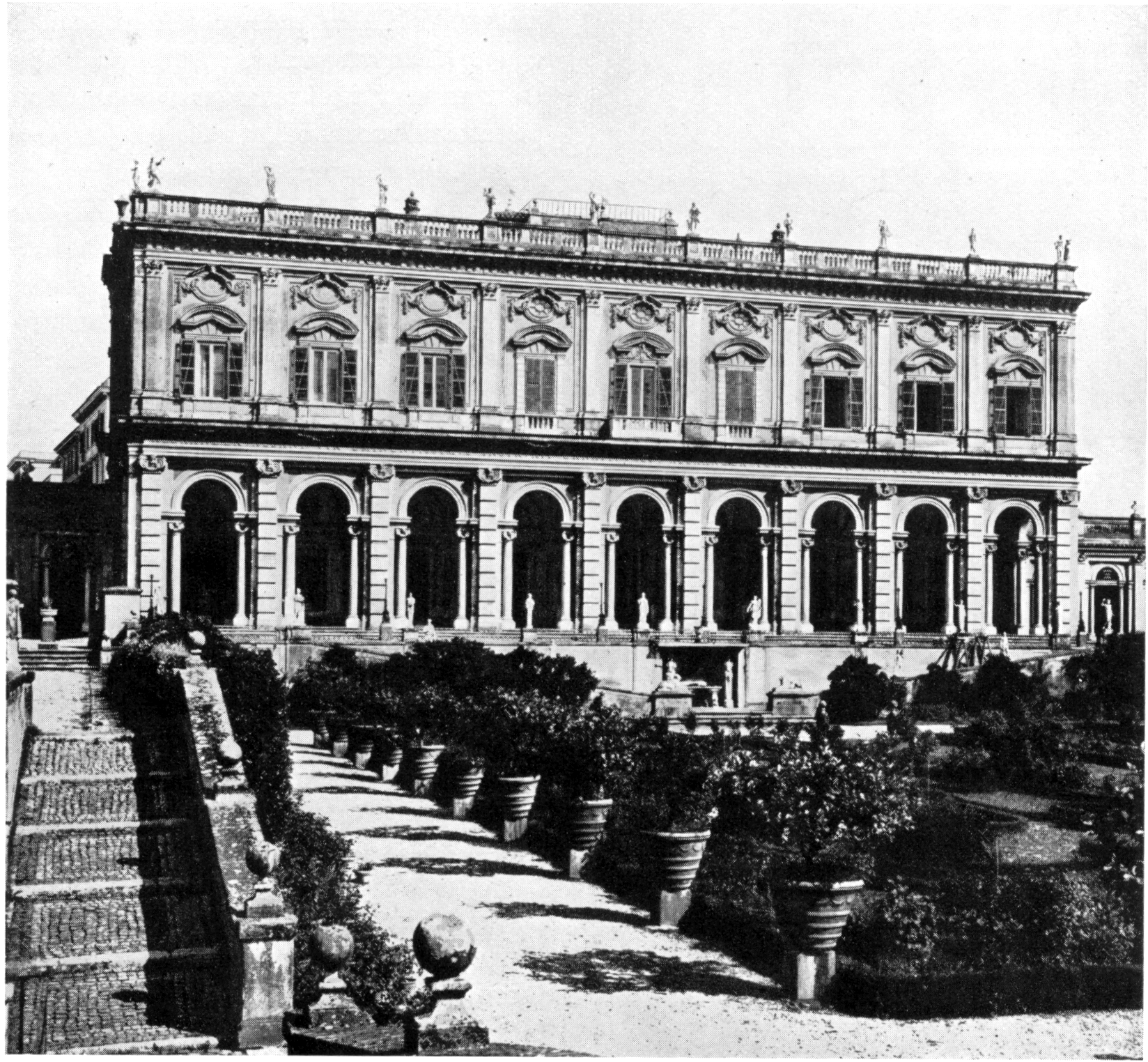
La Villa del Cardinale Albani
Esercitazioni queste del Marchionni che, in definitiva, confermano quasi dimostrazione per assurdo, il carattere fondamentalmente romantico del gusto neoclassico. Lasciando anche intendere con quale sorridente acredine i tradizionalisti dovessero compiacersi delle esercitazioni archeologiche del maestro il quale, con la stessa raffinata abilità, avrebbe potuto anche architettare un salottino alla cinese, persuasi come erano d'aver cosi scoperto il facile segreto del verbo neoclassico predicato dal Winckelmann e dai suoi seguaci. Ogni età indubbiamente ha i suoi Marchionni! Se dunque l'architetto di Villa Albani, morto Nicola Salvi nel 1751, Può rappresentare verso il 1760 la vitalità di una tradizione ancora operante, se non altro per l'accento internazionale del suo gusto, che è riferibile all'attività di un Michetti, morto nel 1759, e di un Chiaveri (1689-1770), il Gregorini (1700-I777), più fedele ai modi borrominiani e che ha il suo capolavoro nell'atrio di S. Croce in Gerusalemme, sembra invece portato ad esaurirsi in un decorativismo sempre più vuoto di significato. Decorativismo che è in netta opposizione anche con quel fare deliberatamente sobrio, semplice e castigato che s'affermava nelle opere romane di Alessandro Galilei (1691- I736) e di Ferdinando Fuga (1699-I781), nonché di Luigi Vanvitelli (1700-1773) che negli stessi anni costruiva la Reggia di Caserta, e in quei lavori che, sulla traccia sua, conduceva in Roma Carlo Murena (17I3-1764) architetto della sagrestia di S. Agostino. Con quel fare cioè, che par seguire la logica evoluzione delle forme architettoniche propria a chi, reagendo all'enfasi agli arbitri del barocco, tendeva a riallacciarsi al Vignola, o almeno ai più austeri cinquecentisti, in accordo con le idee che da anni andavano esprimendo, sulle orme dei Bellori, trattatisti e filosofi. Qui cade anche opportuno fare menzione di Carlo Vanvitelli (1739-1821) il figlio del grande Luigi, che, a Napoli, operando per la Corte dei Borboni, testimonia a lungo, accanto a Domenico Chelli, il gradimento che nell'ambiente napoletano continua ad avere la compostezza delle eleganti forme settecentesche. Idee simili, ma espresse con tono di maggior austerità, mostrano frattanto in alcune loro opere due altri architetti romani, attivi a Roma: Pietro Camporese il Vecchio, romano (1726- 1781), e Cosimo Morelli (1729-1812). A parte il rifacimento della chiesetta di S. Orsola del Convento di Via Vittoria a Roma, che all'interno - oggi adattato a piccolo teatro - è un delizioso ambiente bianco con squisitezza di particolari nell'attenta articolazione della sintassi architettonica; a parte ancora il completamento della facciata di S. Maria in Aquiro, dal Camporese costruita nel secondo ordine con accenti simili a quelli della cinquecentesca facciata di S. Maria dell'Orto, l'opera che meglio caratterizza il gusto architettonico del Camporese è forse l'antico Collegio Germanico con facciata in via della Scrofa tra la via S. Agostino e la via S. Giovanna d'Arco. Austero, malinconico, il grande blocco di costruzione è costituito da un basamento, ove si aprono, oltre il portone, numerose botteghe con gli stipiti sormontati da un arco ribassato. Sopra si stende uniforme la liscia parete, col paramento in mattoni "a faccia vista" dove, largamente spaziate, s'aprono le finestre con incorniciature, semplicissime, simili a quelle delle finestre della casa generalizia dei Gesuiti. E veramente un certo senso di architettura gesuitica emana da questo grande edificio così accigliato e severo, anche nell'interno, nel non vasto cortile ove tuttavia si possono cogliere accenti settecenteschi non privi di gentilezza, nelle soluzioni d'angolo del portico, nel finestrone del primo piano, simile a quello del prospetto di S. Maria in Aquiro, e fin nella fontana che, tuttavia, non si crede sia stata disegnata dallo stesso Camporese per il suo carattere tardo berniniano. Caratteri analoghi si colgono anche in un'altra opera, iniziata con solido impianto dallo stesso Camporese a Subiaco, dove egli eresse pure l'arco in onore di Pio VI, vale a dire il Duomo di quella cittadina e l'annesso edificio del Seminario. Un vastissimo complesso di edifici accastellati a grandi blocchi di muratura, giustapposti gli uni agli altri, come munitissima fortezza, e che dalla profonda valle dell'Aniene salgono fino al livello della via principale. Verso il presbiterio l'edificio assume il composito aspetto di tre chiese sovrapposte, la superiore delle quali, a livello della strada, ha una facciata a due ordini di gusto cinquecentesco. La costruzione, continuata dai figli Giulio e Giuseppe, e dal nipote Pietro Camporese il Giovane, di cui diremo più avanti, in più decise forme neoclassiche, ha forse, agli occhi nostri, il suo pregio maggiore nella felice organicità delle strutture eseguite in pietre e mattoni lavorati con una tecnica, di cui, dal '400, si era veramente perduto il gusto e la scienza. Dalle lisce uniformi pareti, per la mirabile maestria con cui sono lavorati i materiali, emana un senso di solidità, quasi di forte scarto di resistenza, che pur nella implacabile freddezza accademica è l'aspetto più caratteristico e nuovo del Camporese. Cosi il suo neocinquecentismo non impedisce al Camporese di trarre profitto nella misura del proprio gusto, sia da alcuni punti fondamentali delle nuove teorie architettoniche sia dalle esortazione del Winckelmann e degli altri teorici per un ritorno ai modi strutturali degli antichi.
Accanto al Camporese va ricordato Cosimo Morelli (1732-1812), da alcuni ritenuto, ticinese di Torricella ma detto l'Imolese per aver egli vissuto a lungo ad Imola, dove altri lo ritengono nato e dove è sepolto nella chiesa di S. Maria in Regola da lui trasformata. La sua opera più nota a Roma è il Palazzo Braschi fatto costruire da Luigi Braschi, nipote di Pio VI dopo che, fra il 1791 e il 1792 erano stati demoliti, per far luogo al grande edificio che sorge tra Piazza Navona e Piazza S. Pantaleo, l'antico Palazzo Santobono degli Orsini e varie case ad esso adiacenti. E’ una vasta costruzione a cinque piani di netta intonazione neo-cinquecentesca; grande, ma non grandiosa, anche per certo senso di freddezza accademica che per lo più si rivela nei particolari, specie nel grande portale del prospetto e nel balcone che lo sovrasta. La parte più notevole dell'edificio è, tuttavia, lo scalone, marmoreo sorretto da colonne e coperto da volte, decorate di stucchi e rilievi in parte neoclassicheggianti.

Palazzo Braschi e la chiesa di S. Pantaleo in restauro
Al Morelli stesso, che svolse una notevolissima attività nelle Marche, nella Romagna ed in Emilia, vanno poi assegnati i Duomi di Macerata, di Fermo, di Fossombrone e di Imola, il S. Francesco di Lugo, il restauro del Duomo di Ravenna e quello della facciata del S. Pietro di Bologna. Costruì il Morelli anche numerosi teatri, alcuni distrutti, quali quello di Tordinona a Roma, e quello di Imola, ed altri, che vennero più o meno adattati alle nuove esigenze, a Macerata, Jesi, Osimo e Fermo. Gli vengono assegnati anche alcuni palazzi: l'Anguissola a Piacenza, il Silvestri di Macerata e il Berio in Via Toledo a Napoli; suo è anche l'arco Trionfale che i Santarcangiolesi elevarono in onore di Clemente XIV all'ingresso della cittadina. Interessante per noi è anche un suo progetto per la sistemazione dei Borghi presso S. Pietro. Progetto pubblicato a stampa e detto anche Napoleonico perchè sembra dovesse essere attuato dall'Imperatore. Tale piano, rispetto a quello realizzato in questi ultimi tempi, aveva il vantaggio, pur prevedendo ugualmente la demolizione della "spina", di limitare le demolizioni a un più ristretto complesso di costruzioni, lasciando intatto il folto, interessante gruppo di case e vecchi palazzetti, ammassati tra l'ospedale di S. Spirito e il Passetto. Prevedeva inoltre il Morelli all'inizio della nuova arteria l'erezione di due portici tetrastili di netta intonazione neopalladiana. E di carattere neopalladiano, più che neoclassico, sono gli altri numerosi elementi architettonici ricorrenti nelle costruzioni morelliane fuori Roma a testimonianza delle sue aspirazioni classiciste.
Personalità caratteristica del suo tempo è anche Giovanni Stern, nato a Roma nel 1734 e morto nel 1794, che, dopo aver decorato con qualche intonazione classicista il Salone d'oro di Palazzo Chigi costruì una casa all'angolo di via della Stelletta con la piazzetta di Campo Marzio. Un edificio d'altronde modesto ed in seguito rimaneggiato. Ma lo Stern c'interessa soprattutto per la sua partecipazione alle idee allora correnti e da lui chiaramente espresse quando pubblicò nel 1784, con splendidi rami di vaste proporzioni, piante, elevazioni, profili e spaccati degli edifici della Villa Suburbana di Giulio III: " Speriamo che i giovani s'approfittino di si eccellenti esemplari e si rammentino d'aver sempre in vista, come fece il Vignola, la convenienza fra loro delle varie parti e dei vari ornati d'un istesso edificio, e i loro rapporti con gli ordini dove restano situati ". Fu con questi principi educato il figlio di Giovanni, Raffaele Stern, che, quando poté operare da vero architetto, applicò con esemplare integrità i principi neoclassici winckelmaniani. Ma prima di dire di Raffaele Stern e dei puri neoclassici sarà opportuno ricordare l'opera di altri maestri ancora, che nella loro stessa varietà ragguagliano sul gusto e sulle aspirazioni classiciste del tempo. Un'opera singolarissima, più in armonia con le approssimazioni archeologiche del Marchionni che con opere veramente meritevoli dell'attributo di neoclassiche, è la chiesa di S. Maria del Priorato sull'Aventino rimessa a nuovo da Giovan Battista Piranesi nel I765. Il Piranesi, su strutture di gusto cinquecentesco compose riquadrature e stucchi, esemplificati indubbiamente su antichi modelli, ma interpretati con una fantasia ed un senso del pittoresco del tutto settecenteschi. L'intonazione genericamente neoclassica dell'ambiente più che dagli elementi della decorazione deriva dal suo biancore, il che è certamente poco per ascrivere quell'opera al gusto neoclassico. Infatti, ed è bene chiarirlo ancora, meritano il nome di neoclassiche solo le opere che ripetono antichi motivi indagati con rigore e spirito archeologici. Per la stessa ragione non possiamo definire puramente neoclassica l'architettura che Giacomo Quarenghi compose con chiari accenti palladiani, rivestendo l'interno dell'antica chiesa dei Monastero di S. Scolastica a Subiaco l'anno 1769.

La chiesa di S. Maria del Priorato

Particolare della facciata
Era nato il Quarenghi a Valle Irnagna presso Bergamo nel 1744. Recatosi a Roma aveva studiato pittura prima con il Mengs poi con Stefano Pozzi, aveva quindi lavorato con Paolo Posi, ma, appassionato del Palladio e imbevuto delle nuove idee che il Mengs stesso e il Winckelmann propagavano, si era dato a viaggiare tutta l'Italia studiando e disegnando edifici antichi. I frutti di quelle sue esperienze li colse più tardi quando, dopo essere stato in Francia ed Inghilterra, nel 1779 se ne andò in Russia alla Corte dì Caterina II, di cui, presto, divenne l'architetto preferito. Ed in Russia rimase anche sotto Paolo I ed Alessandro I, fino alla morte, avvenuta nel 1817, costruendo chiese, ville, teatri, palazzi, archi trionfali, con un linguaggio architettonico esemplificato sui disegni ed i rilievi pubblicati dagli studiosi di antiche architetture. Un linguaggio architettonico quello del Quarenghi, in Russia, di gusto neoclassico, indubbiamente, ma di un neoclassicismo eclettico non derivato da precisi e individuabili modelli, ma da elementi tratti da vari repertori, per cui assunse un tono generico ed impersonale malgrado la grandiosità delle masse disposte con larghezza di concezione e vero senso architettonico. Che, d'altro canto, l'opera di Quarenghi a Subiaco rappresentasse quasi un frutto fuori stagione in un ambiente ad essa estraneo - il suo vero ambiente sarebbe stato, negli stessi anni, il Veneto dove, come vedremo, imperavano i neopalladiani, - lo dimostra anche la scarsa eco che la chiesa del Monastero Sublacense ebbe nell'ambiente romano, dove le idealità più propriamente neoclassiche andavano, nello stesso giro d'anni, precisandosi.