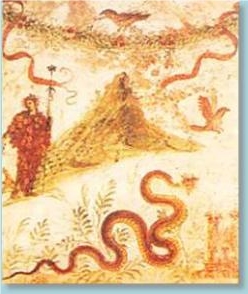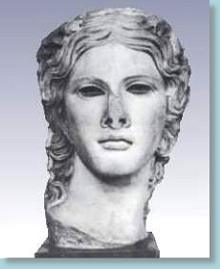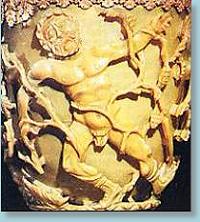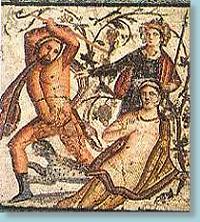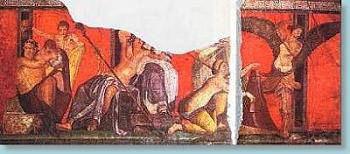Dioniso, un breve
escursus
Il Culto di Dioniso
fu molto diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, da oriente ad
occidente, comprendendo Asia ed India, Nord Africa, Penisola Greca
inclusa la Macedonia e la Penisola Italica.
Il culto di questa divinità si
perde nella notte dei tempi; più tardi approdò a Roma e
quindi alle terre da essa controllate.
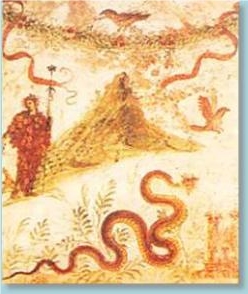 |
Dioniso, rivestito
di pampini, e il Vesuvio, con un serpente in primo piano, quale simbolo
di fertilità.
Affresco
del I sec., dalla
Casa del
Centenario
a Pompei.
Napoli, Museo
Archeologico Nazionale
Dioniso (come altre
divinità Greche), ebbe
diversi nomi ed appellativi che seguivano il nome a
seconda dei luoghi nei quali era onorato; a Roma era noto come Bacco
o Libero, in Oriente come Zagreo
o Bassareo o anche Leneo.
Il suo aspetto era sempre
quello di un giovane bellissimo, con il capo riccioluto e incoronato da
pampini e da viticci.
.
Dio gioviale, sorridente e simbolo del
tripudio e della
ricchezza della natura, legato a riti rimasti abbastanza misteriosi e
talora
selvaggi, che attestano anche la sua vicinanza con antichissimi riti in
cui si usava propiziare il favore della
natura mediante sacrifici di animali.
|
Fra i suoi
adepti si registrano soprattutto donne (baccanti o mènadi),
ma anche creature semiferine come Satiri e Sileni, ciò che
sottolinea
il carattere virtualmente ‘sovversivo’ o ‘alternativo’ del culto
dionisiaco. Elementi fondamentali di tale culto sono lo sparagmós e l’homophagía
(smembramento rituale di una bestia divorata cruda). Nonostante questa
caratterizzazione, lontana dai comuni valori civici e sociali,
importanti feste pubbliche sono dedicate al dio in tutte le poleis:
ad Atene,
in particolare, le Antestèrie
primaverili, le Lenèe e le Dionisie,
con agoni tragici, comici e ditirambici, posti sotto il controllo del
dio Dioniso, che come tale è considerato il dio patrono del
teatro.
Tipici simboli dionisiaci (oltre al viticcio e all'edera
rampicante) sono il tirso (bastone di abete, ornato da
tralci di edera e di vite), la nèbride (in greco nebrís,
pelle di capriolo adibita a mantello), la maschera, il fallo di cuoio (esibito ad Atene
durante la processione delle Fallofòrie).
All’iconografia del dio appartengono animali
come il toro, il leone, la pantera e il capro, emblemi della vita selvaggia
con cui
gli adepti entrano in comunione grazie alla manía
(«follia», «invasamento») dionisiaca. Culti
privati di Dioniso furono tipici delle associazioni dette tìasi,
specie in età ellenistica. Il dio, probabilmente in
virtù del carattere
orgiastico del suo culto, fu adottato dagli orfici (sedicenti seguaci
del leggendario Orfeo) come una delle divinità più
importanti della
loro mitologia: in questo modo Dioniso (spesso con il nome di
Zàgreo)
assume caratteri iniziatici ed escatologici (cioè legati alla
promessa
di una ‘salvezza’ dopo la morte) che non appartengono originariamente
alla sua figura.
|
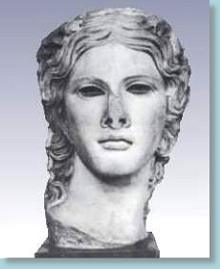 |
Attributi dionisiaci: tamburello,
tirso, cembali, cantaro, cista; in primo piano pantera che lotta con
serpente.
Affresco del I sec., da
Pompei.
Napoli, Museo Archeologico Nazionale |
Testa di Dioniso giovane.
Scultura ellenistica
ritrovata nei pressi di Roma.
Londra, British
Museum |
NASCITA DI DIONISO
Secondo il mito più
diffuso, Dioniso è figlio di Semele (una mortale) e di Zeus e
nasce a Tebe.
Semele fu incenerita per aver voluto,
dietro istigazione di
Era gelosa, vedere l'amante in tutto il suo fulgore, non considerando
che solo agli Olimpi era permesso di osservare il vero volto di Zeus; e
Dioniso, non ancora nato, rischiò di perire con la madre.
Allora Zeus tolse il figlio dal grembo di lei e lo cucì in una
sua
coscia finché la gestazione fu completata; poi portò il
bambino a Nisa,
dove le Ninfe lo nutrirono con miele.
(Le ninfe nutrici di Dioniso
diventarono più tardi le stelle della costellazione delle Iadi.)
VITA DI DIONISO
Una volta cresciuto il dio
errò per ogni dove, accompagnato nel suo peregrinare da Sileno,
dai Satiri, dalle Ninfe e dalle Menadi, o Baccanti, a volte su un carro trainato
da pantere. Lo troviamo così in Tracia da dove, per sfuggire al
re Licurgo che voleva imprigionarlo, si rifugiò presso la
nereide Teti, la quale
gli diede rifugio in mare.
Giunto nell'isola di Nasso vi trovò
Arianna,
lasciata da Teseo
dopo la loro fuga da Creta, dove la fanciulla aveva aiutato l'eroe
nell'impresa per uccidere il Minotauro; innamoratosene, Dioniso la
sposò e la portò con sé.

Dioniso con Arianna a Nasso. Vetro a
sbalzo del I sec.
dalla Casa di Fabio Rufo a Pompei.
Napoli, Museo Archeologico Nazionale
Le nozze di Dioniso ed Arianna. Affresco del
I sec.,
nella Villa dei Misteri a Pompei
In Orcòmeno rese
invasate le Miniadi, che prese da una
strana pazzia, uccisero il figlio di una di loro scambiandolo per la
vittima sacrificale del rito in onore del dio; e una tragedia simile
capitò al re di Tebe, Penteo, ucciso e fatto a pezzi dalle donne
invasate, compresa la sua stessa madre, alle quali voleva impedire di
recarsi sui monti per onorare Dioniso.
Un giorno nel suo
continuo errare fu trovato dai pirati
che lo rapirono per venderlo come schiavo in un mercato d'Oriente;
Dioniso allora trasformò i loro remi in serpenti e
paralizzò la nave
con ghirlande d'edera e di vite, cosicché i pirati, impazziti si
gettarono in mare dove diventarono delfini (il che spiega come i
delfini siano amici degli uomini, e si sforzino di salvarli, nei
naufragi, poiché sono pirati pentiti).
Anche Orfeo, il
più antico cantore della Grecia, si
inserisce nel mito di Dioniso. Orfeo disdegnava il dio del vino ed era
devoto solo ad Apollo, che adorava chiamandolo dio del Sole; per questo
Dioniso gli istigò contro le Menadi che, invasate dalla furia
ispirata
loro dal dio ne straziarono il corpo e lo smembrarono; le Muse di
Apollo composero poi i resti del cadavere e gli diedero una conveniente
sepoltura. Ad Orfeo si legherà poi l'Orfismo, un'espressione
oscura e
difficile del pensiero filosofico.
Nel corso delle feste
dionisiache, o baccanali, si era
soliti sacrificare un caprone, e il rito sacrificale era accompagnato
da canti corali e da battute che in forma di dialogo venivano scambiate
dai sacerdoti. A questo aspetto del rituale i pensatori greci
riconducono l'origine della tragedia (individuando l'etimologia, nel
termine tragedia "il canto del capro"), destinata nella Grecia classica
a diventare una delle forme più alte e complesse di poesia.