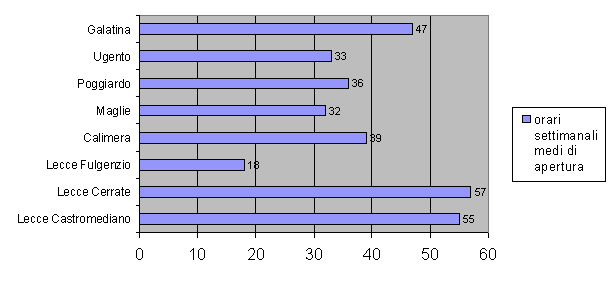
Nuove forme di offerta culturale locale
Il "sistema museale" salentino
Introduzione
Le funzioni essenziali della politica dei beni culturali (tutela – gestione – valorizzazione), fino a poco tempo fa sostanzialmente centralizzate, hanno sempre contrastato con in tratti distributivi che caratterizzano il patrimonio storico-artistico dell’Italia: rispetto ad altri Paesi, infatti, la nostra realtà continua a distinguersi da una parte per il livello di accentramento nella proprietà e nella gestione di beni culturali (in Italia i musei di diretta gestione statale sono 462, in Francia 34, in Spagna 22, in Gran Bretagna solo 19[1]), dall’altra per la peculiarità nella distribuzione del patrimonio artistico.
Sono spesso i tecnici della tutela a difendere l'impostazione tradizionale per ragioni pratiche e di efficacia, più che ideologiche: uno Stato che si fa carico della tutela garantirebbe, nell’assolvimento di questa funzione, una maggiore “distanza scientifica” rispetto agli enti locali, rivelandosi così da parte degli stessi tecnici un particolare interesse non tanto all’unicità e all’uniformità del governo, ma alla sua impermeabilità alle ragioni contingenti e locali del consenso[2].
In merito ai vantaggi del decentramento, le riserve si basano soprattutto sull’osservazione che gli interessi particolaristici che possono intralciare la tutela non agiscono soltanto a livello locale, ma spesso sono in grado di organizzarsi sul piano nazionale e di condizionare le scelte dello Stato centrale, mentre le adesioni poggiano sulla constatazione di come il sistema centralizzato di distribuzione delle risorse si sia nel tempo rivelato inefficiente.
Si sottolinea, inoltre, come la politica dei beni culturali non debba essere solo conservativa e di tutela, ma anche di valorizzazione del bene e di promozione: bisogna perciò conciliare l’apporto di “imparzialità” che l’accentramento può garantire alla tutela con l’importanza dei contesti connessa con la valorizzazione.
1. - I motivi economici del decentramento
Con la crisi della finanza pubblica sono diventate sempre più importanti le forme di autofinanziamento dei beni culturali, derivanti sia dagli utenti e dai consumi turistici che da collaborazioni con i privati. L’estensione stessa del discorso economico alle organizzazioni culturali si accompagna a un preciso orientamento di policy, condiviso a livello europeo, verso processi di privatizzazione o quanto meno destatizzazione delle istituzioni della cultura. Resta il rischio di produrre, con il decentramento e l’esternalizzazione, un’asimmetria tra le regioni “ricche”, che ricevono maggiori afflussi di turisti e nelle quali esiste una maggiore disponibilità dell’impresa privata ad investire nel patrimonio culturale e le altre che potrebbero permanere nell’attuale stato di povertà[3].
La legislazione dell’ultimo decennio ha segnato, relativamente all’intera materia degli enti locali, un’inversione di rotta in favore del decentramento e dell’autonomia (l. 142/1990), intento rafforzato dalla riforma amministrativa avviata con le leggi Bassanini (l. 59/1997 e l. 127/1997) che contempla fra i principali obiettivi quello del trasferimento di funzioni dal centro alle periferie.
Sebbene questi impulsi di riforma siano partiti da altre esigenze, la prospettiva del decentramento, che ha coinvolto i beni culturali (d. lgs. 112/1998), potrebbe rivelarsi importante per le istanze di rinnovamento di questo settore, che di decentramento e articolazione ha effettivamente bisogno.
I fondamenti economici della riforma in questo settore, come negli altri in cui interviene l’operatore pubblico, sarebbero quelli del federalismo fiscale e del principio di sussidiarietà, esplicitamente riportato nel decreto 112/1998.
Gli studiosi del settore sottolineano il bisogno di strutturare l’intervento pubblico relativo alle attività e ai beni culturali, in modo da distinguere gli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti a livello centrale da quelli che possono essere riservati a strutture decentrate (enti locali, soggetti privati, terzo settore). Tra i primi si individua la tutela, che implica la garanzia della conservazione del patrimonio in vista del godimento presente e futuro di questo da parte della comunità, e che, ragionevolmente, fa capo a strutture centrali: tra i secondi, c’è la gestione, che incontra a livello locale la domanda dei fruitori come singoli e come collettività.
In parte la riforma ha rispecchiato queste esigenze: l’art. 150 del d. lgs. 112/1998 infatti prevede il trasferimento, deciso in base al principio di sussidiarietà, agli enti locali della gestione di “musei e altri beni culturali”. Gestione e non tutela, dunque, conformemente a quanto sopra detto: ma da più parti si è osservato che la definizione che il legislatore adotta riguardo al concetto di tutela è particolarmente lata, e rafforzata dalla funzionalizzazione ad esso dell’accezione del termine gestione[4]. Già nel dettato legislativo, dunque, la portata della riforma rischia di rimanere limitata in una prospettiva centralistica persistente e la politica dei beni culturali sembra rimanere nella sfera “conservativa” cui sopra si faceva cenno, senza allargarsi alla valorizzazione. Non è previsto, accanto al trasferimento della gestione, anche quello della titolarità dei beni agli enti locali e questo favorisce una scelta “reversibile”, permettendo all’azione di riforma di superare le critiche da parte dell’opinione centralista a lungo dominante. Questo modo d’agire, d’altro canto, non taglia i ponti con il passato, ed in questo modo non stabilisce una chiara linea di policy.
Altra novità introdotta dal d. lgs. 112/1998 è il concetto di “standard” minimi di gestione, individuati dal Ministro dei Beni culturali con decreto proprio. L’obiettivo è di riprodurre nel quadro delle istituzioni culturali italiane una procedura già affermata nell’esperienza museale di vari Paesi europei, cioè quella di condizionare l’accreditation o la registrazione di un museo (in questo caso, il trasferimento della sua gestione all’ente locale) al possesso di prerequisiti essenziali per la fruizione collettiva.
Il presupposto implicito è che ai beni che restano assegnati allo Stato sia comunque assicurata una qualità di gestione sufficiente, e che la normativa abbia funzione di salvaguardia del patrimonio culturale e della sua fruizione nei casi in cui avvenga il trasferimento di gestione agli enti locali.
Nell’intento legislativo si fa dunque riferimento ad un profilo istituzionalizzato del bene culturale, tipicamente espresso nel museo tradizionalmente inteso piuttosto che al museo diffuso; d’altra parte, inquadrare quest’ultimo da un punto di vista giuridico è opera ardua. Viene comunque sottolineata “la particolare connessione sussistente fra il museo come istituto (competente per il 'deposito' organizzato della memoria, la sua analisi e la sua ostensione a fini educativi) ed il territorio come "museo diffuso", che può essere goduto e rispettato soltanto se trova nel museo-istituto una sede idonea di interpretazione e comunicazione dei propri valori”[5].
Può essere considerata un passo avanti su questa strada la nuova e più estesa definizione di bene culturale[6]contenuta nel decreto legislativo 240 del 29 ottobre 1999, che riordina in un testo unico l’intera disciplina, e il conseguente ampliamento dell’ambito della tutela a fotografie, spartiti musicali, opere cinematografiche e altre “testimonianze aventi valore di civiltà”. Il nuovo testo attribuisce agli enti locali un ruolo specifico nella cura della catalogazione dei beni presenti nei territori di loro pertinenza, e riguardo alla fruizione stabilisce, per i beni di loro proprietà, la possibilità di appaltare anche a privati i servizi di assistenza culturale e di ospitalità, quelli di pulizia, vigilanza, biglietteria, inserendo e razionalizzando in un contesto unitario quanto già previsto dalla legge Ronchey.
2. - Forme possibili e problemi connessi all'offerta culturale
Le istanze di riforma amministrativa, il lungo dibattito sull’alternativa pubblico-privato riguardo alla titolarità e concreta gestione delle strutture museali, le peculiarità della distribuzione dei beni culturali in Italia portano a delle riflessioni sulle forme che l’offerta culturale può assumere. Cercheremo di tracciare degli scenari sui possibili sviluppi del decentramento in una realtà come quella italiana, con le sue connessioni al territorio.
Indicheremo alcune possibili forme di offerta: la prima, già in corso di sperimentazione a Napoli, è quella detta del museo “aperto”e sulla quale non ci soffermeremo visto che è già stato oggetto di numerosi e recenti studi ( vedi anche Santagata-Signorello, Economia della Cultura, n.2/2000); la seconda, quella del “polo culturale”, è stata per molte strutture di offerta culturale il frutto di una evoluzione spesso spontanea ed economicamente necessaria che ha portato all’aggregazione funzionale e all’espansione delle attività; l’ultima rappresenta una fase ulteriore di questo sviluppo e, in analogia con una realtà produttiva diffusa in Italia, è definita “distretto culturale”.
2.1 - Il polo culturale
Il modello gestionale denominato “polo culturale” si riferisce ad un sistema integrato di offerta che consta di differenti strutture: tipicamente è composto dal trinomio museo – biblioteca – teatro, elementi analoghi che vengono aggregati funzionalmente.
È il caso di numerosi musei di tipo composito, accorpati a biblioteche, pinacoteche, etc, situati in importanti edifici monumentali, risultato di un’evoluzione che consente da una parte la conservazione di un patrimonio storico artistico (i siti del museo) e dall’altra lo svolgimento delle tradizionali funzioni dell’istituzione museale. Ma la creazione di un polo culturale innesca un ulteriore processo produttivo di servizi, al di là della pura funzione di tutela e di custodia delle opere e del loro contenitore. In un’analisi di questa particolare forma di offerta culturale, Pronti e Boccenti tratteggiano un’interazione tra la struttura e il territorio tale che “da un processo di sviluppo delle conoscenze basato sul rispetto della storia, dell’arte e di tutte le forme di espressione di una cultura anche locale possono originarsi numerosi percorsi culturali che difficilmente si potrebbero concretizzare e centralizzare all’interno dell’“edificio museo”, ma che è bene si sviluppino all’esterno”. Nasce così “un ulteriore strumento di sviluppo conoscitivo che stimola differenti percorsi culturali generando una cultura della conservazione capace di originare sul territorio ulteriori servizi anche per iniziative di singoli soggetti sensibilizzati e motivati. Da una corretta gestione dei musei cittadini può quindi nascere una nuova cultura della conservazione e della valorizzazione [7]
2.2 - Il distretto culturale
Uno degli orizzonti che il decentramento potrebbe aprire, mettendo in risalto le potenzialità proprie del territorio, è quello dei “distretti culturali”.
Si discute molto, infatti, delle opportunità che derivano dall’istituzione di reti o sistemi museali, per ovviare agli squilibri gestionali che le dimensioni medio-piccole della maggior parte dei musei di ambito locale possono causare, ridimensionando l’apporto positivo del decentramento.
Una delle ipotesi più stimolanti appare quella della “distretto culturale”, che adotta strumenti di analisi analoghi a quelli usati per studiare il distretto industriale[8].
In base a determinate condizioni di omogeneità, il sistema museale potrebbe infatti profilarsi come “club di prodotto”, qualificando così la sua offerta nei confronti dell’utente e avvalendosi dei vantaggi economici del networking: la possibilità di garantirsi rifornimenti e gestione di inputs come gruppo di acquisto (avvalendosi di migliori condizioni di vendita) e la condivisione di risorse e la ripartizione di costi che in questo modo ne seguirebbe.
Il sistema museale dovrebbe agire come strumento di intervento per attivare meccanismi che segnalino ai potenziali utenti la qualità dell’offerta. Ne segue la necessità di certificare tale qualità per dare credibilità al segnale, cioè di stabilire degli standard di offerta differenziali dei sistemi, in base ai quali il pubblico abbia modo di distinguere le istituzioni che partecipano al sistema da quelle che ne sono escluse.
L’idea alla base di questa analogia teorica è che un modello che ha avuto buoni risultati in contesti industriali estremamente “diffusi”, può, con meccanismi di funzionamento simili, avere successo in un’economia come quella museale italiana che, a livello locale, presenta la stessa “polverizzazione”.
La nascita, in comuni medio-piccoli, dei “poli culturali” multifunzionali cui sopra si è accennato (museo-biblioteca-centro di attività di promozione culturale) conferma, per un altro verso, la spontanea ricerca di economie di scala da parte degli operatori. Naturalmente la creazione di distretti culturali richiede passi ulteriori, come l’individuazione di un bacino potenziale di utenza, e la presenza di condizioni base come l’omogeneità del prodotto offerto, dal punto di vista della sua “produzione” economica, se non addirittura delle sue caratteristiche storico-culturali (elemento che è possibile ritrovare in molte aree d’Italia, legate da passati comuni).
La rete museale italiana è ampia e articolata in una distribuzione non uniforme sul territorio. L’insieme delle istituzioni è amministrato da varie categorie di soggetti (Stato, Enti locali, Enti ecclesiastici, privati) tra i quali raramente vengono stabilite le connessioni necessarie per instaurare modalità gestionali “su base reticolare d’area, orientate alle esigenze della fruizione piuttosto che a quelle dell’amministrazione[9]”.
In questo contesto il modello del museo civico rappresenta una parte importante dell’offerta culturale a livello locale. È significativa l’evoluzione in vari casi registrata verso la creazione di sistemi civici, dei poli culturali cui sopra si è fatto cenno, per l’integrazione dei servizi culturali da fornire a bacini d’utenza individuati territorialmente.
Proprio il museo civico, che per molto tempo e ancora oggi si presenta come centro di costo per le amministrazioni locali, può, grazie alla maggiore autonomia derivante dal decentramento, diventare una struttura in grado di autodefinire i propri strumenti operativi e professionali, e parte delle scelte culturali e organizzative. Questa attitudine richiede necessariamente un’ottica “aziendale”, attenta alla valutazione dei servizi museali non solo a livello sostantivo ma anche in termini di efficacia ed economicità, e ad evidenziare le ricadute dell’attività del museo sul territorio.
3. - L’offerta culturale del Salento
La scelta di redigere un caso studio sui musei dell’area salentina (riconducibile, con buona approssimazione, ai confini della provincia di Lecce) è stata guidata dall’ambizione di aggiornare da una parte la mappa dei musei fruibili nella zona, e dall’altra di contribuire a descriverne la realtà museale, con le sue articolazioni, in un momento di trasformazione in cui molti musei stanno attraversando o hanno appena attraversato una fase di ristrutturazione.
Oggetto dell’indagine, oltre ai musei presenti nella zona, sono anche le biblioteche comunali ad essi collegate. Trattandosi infatti di piccoli centri, per ragioni di spazio e di economicità di gestione, le due strutture sono spesso collocate nello stesso edificio (di solito un complesso architettonico di pregio, come il “Palazzo della Cultura” a Galatina, il secentesco Palazzo ducale a S. Cesario, etc.), se non proprio accorpate le une alle altre, e gestite dallo stesso personale (cooperative o addetti comunali: a volte si giunge al limite di un solo addetto per entrambe le strutture).
Considerando non un singolo museo, né i musei presenti in una singola città, ma l’offerta museale di un’area piuttosto vasta, composta da istituzioni di diverso genere (musei archeologici, storici, artistici, antropologici, naturalistici) si può parlare di “sistema museale”, nel quale si “cristallizzano” le varie fasi storiche e culturali della zona. Per questo, per la stretta connessione del museo con le altre istituzioni culturali locali (biblioteche, mediateche) e per altri motivi di seguito esposti, tale realtà potrebbe essere definita, più che offerta museale, offerta culturale del Salento.
Il patrimonio storico artistico dell’area è legato al succedersi di civiltà che ne hanno caratterizzato la storia: per l’antichità le testimonianze più importanti sono relative alla civiltà messapica, insediatasi nella penisola intorno al V sec. a. C., alla presenza greca e alla successiva dominazione romana; il medioevo ha lasciato rilevanti tracce soprattutto per quel che riguarda l’arte e l’architettura religiosa (chiese romaniche caratterizzate in particolare dall’influenza bizantina dovuta alla permanenza dei monaci basiliani nella zona); il ‘600 e la dominazione spagnola sono testimoniati dalle fortificazioni lungo le coste e dall’abbondanza di palazzi e chiese barocche in buona parte dei centri storici. Nel Salento il barocco ha assunto connotazioni sue proprie anche per le particolari proprietà dei materiali usati nelle decorazioni (pietre locali come il carparo e la così detta pietra leccese).
Oltre all’arte dei secoli passati, altri fattori che definiscono l’offerta culturale del Salento sono i reperti preistorici, ritrovati specialmente nell’area meridionale, che interessano studi paleontologici e paletnografici (Musei di Maglie ed Ugento), le testimonianze della cultura locale, cristallizzate nelle numerose “masserie” che punteggiano la campagna salentina (la maggior parte delle quali sono in disuso), e custodite nei musei di cultura contadina (Museo Provinciale di Squinzano – Abbazia di Cerrate, Museo di Presicce, Museo di Tuglie); la storia naturale (Musei di Calimera, Lecce a Fulgenzio, Porto Cesareo, Nardò, che documentano il legame che la popolazione locale ha sempre avuto con il mare e la pesca, vissuta non solo come risorsa economica ma anche come forma di cultura).
In alcune aree industriali dismesse (distillerie di S. Cesario) sono in progettazione musei di “archeologia industriale”, documentazione del passato economico prossimo della zona.
3.1 - La fruibilità
Sembra opportuno tracciare un quadro generale degli elementi che costituiscono l’offerta culturale di Lecce e provincia in termini di musei e strutture analoghe: per questo nella Tabella 1 sono riportati tutti i musei, le biblioteche e le pinacoteche della provincia, ripartiti secondo la loro posizione giuridica (proprietà statale, provinciale, comunale, privata: non sono presenti musei regionali).
Il numero complessivo di elementi riportati è 30. Una dettagliata indagine ISTAT del 1995 (Indagine sui musei e istituzioni similari, 31-12-1992) conta trentadue tra musei, biblioteche e raccolte[10]. Confrontando i dati attuali con quelli dell’indagine ISTAT del 1995, uno dei tratti che è possibile evidenziare immediatamente è la “natimortalità” dei musei salentini.
Tabella 1: I musei, le biblioteche, le pinacoteche della provincia di Lecce secondo la loro posizione giuridica
| Comune | Museo, Biblioteca, Pinacoteca | al 31/12/1992 (a) | al 2000 (b) | Orari settimanali di apertura | ||
| Statali | ||||||
| Lecce | Anfiteatro romano | X | X | |||
| Copertino | Castello | X | X (per restauro) | |||
| Otranto | Castello | X | X (per restauro) | |||
| Provinciali | ||||||
| Lecce | Museo "S. Castromediano" | X | X (ristrutturazione) | |||
| Biblioteca "N: Bernardini" | X | X (ristrutturazione) | ||||
| Museo delle tradizioni popolari "S. Maria di Cerrate" | X | X | 57 | |||
| Comunali | ||||||
| Alezio | Museo Civico Messapico | X | X (per restauro) | |||
| Calimera | Museo di Storia Naturale | X | X | 39 | ||
| Copertino | Museo etnologico | X | X | A richiesta | ||
| Cutrofiano | Museo Comunale della Ceramica | X | X | A richiesta | ||
| Galatina | Museo d'arte "P. Cavoti" | X | X | 47 | ||
| Gallipol | Museo Civico | X | X (per restauro) | |||
| Maglie | Museo Paleontologico e Paletnologico "D. de Lorentiis" | X | X | 32 | ||
| Nardò | Museo del Mare | X | X (restauro-allestimento) | |||
| Parabita | Pinacoteca Comunale | X (restauro-allestimento) | ||||
| Presicce | Museo Civico della civiltà contadina | X | A richiesta | |||
| Poggiardo | Museo della civiltà messapica | - | - | X | 36 | |
| Museo delle Cripte | X | X | 9 | |||
| S. Cesario | Museo Civico | X | X (ristrutturazione) | |||
| S. Pietro in Lama | Museo Civico del Lavoro contadino | X | ||||
| Surbo | Museo Civico | X | ||||
| Specchia | Museo Civico | X | ||||
| Ugento | Museo Archeologico | X | X | 33 | ||
| Porto Cesareo | Stazione di Biologia Marina | X | X (in allestimento) | |||
| Privati | ||||||
| Campi Salentina | Museo Pirrotti | X | X | (a richiesta) | ||
| Lecce |
Biblioteca “R. Caracciolo” e Pinacoteca d’arte francescana |
X | X | 18 (orario ridotto per esigenze di catalogazione) | ||
| Museo Missionario Cinese | X | X | 15 (e su richiesta) | |||
| Parabita | Museo del Manifesto | X | ||||
| S. Cesario | Museo “E. Leandro” | X | X | 6 (e a richiesta) | ||
| Tuglie | Museo della Civiltà Contadina | X | X | (a richiesta) | ||
| Totale strutture | Aperti su totale | Aperti su totale | Orari medi di apertura* | |||
| Anno 1992 | Anno 2000 | 23/29 | 15/30 | 34.625 | ||
| 29 | 30 | |||||
*Nel computo degli orari medi di apertura sono esclusi i
musei a fruibilità limitata, cioè visitabili su richiesta o comunque aperti
al pubblico per meno di 15 ore settimanali.
Fonti: (a) Indagine sui musei e le istituzioni similari, 31-12-1992, ISTAT 1995
(b) dati propri.
3.1.1 - Apertura e chiusura
Rispetto alle rilevazioni dei primi anni ’90 si può notare:
·la riapertura dopo alcuni anni di inattività di un solo museo, quello di Galatina, inserito in un complesso che comprende anche la biblioteca e la mediateca comunali, e che può essere accostato al modello di polo culturale;
· l’apertura di un nuovo museo, quello di Poggiardo-Vaste, dedicato alla civiltà messapica;
· la chiusura di sei musei e due complessi monumentali (castelli di Copertino e Otranto) su un totale di trenta elementi[11].
Ciò che si evince è che il potenziale di offerta museale in parte non raggiunge il pubblico per l’effettiva impossibilità di accesso. Rispetto al passato la situazione sembra non essere migliorata: per quanto grossolano, il dato fornito dal numero di musei aperti sul totale appare indicativo di una situazione critica: nel ’92 erano visitabili 23 strutture su 29, oggi solo 13 su 30 (considerando il nuovo museo di Poggiardo). A mitigare la rilevanza negativa di questo quadro si può sottolineare che alcuni musei chiusi lo sono solo temporaneamente, come sopra si accennava, e che dal punto di vista qualitativo, alcuni dei musei oggi aperti hanno migliorato i loro standard di fruizione in seguito a ristrutturazioni intervenute negli ultimi anni (Maglie, Ugento, Galatina).
3.1.2 - Gli orari
Il problema del ridotto orario di apertura è una conseguenza logica delle dimensioni spesso molto ridotte dei musei e della scarsa attrattiva che esercitano al di là del territorio strettamente adiacente. Bisogna poi considerare che buona parte dell’utenza è costituita da scolaresche, e quindi la modalità di fruizione più rilevante è quella della visita guidata, per la quale è sufficiente che il museo metta a disposizione del personale appositamente per l’occasione, senza il bisogno di sostenere l’impegno di un orario di apertura più esteso ed assolvendo in ogni caso la sua funzione.
Per le strutture più grandi, gli orari e le disponibilità di personale sono maggiori. Si va dalle 32 ore di apertura settimanale del Museo di Maglie all 57 di quello provinciale di Cerrate. I musei che “offrono” un’apertura settimanale superiore alle 30 ore sono sei: Cerrate, Maglie, Calimera, Galatina, Poggiardo, Ugento. Possono essere inclusi in questo gruppo il Museo e la Biblioteca provinciali, che dopo la ristrutturazione dovrebbero tornare al regime di 30-32 ore settimanali.
Un quadro d’insieme è dato dal seguente grafico.
Grafico 1: Dati relativi agli orari di apertura per i musei della provincia di Lecce a fruibilità non limitata (orario di apertura settimanale superiore alle 15 ore complessive)
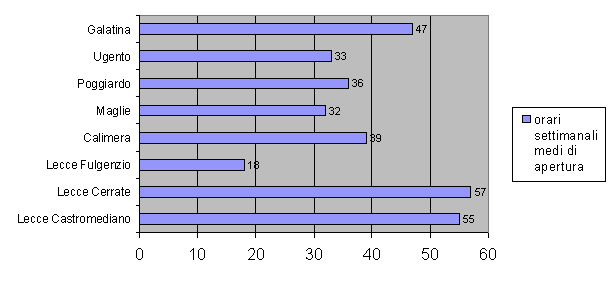
Fonte: elaborazione propria dai dati resi pubblici dai musei.
3.2 - Le ristrutturazioni
Un altro aspetto che la rilevazione mette in luce è la fase di ristrutturazione che parte delle strutture operanti sul territorio ha attraversato degli anni scorsi o attraversa attualmente. Dal punto di vista del fruitore, il fatto che il museo sia chiuso è indubbiamente una perdita, compensata però dalla prospettiva di poterlo visitare avvalendosi di maggiori servizi in un futuro più o meno immediato. Ciò, almeno, è valido per un tipo di utente che risieda nel comune o nei centri limitrofi: lo stesso non vale per il visitatore esterno, ad esempio il turista occasionale o il villeggiante abituale, che non possono rimandare la visita ai mesi (anni, nelle ipotesi peggiori) successivi.
I musei che sono stati ristrutturati negli anni appena trascorsi sono quelli di Maglie, Ugento, Galatina, mentre sono in corso di ristrutturazione il Museo e la Biblioteca provinciali di Lecce, il Museo di S. Cesario (parte della cui collezione è in restauro presso il Museo Provinciale), la Biblioteca Caracciolo (dove alla ristrutturazione degli edifici si accompagna la catalogazione del materiale disponibile), il museo di Cutrofiano (che dovrebbe cambiare sede) e quello di Gallipoli. Altri due musei (Nardò, Porto Cesareo) risultano in allestimento. Significativi sono i tempi di chiusura durante i quali le ristrutturazioni sono avvenute, e che vanno dal lungo intervallo di chiusura di Galatina (che nel 1992 risultava aver interrotto le attività, e che è stato riaperto solo nel maggio del 2000) ai tempi più brevi (e di conseguenza, efficienti) di Maglie (16 mesi, dal luglio 1998 al dicembre1999). La ristrutturazione meno recente è quella del museo di Ugento (1988).
L’osservazione di queste realtà permette di dedurre che i processi di ristrutturazione (e contestuale trasferimento) che esse hanno attraversato, hanno avuto l’effetto di:
· aggregare più servizi culturali in un solo complesso fisico, che identifica funzionalmente (anche agli occhi dei cittadini) un Polo culturale;
· innalzare i livelli di tutela e valorizzazione degli edifici di pregio.
Se scelte in questo senso appaiono praticamente obbligate in centri come questi, che hanno dimensioni medio-piccole, d’altra parte sono anche ottimizzanti, perché permettono di realizzare economie di gestione e, dal punto di vista della fruizione, forniscono all’utente un’offerta culturale articolata in un solo punto di riferimento immediatamente identificabile.
L’ampliamento di dimensioni che ciò comporta potrebbe, inoltre, rendere plausibile l’installazione di servizi accessori, anche se l’effettiva realizzazione di questi si è verificata solo nel museo di Maglie.
In una direzione analoga si stanno muovendo le ristrutturazioni in corso, tra cui quelle che hanno luogo a Lecce, dove la presenza museale è più articolata. Anche qui è evidente la “polarizzazione” in complessi multifunzionali, che sono due:
· l’ex Collegio Argento, che ospita il Museo Castromediano e la Biblioteca Bernardini, di proprietà della Provincia entrambi, come il Museo delle Tradizioni Popolari di S. Maria a Cerrate (ma quest’ultimo è situato fuori città);
· il centro culturale di S. Antonio a Fulgenzio, che comprende la Pinacoteca di Arte Francescana, la Biblioteca Caracciolo, un Museo diviso in due parti (Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale), una sala cinematografica che funge anche da aula didattica e un ninfeo.
Il primo sta affrontando una radicale opera di restauro e di ristrutturazione, che ne richiede la completa chiusura, il che causa concreti danni alla fruizione culturale dell’intera area, essendo il Castromediano una delle istituzioni più attive nell’organizzazione di mostre e attività di promozione culturale.
Il secondo, invece, ha solo ridotto l’orario di apertura al pubblico, pur essendo in corso i lavori di schedatura e informatizzazione nella biblioteca e prospettandosi un trasferimento del “doppio” museo nella cinquecentesca villa extraurbana (oggi centralissima) di Fulgenzio della Monica, annessa al Convento dei Frati Minori responsabili del centro.
3.3 - L'utenza
L’ampiezza della fruizione del museo è data dall’afflusso dei visitatori, che può essere registrato attraverso lo sbigliettato (ove il museo imponga un biglietto per l’ingresso) oppure dai dati risultanti da registri di cui in molti casi i musei si avvalgono come strumenti operativi per il controllo dei servizi. A questi perciò bisogna far riferimento per buona parte dei musei della provincia di Lecce, il cui accesso è gratuito.
Per alcuni di essi riportiamo un quadro sinottico delle presenze registrate con riferimento all’anno 1999 (tranne che per il Castromediano di Lecce, i cui dati sono riferiti all’ultimo anno di apertura, il 1998). Nella sezione successiva, relativa ai servizi aggiuntivi, gli stessi dati relativi alle presenze nei musei saranno riportati insieme ad altri dati fisici con l’intento di tratteggiarne le caratteristiche dimensionali.
Grafico 2: dati delle affluenze per alcuni musei della provincia di Lecce per il 1999
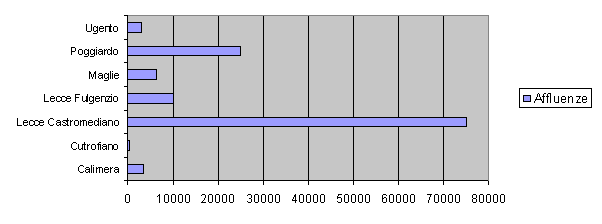
Fonte: dati risultanti da interviste ai direttori dei vari musei
È immediatamente visibile che i musei situati nel capoluogo ricevano un considerevole flusso di visitatori. Alla buona performance di Poggiardo contribuisce la complessità dell’offerta (un percorso che comprende gli scavi di Vaste, la cripta con affreschi bizantini, il museo). Per Maglie il dato usato è una media degli afflussi per gli anni 1995-1996-1997, in considerazione del fatto che il museo è stato chiuso per ristrutturazione per alcuni mesi del 1998 e del 1999.
La fase di ristrutturazione è intervenuta, per il museo di Maglie come per altri del Salento, negli ultimi anni ed ha mutato le condizioni di fruizione. Un’analisi della risposta in termini quantitativi da parte dell’utenza è evidente laddove si disponga di dati dettagliati. Proprio il caso del museo di Maglie offre la possibilità di riscontrare il favore che presso il pubblico ha ottenuto il miglioramento delle condizioni di offerta: comparando infatti i dati medi di frequenza relativi ai singoli mesi per gli anni dal 1995 al 1999 (escluso) con quelli che si sono registrati dopo la riapertura il 14 dicembre 1999, si evince chiaramente un incremento degli ingressi.
Grafico 3: comparazione tra medie mensili degli afflussi per gli anni 1995/1999 e dati omologhi successivi alla ristrutturazione per il Museo di Maglie
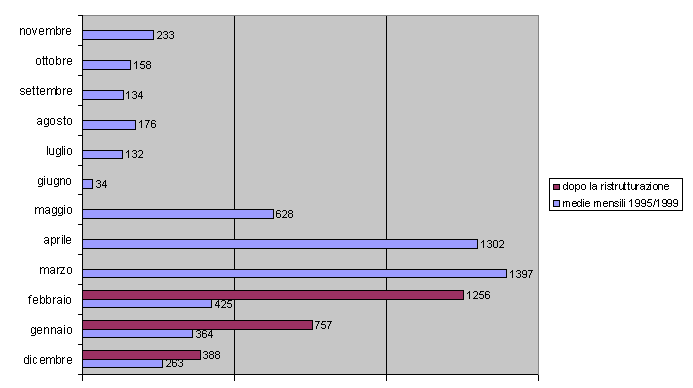
Fonti: dati ed elaborazioni del Museo Paleologico e Paletnologico di Maglie
Un altro aspetto che gli ingressi per stagionalità mettono in luce è la variabilità delle frequenze tra i diversi mesi: si registrano picchi di presenze nel periodo tra marzo e maggio, il che indica un bacino di utenza prevalentemente scolastico, il cui rapporto con il museo è supportato da attività didattiche specifiche (si veda in seguito, nella sezione dedicata alla promozione presso le scuole).
Analogo profilo presentano gli afflussi di quasi tutti gli altri musei, a sottolinearne l’orientamento prevalentemente didattico: le eccezioni sono costituite da musei che registrano consistenti flussi di visitatori anche nei mesi estivi. È il caso di Calimera e Vaste (flussi massimi nel periodo marzo-agosto), Ugento (picchi in luglio-agosto): contribuisce a questi risultati la collocazione geografica (più o meno vicina a posti di villegiatura) dei musei.
3.4 - I servizi aggiuntivi
L’offerta di servizi aggiuntivi è, nel panorama museale italiano, relativamente recente: nell’ambito dei musei civici è, per ragioni dimensionali, poco applicata. Tra i musei salentini sono pochi quelli che hanno allestito al proprio interno punti vendita per pubblicazioni, gadgets, caffetterie, ecc. D’altra parte quasi tutti i musei della provincia sono ad ingresso gratuito ed offrono all’utente la possibilità di effettuare visite guidate con varie modalità. L’approntamento di servizi accessori è da guardare in rapporto anche alla dimensione del museo, che si può evincere dai dati della Tabella 2.
Tabella 2: dati fisici e relativi ai servizi aggiuntivi di alcuni musei della provincia di Lecce in relazione al numero di visitatori, al prezzo del biglietto e al personale impiegato.
| Musei | Prezzo biglietto | Sup. espositiva | Personale | Numero Visitatori (1999) | Visite guidate (modalità) | Supporti audiovisivi | Aula didattica | Bookshop | Caffetteria | |
| (a) | (b) | |||||||||
| Calimera | 3000/2000 | 1400 | 5 | 3600 | A pagamento | X | X | - | - | |
| Cutrofiano | 0 | 50 | 1 | 400 | A richiesta, gratuite | - | - | - | - | |
| Galatina | 0 | 800 | 7* | 1* | n.d. | A richiesta, gratuite | X | X | - | - |
| Lecce Castromediano | 0 | 5000 | 30 | 2 | 75000 | A richiesta, gratuite | - | X | X | - |
| Lecce Fulgenzio | 0 | 600 | 6 | 2 | 10000 | A richiesta, gratuite | X | X | X | X |
| Maglie | 5000/3000 | 700 | 6 | 3 | 6377 | Incluse nel costo del biglietto | X | X | X | X |
| Poggiardo | 4000/1000 | 400 | 12 | 25000 | A pagamento | X | X | X | X** | |
| S. Cesario | 0 | 50 | 1 | 1 | n.d. | A richiesta, gratuite | - | - | - | - |
| Ugento | 0 | 700 | 2 | 1 | 2950 | A richiesta, gratuite | - | - | - | - |
(a): personale fisso con varie mansioni (escluse cooperative)
(b): personale esterno (es. addetti comunali a pulizie, manutenzione locali) od occasionale (lavoratori socialmente utili, obiettori, ecc.)
*Nel museo di Galatina le guide sono fornite di volta in volta dal Comune (il dato 1 è indicativo), mentre il personale permanente del museo è quello della cooperativa Millenium.
**E’ stato installato un punto ristori nella zona degli scavi, fuori dall’abitato.
Fonte: dati risultanti da interviste ai direttori dei musei.
I musei che dal confronto sembrano aver applicato nel modo più esteso i servizi aggiuntivi sono quelli di Maglie e di Lecce a Fulgenzio, che offrono al visitatore, oltre alla guida (effettuata da personale qualificato: a Maglie due laureati impiegati permanentemente e tre laureandi in maniera occasionale, a Lecce un biologo), la possibilità di acquistare materiale informativo, specialistico e gadgets nel bookshop e di servirsi della caffetteria. Nel complesso di Maglie, inoltre, a disposizione degli utenti della biblioteca e del museo c’è anche la lettura di diversi quotidiani, la consultazione del materiale informatico della mediateca e l’accesso (a pagamento) ad Internet. Il museo, o meglio il “polo culturale” nel suo complesso si avvale di un’aula didattica propria di 70 posti con maxi schermo per l’organizzazione di seminari e corsi tematici.
Quanto al complesso culturale di S. Antonio a Fulgenzio a Lecce, questo articola i servizi aggiuntivi nella varietà della sua struttura: la sala cinematografica viene adibita anche ad aula didattica ove se ne presenti il bisogno; annessa alla sala vi è la caffetteria; nella biblioteca, oltre alla consultazione di materiale informativo e specialistico (nella sala lettura), è possibile avvalersi di supporti audiovisivi; nel museo è disponibile la visita guidata; infine è possibile acquistare (con offerta libera) pubblicazioni proprie del museo.
Servizi analoghi offre il Museo Provinciale di Lecce: anche qui la guida è un servizio base si ha la disponibilità di un bookshop, e per visite di gruppo, un’aula didattica. C’è anche una caffetteria, ma, almeno fino all’inizio della ristrutturazione, è stata destinata ad uso interno.
Anche il museo di Galatina offre al visitatore supporti audiovisivi e la possibilità della visita guidata, effettuata dal personale della cooperativa che ha in gestione il museo, e dispone, nel Palazzo della Cultura, di un’aula didattica che funge anche da sala conferenze.
Un discorso a parte merita il Museo di Storia Naturale di Calimera, gestito da una s. c. r. l. (Naturalia), nella quale ognuno dei soci (personale qualificato con specifiche competenze) è responsabile di un settore espositivo del museo: questa struttura offre, oltre alla visita guidata a pagamento, la possibilità di una dettagliata visita virtuale sul proprio sito web; una visibilità che in parte sopperisce alla mancanza di pubblicazioni proprie del museo.
Dal confronto dei dati nelle due tabelle si evince che l’allestimento di servizi accessori si ha in musei che superano una soglia minima di circa 6000 visitatori all’anno (il museo dotato di servizi accessori che registra il numero più basso di visitatori è quello di Maglie, ma le tendenze degli afflussi sembrano aver registrato un radicale cambiamento nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla ristrutturazione). Al di sotto di tale massa critica di utenza sembra ingiustificato dotare la struttura di servizi aggiuntivi. Bisogna notare che nei musei in cui l’ingresso è gratuito la rilevazione del numero delle visite si presenta difficoltosa perché affidata ai conteggi sui registri delle presenze, fonte meno completa e affidabile dello sbigliettato.
Quanto al canale telematico, le modalità di accesso di musei e istituzioni affini alla Rete sono principalmente la costruzione di un sito proprio, la segnalazione in siti che forniscono informazione culturale a carattere più ampio o a siti istituzionali (Comune, Provincia), oltre al possesso di un indirizzo di posta elettronica proprio. In generale la presenza die musei leccesi sul Web è affidata a provider locali (clio, medusa, itaka), alcuni dei quali (clio) sembrano aver superato le difficoltà iniziali della loro attività, garantendo siti completi ed efficienti; in altri casi si può dire che la situazione sia ferma alla fase di avviamento.
Tabella 3: Presenza dei musei salentini nel web (siti propri, istituzionali, altri, e-mail)
| Musei | Siti propri | Segnalazione in siti istituzionali (a) | Segnalazione in siti specializzati (b) | Segnalazione in siti di altro genere (c) | |
| Calimera | X | X | X | X | |
| Galatina | X | X | X | ||
| Lecce Castromediano | X | X | X | ||
| Lecce Fulgenzio | X | X | |||
| Maglie | X | X | X | ||
| S. Cesario | X | ||||
| Ugento | X | X |
(a) Siti dei Comuni, della Provincia.
(b) Siti specifici come Apuliamuseum, museionline, ecc.
(c) Siti di informazione culturale e turistica come salentoweb, salentoantico, salentofrancescano, ecc.
Fonte: dati propri.
Sotto il profilo del contatto telematico con l’utente, il museo che ha rivelato il maggior dinamismo (creazione di un sito proprio, disposizione di visita virtuale, informazioni sull’attività di ricerca del museo) è quello naturalistico di Calimera.
Gli altri sono segnalati sia in siti specializzati che ne riportano i dati essenziali di fruizione (orari di apertura, disponibilità di servizi aggiuntivi, accesso ai disabili, ecc.), sia nei siti dei Comuni o delle istituzioni (v. Lecce Fulgenzio) cui appartengono. A diminuire l’efficacia del canale informativo telematico contribuisce però l’incompleta sistematizzazione di questo strumento sul territorio: i siti web di molti Comuni della provincia sono ancora in allestimento e questo giustifica la mancata segnalazione dei rispettivi musei civici in questi casi.
3.5 - Le risorse umane
Anche quello riguardante il personale impiegato può essere un dato cui far riferimento per dimensionare i musei, oltre all’afflusso di visitatori: e qui si passa dalle 32 unità del Museo Provinciale di Lecce alle 6 di quello di Maglie, alle situazioni come quelle di S. Cesario, Cutrofiano e Ugento (comuni a molti altri musei civici) in cui l’intera struttura grava praticamente su un solo soggetto (due ad Ugento: il direttore del museo e l’addetto della biblioteca), coadiuvato da collaboratori occasionali (obiettori, lavoratori socialmente utili). Il dato relativo al complesso di Lecce a Fulgenzio è da considerarsi indicativo e “flessibile”, perché la struttura è connessa al Convento dei Frati minori e si avvale della collaborazione di volontari del WWF (che ha sede nello stesso complesso), di Legambiente e del FAI.
Al di là dell’aspetto dimensionale, è importante considerare anche quello qualitativo, che può essere sinteticamente indicato attraverso la quota di addetti qualificati sul totale del personale impiegato. Nella quota sono inseriti gli addetti alla didattica, alla preparazione di percorsi conoscitivi, al restauro, all’attività di promozione presso il pubblico, alla dirigenza.
Grafico 4: quote di addetti qualificati sul totale degli impiegati presso alcuni musei salentini
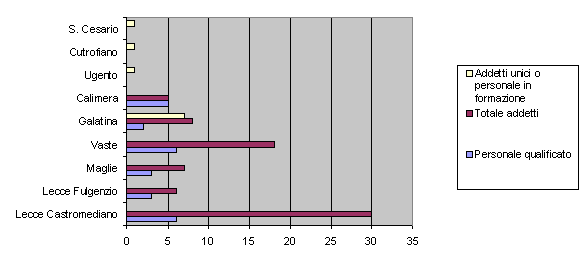
Fonte: dati risultanti da interviste ai direttori dei musei.
Per alcuni musei questa distinzione non è stata possibile. I motivi sono i seguenti:
· il personale è addetto, a rotazione, a tutte le mansioni previste dall’organico (come nei casi delle cooperative Penelope 2000 a Vaste e Millenium a Galatina);
· gli addetti non hanno qualifiche certificate (lauree, diplomi, etc.) ma stanno acquisendo una formazione specifica (è il caso della cooperativa Millenium di Galatina, i cui soci stanno seguendo un corso per operatori di museo organizzato dalla Regione Puglia);
· il museo è retto da un solo elemento che svolge più funzioni (guida, custodia, piccoli restauri…) come nei casi sopra citati di S. Cesario, Cutrofiano e Ugento. Si noti la felice anomalia di Calimera: nel Museo di Storia Naturale praticamente la totalità del personale è qualificata, e impegnata nelle molteplici attività di ricerca del centro.
3.6 -Attività di promozione presso le scuole e la cittadinanza
Un altro canale attraverso il quale il museo dialoga con l’utente è quello dell’attività con cui si fa “conoscere”, organizzando mostre, ospitando eventi culturali, conferenze, convegni e così via. Le attività di promozione e ricerca sono quelle che mettono maggiormente in luce le opportunità di cooperazione tra musei, le potenzialità di nascita di distretti culturali.
Nella promozione della propria attività, i musei si distinguono a seconda del bacino di utenza al quale si rivolgono: molto spesso di tratta di scuole dei comuni vicini (e qui la promozione si traduce in offerta di pacchetti didattici, percorsi tematici, oltre all’organizzazione delle tradizionali visite guidate per scolaresche); in altri casi il pubblico cui il museo cerca di rivolgersi è la cittadinanza in generale, a favore della quale promuove mostre, incontri con studiosi delle discipline caratterizzanti il museo (archeologia, paleontologia, ecc.); infine il museo si rivolge agli “addetti ai lavori”, organizzando conferenze, convegni, giornate studio, e qui l’attività di promozione si fonde con quella di divulgazione dei risultati dell’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’istituzione.
3.7 - Le attività di ricerca
L’attività di ricerca (catalogazione, restauro, studio) è talvolta svolta all’interno dello stesso museo, talatra in collaborazione con altri: in questi casi l’ente cui fa capo l’attività di ricerca (Università) diventa il tramite tra l’istituzione che eroga i fondi (Sovrintendenza) ed il museo, estromettendo quest’ultimo da questa fase della gestione e condizionandone l’attività (si veda più avanti il caso di Vaste).
L’indagine scientifica è legata al campo di specializzazione del museo: a parte i musei di tradizioni popolari (musei di tipo antropologico) e quelli “generalisti” come il Castromediano, buona parte dei musei salentini può rientrare sotto la definizione di “specialistici”, specialmente nel campo dell’archeologia e delle scienze naturali. In appendice sono riportate alcune tra le più interessanti attività svolte nei musei salentini, sia nel campo della ricerca, sia in quello della promozione.
3.8 - La gestione finanziaria
I musei considerati sono in maggioranza civici, a parte alcune importanti eccezioni: il Museo S. Castromediano di Lecce, che appartiene alla Provincia, il Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale di Lecce, di proprietà dei Frati minori e alcuni musei privati.
È l’ente proprietario a convogliare verso i musei la maggior parte dei fondi che ne finanziano l’attività.
Le difficoltà incontrate in questa parte dell’analisi sono dovute innanzitutto ai diversi aspetti sotto i quali la gestione dei musei di volta in volta si presenta: alcuni sono gestiti direttamente dai Comuni, altri sono interamente affidati a cooperative, altri ancora delegano alle cooperative parte dei servizi necessari alla gestione. Quanto ai servizi accessori, non si riscontra alcun caso di affidamento per appalto secondo il dettato della legge Ronchey (una procedura, come si è visto, possibile di fatto solo per grandi musei).
A rendere difficile la rappresentazione contabile dell’attività dei musei concorre, oltre ai vari legami di dipendenza dei vari istituti con i rispettivi patron, anche la diffusa mancanza di disponibilità informative.
L’erogazione di fondi risulta inoltre condizionata, in determinati casi, all’attivazione di progetti specifici, per cui a seconda della tipologia di museo considerato è possibile registrare erogazioni di fondi per scavi (musei archeologici), restauri, mostre, etc. Ma affinché i progetti si attivino è necessario che l’attività di gestione del museo si affermi in maniera efficace, sì da prospettare la concreta utilità della realizzazione dei progetti.
Dai dati disponibili si può evincere che le destinazione cui vengono indirizzati i fondi riferiti ai musei riguardano, oltre ai tipi di progetti circostanziati cui si è accennato, anche disegni di politica per la cultura più ampli, come nel caso di Ugento, e ristrutturazioni.
Nella tabella seguente vengono riportate, per alcuni musei, le somme stanziate a vario titolo dagli enti che ne rappresentano i principali interlocutori finanziari. In alcuni casi il riferimento temporale è determinato, in altri (Galatina, Ugento) si considera un arco temporale più lungo, richiedendo i progetti tempi di attuazione più estesi.
Tabella 4: Dati relativi al finanziamento delle attività di alcuni musei del Salento
| Destinatari fondi | Anno | Importo (milioni) | Provenienza | Destinazione |
|
Galatina |
1994-1999 | 590 | Fondi Europei (POP 94/99) | Ristrutturazione del Polo culturale |
| 390 | Mutuo Comunale | |||
| Gallipoli | 1998 | 34 | Comune | Ristrutturazione |
| Poggiardo-Vaste | 1999 | 1700 | Sovrintendenza | Scavi parco archelogico |
| 60 | CNR | Creazione centro studi | ||
| Ugento | 1979 e seguenti | 275 | Regione (l.reg. 22/79) | Restauro Mura di Ugento |
| 120 | Regione (l.reg. 37/79) | Restauro Mura di S. Giovanni | ||
| 1999 | 50 | Provincia | Restauro Cripta Crocefisso | |
| 2000 | 276 | Comune | Piano tematico per la conoscenza l’uso e la valorizzazione dei beni culturali | |
| Convenzione di studio con l’università di Lecce | ||||
| Parco letterario “Q: Ennio” |
Fonte: dati risultanti da interviste con i direttori dei musei.
Si può quindi notare che le attività del museo, in particolare la ricerca, trovano un condizionamento nella gestione del museo, e, a loro volta, la influenzano. Ne risultano condizionate perché l’efficienza della gestione museale crea le premesse per l’avanzamento della ricerca, o stabilisce condizioni coerenti a giustificare una ristrutturazione; sono condizionanti perché, soprattutto per determinate tipologie di musei (archeologici, paleontologici) l’erogazione di fondi è legata a progetti di scavo, restauro, ecc., che d’altra parte sono possibili solo ove una struttura efficiente li renda plausibili. Valga per tutti l’esempio del Museo di Vaste – Poggiardo: nato da pochi anni, è diventato il fulcro di un vasto circuito storico artistico che comprende il Parco archeologico dei Ss. Stefani e l’Abbazia di S. Giuliano. Il recente stanziamento di 1700 milioni per gli scavi da parte della Provincia è stato reso possibile dal fatto che l’attività di studio e recupero di reperti non si è praticamente mai interrotta e il museo, coadiuvando l’attività espositiva con un’intensa promozione culturale e avviando ottimi rapporti con le istituzioni locali, ha creato un notevole radicamento sul territorio.
Considerazioni finali
È possibile, riguardo alle istituzioni considerate, parlare di sistema museale? A questo proposito bisogna tener conto della varietà registrata nelle tipologie di musei (archeologici, artistici, paleontologici, etc.), che permetterebbe di individuare, nella diversità di caratterizzazioni, una condizione idonea per la sistematizzazione dell’insieme dell’offerta (in base ad una sorta di divisione delle competenze scientifiche).
Ma proprio dall’osservazione delle diverse caratterizzazioni emerge un punto debole: la non definita specificità in alcuni dei musei (ad esempio Gallipoli, e, fra i maggiori, il Castromediano, che sopperisce all’eclettismo con un’intensa attività di promozione culturale). Si aggiungono poi diversità negli standard qualitativi di offerta (si vedano i servizi aggiuntivi), la difficoltà a creare e consolidare una collaborazione tra musei: questa, infatti, si svolge in un ambito quasi esclusivamente extraistituzionale, sulla scorta di contatti personali e interessi comuni di studio o ricerca. Progetti di cooperazione sono presentati annualmente dalla direzione del Castromediano al diretto interlocutore istituzionale, la Provincia, ma senza importanti risultati. Se da una parte qualche legame sembra emergere (nell’area del Basso Salento, tra i “poli” di Maglie, Ugento e Poggiardo, grazie anche all’intensa presenza archeologica comune alle rispettive zone), dall’altra si avverte una diffusa riluttanza a instaurare rapporti concreti di collaborazione (scambi di reperti, creazione di percorsi tematici comuni a scopo didattico), andando oltre i semplici e sempre condivisibili auspici.
In questo contesto svolgono un ruolo importante, soprattutto come punti di riferimento comuni e possibili canali di raccordo, agenti “esterni” come l’Università e le associazioni che animano la vita culturale del Salento.
Non mancano, al di là di questi punti d’ombra, degli aspetti positivi. Tra questi il più evidente è dato dalle ristrutturazioni che hanno mutato la presentazione dell’offerta al pubblico e hanno contribuito a razionalizzarla dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità: nella maggior parte dei casi, infatti, il processo di ristrutturazione è coinciso con un accorpamento di strutture che ha prodotto nuclei di poli culturali (Galatina, Maglie, e, primo nel tempo, Ugento). Lo stesso indirizzo seguono alcune delle ristrutturazioni in corso (quelle delle due principali realtà leccesi, Castromediano e Fulgenzio, oltre a quella del Museo di S. Cesario) con prospettive di efficacia ancora maggiore nella promozione di quella cultura della conservazione cui nell’inizio di questo lavoro si accennava, grazie anche alla consolidata esperienza di queste strutture nell’attività di promozione culturale, al loro collaudato legame con le istituzioni della ricerca e il loro più vasti bacini di utenza.
Le ristrutturazioni hanno inoltre avuto importanti conseguenze e propongono sfide impegnative. Tra le prime l’aumento delle affluenze, legato al miglioramento della fruibilità derivante dall’aggiornamento in termini qualitativi delle strutture; tra le seconde, la necessità di una riqualificazione (e in qualche caso, di un ampliamento) del personale, soprattutto di quello a diretto contatto con l’utente.
Appendice
Attività di promozione di alcuni musei salentini
Museo Provinciale di Lecce “S. Castromediano”
È un’istituzione molto attiva nella promozione culturale. Possiede una variegata collezione di dipinti di maestri salentini, oltre a notevoli reperti archeologici. Il carattere eclettico del contenitore-museo ne fa un quadro ideale per l’organizzazione di mostre d’arte, che vi si svolgono con frequenza semestrale (ogni due anni, mediamente, il museo ospita una mostra di livello ed impegno particolarmente elevato); le mostre relative al territorio (valorizzazione della cultura locale, delle tradizioni, ecc.) hanno luogo con frequenza anche mensile. Vengono promossi convegni (due all’anno in media) e conferenze (5-6 al mese).
Tra le mostre di una certa importanza ricordiamo: Il Barocco a Lecce e nel Salento, Gioacchino Toma (1836-1891), Opere del Novecento italiano nella Collezione della RAI, La passione dell’Origine.
Museo di Storia Naturale (complesso di Lecce a Fulgenzio)
Il museo svolge varie attività ricreative e formative; fra queste, le iniziative di promozione culturale vengono attivate in collaborazione con WWF (che ha sede nello stesso complesso in cui sorge il centro), Legambiente, e il FAI.
Museo Paleontologico e Paletnologico di Maglie
Il Museo ha fatto propria la missione di prevenire, con un’opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, gli atti di vandalismo che, purtroppo, spesso si registrano ai danni di siti archeologici e di interesse paleontologico molto diffusi nel Salento: a questo scopo promuove incontri-dibattito a tema (“Incontri con archeologi”) due volte al mese nel periodo tra aprile e giugno. L’attività di promozione culturale si compone anche di un’articolata proposta didattica nata da progetti mirati del Comitato Scientifico (tre percorsi tematici per un’offerta didattica che può essere fruita nel Museo o direttamente nelle scuole).
Museo Civico di S. Cesario
Dopo un periodo in cui il Museo è stato centro di un’attività di promozione culturale di buon livello (mostre di arte contemporanea curate con competenza), nell’ultimo decennio le iniziative più frequenti sono state mostre personali di pittori locali.
Museo Archeologico di Ugento
Dotato di scarsi strumenti organizzativi (il personale è composto da due persone), il Museo svolge la sua attività di promozione culturale in collaborazione con altre istituzioni locali: varie Pro loco per l’organizzazione di eventi culturali di vario genere, specie nel periodo estivo; l’Accademia di Belle Arti e l’Università di Lecce per quel che riguarda mostre (la più recente cui il Museo ha partecipato, “Dalle monete antiche all’Euro”, è di ambito regionale: in generale l’Accademia allestisce presso il Museo due mostre l’anno). Con l’Università è costante la collaborazione nella ricerca, costituita essenzialmente dalle attività degli scavi archeologici.
Museo archeologico di Poggiardo
Il Museo organizza ogni estate il “Festival internazionale dell’archeologia per ragazzi”, in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Lecce, presso il parco archeologico dei SS. Stefani, e rassegne estive di manifestazioni artistiche, teatrali e altre eventi culturali.
Attività di promozione di alcuni musei salentini
Museo di Calimera
Il museo ospita: un centro sperimentale di inanellamento, che opera in collaborazione con l’Istituto Fauna Selvatica dell’Università di Bologna; un centro paleontologico per lo studio ed il restauro dei fossili, nel cui ambito vengono promossi corsi formativi; un centro di studi entomologici, che aderisce al progetto internazionale per la creazione di un Parco ambientale nel delta del Niger, e presso il quale è in corso di svolgimento il censimento della fauna entomologica dell’Italia meridionale; un centro per lo studio e il censimento della malacofauna; un centro studio per le tartarughe marine ed un altro per la riproduzione e la reintroduzione delle tartarughe terrestri. Il Museo si propone di organizzare corsi, conferenze e dibattiti sulle metodologie di studio e restauro di reperti fossili, di cui il Salento è ricchissimo.
Museo Comunale della Ceramica di Cutrofiano
Il museo dispone di un piccolo laboratorio di restauro di cui si occupa l’unico addetto- responsabile; pubblica inoltre, con frequenza annuale, i “Quaderni del Museo della Ceramica” con i risultati degli studi effettuati su reperti ceramici provenienti dalla zona di Cutrofiano e di altre località del Salento. In collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Lecce, il museo dovrebbe avviare un progetto di ricognizione del territorio circostante come centro di produzione della ceramica medievale.
Museo Provinciale di Lecce “S. Castromediano”
Museo si avvale di due laboratori di restauro, uno per i dipinti e un altro per il materiale archeologico, cui fanno capo musei e altre istituzioni della provincia (in particolare le chiese di pregio). Lavorano presso i laboratori tre restauratori ad incarico permanente (tra i progetti compresi nella ristrutturazione in corso c’è l’assunzione di nuovo personale scientifico di settima qualifica.
Il museo partecipa al progetto “La Provincia restaura” insieme alla Sovrintendenza; un’altra iniziativa cui attualmente il Museo prende parte è “Medioevo nel Salento”, promosso insieme all’Università di Lecce.
Museo di Storia Naturale (complesso di Lecce-Fulgenzio)
Il Museo svolge al proprio interno attività di ricerca in campi specifici (attualmente è in corso uno studio sui coleotteri) e si avvale di collaborazione con l’Università sia come utente dei risultati di ricerca raggiunti in sede accademica, sia ospitando corsi curati da docenti universitari: non si tratta però di collaborazioni istituzionali, nascendo di solito da contatti di tipo personale tra curatori del Museo e ricercatori o docenti.
Museo Paleologico e Paletnologico di Maglie
La ricerca qui svolta, che si sostanzia innanzitutto nella funzione conservativa di materiale paleologico e paletnologico presso il Museo, vede una significativa integrazione di quest’ultimo con l’Università, rappresentata nel Comitato Scientifico e nella direzione, retta da una docente dell’Ateneo di Lecce, e la Soprintendenza, con la quale è stata sottoscritta una convenzione di intervento per la ricerca relativamente agli scavi del Basso Salento.
Il museo si avvale della collaborazione di un Gruppo speleologico.
Museo Civico di S. Cesario
Il Museo non svolge studi legati al materiale che ospita ma offre supporto tecnico-organizzativo e conoscenze ad iniziative provenienti dall’esterno, come il progetto di valorizzazione di luoghi di archeologia industriale (ex distillerie De Bonis), studi di storia dell’arte su realtà locali svolti in ambito universitario (collaborazione con l’Università di Strasburgo).
[1] ISTAT, Indagine statistica su musei e istituzioni affini, 1995.
[2]Paolucci scrive: «il primo cardine e' il primato dello Stato. Lo Stato non può delegare a nessuno ruolo e responsabilità nei confronti del patrimonio storico culturale della Nazione. E ciò non per pregiudiziale totalitaria, ma perché solo lo Stato, sintesi di tradizione e di storia, puo' farsi garante, per tutti, di valori che sono di tutti» [A. Paolucci, in Sole 24 ore, 24 aprile 1994].
[3] L. Bobbio, “Il patrimonio dell’autonomia”,in Sole 24 ore, 1 giugno 1997.
[4]M. Cammelli, Il decentramento difficile; M. P. Chiti, La nuova nozione di “beni culturali” nel d. lg. 112/1998: prime note esegetiche, Aedon, n.1/1998.
[5]Standard per i musei italiani a cura del Gruppo di lavoro promosso dalla Conferenza delle Regioni d’intesa con ANCI, UPI e con la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dell’ICOM e dell’ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali).
[6]D. Santucci in Osservatorio legislativo enti locali – Sole 24 ore, 7 febbraio 2000.
[7]Pronti, Boccenti, Il museo tra istituzione e azienda, ed. il Sole 24 ore, 1999.
[8] M. De Fulgentiis, “Cultura in rete. I vantaggi economici” in il Sole 24 ore, 03/12/1999.
[9] A. Misiani, “La mappa dei poli culturali”; sintesi della ricerca di Federculture “Lo stato dei servizi per la cultura negli Enti locali”, in il Sole 24 ore, 3 dicembre 1999.
[10] Si è preferito però non inserire nell’analisi alcune di quelle realtà, ovviamente non con riferimento al loro valore, ma perchè troppo ridotte sono le dimensioni o il respiro economico, o perchè non strutturate funzionalmente ad una fruizione da parte del pubblico. Per questo, nonostante le segnalazioni ISTAT, non rientrano tra i musei e le istituzioni similari riportate nella Tabella 1 i seguenti elementi: la Raccolta di Animali Imbalsamati di Tricase, il pur interessante Museo Malacologico di Cava Lustrelle, la Raccolta Colosso (che comprende pregevoli reperti archeologici ma è visitabile solo previo appuntamento ed è disposta in locali privati), la Raccolta di Reperti storico-artistico-ambientali di Ruffano ed il Tesoro della Cattedrale di Gallipoli. E’ sembrato giusto, d’altra parte, inserire complessi monumentali importanti come i Castelli di Copertino ed Otranto e l’Anfiteatro Romano di Lecce (di proprietà statale e chiusi per restauro).
[11] Su questo dato è necessario fare una distinzione tra musei che sono chiusi ormai da alcuni anni (Alezio, Gallipoli, Surbo, etc.) e altri la cui chiusura è o si prevede temporanea. Per questi ultimi (Museo e Biblioteca Provinciali di Lecce, Museo di Biologia di Porto Cesareo, Museo di S. Cesario) la sospensione dell’attività è dovuta a cause contingenti: ristrutturazioni per adeguare gli impianti agli standard di sicurezza previsti dalle nuove norme oppure ad urgenze di restauro o a fasi di allestimento. Per i primi, invece, la situazione appare più preoccupante: il Museo Civico di Gallipoli è chiuso dal 1997, quello di Alezio dal 1992, quelli di Nardò e Surbo addirittura da prima del 1990. Quanto alle prospettive di riapertura sono praticamente nulle per Alezio e Surbo, i cui reperti sono stati trasferiti rispettivamente alla Soprintendenza di Taranto e all’Università di Lecce. Per il Museo del Mare di Nardò si prospetta una riapertura a breve, dopo anni di chiusura per restauro.