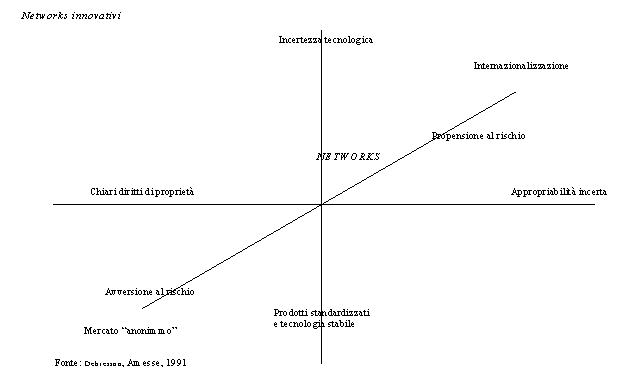 |
CAPITOLO II
IL SISTEMA INNOVATIVO ITALIANO
L’approccio dei sistemi innovativi nazionali di d’innovazione considera le caratteristiche dei processi innovativi nella specificità dell’ambito economico di ciascun Paese. Le capacità tecnologiche delle imprese sono viste come la fonte principale del loro valore; si sottolinea che tali capacità sono “nazionali” e quindi legate ad una precisa situazione economica, ad un’identità socioculturale difficilmente generalizzabile. I sistemi nazionali di innovazione, la conoscenza tecnologica di un Paese sarebbero frutto di un processo di sedimentazione o evoluzione graduale che non può essere trasferito in altri contesti economici con la stessa facilità di altri fattori di produzione.
All’interno di questi sistemi operano determinate istituzioni, tra cui possiamo distinguere: le imprese, soprattutto quelle che svolgono attività di ricerca e sviluppo; le Università e gli istituti di ricerca di base; le istituzioni pubbliche e private che forniscono educazione e base tecnica; il settore pubblico che finanzia e promuove un cambiamento tecnologico.[1]Si può notare che queste istituzioni tracciano in tutte le sue tappe l’itinerario della conoscenza attraverso il mondo produttivo, dalla ricerca base nei laboratori universitari, alla ReS delle imprese, dalle politiche tecnologiche alla formazione e produzione di capitale umano.
Ogni singolo sistema innovativo nazionale vive realtà che derivano dalla sua evoluzione passata, percorre cammini di specializzazione che si inquadrano nel più ampio contesto della divisione internazionale del lavoro e delle attività tecnologiche e innovative.
Il processo di crescente internazionalizzazione dell’economia ha sicuramente cambiato il ruolo degli Stati nazionali. Si sono formati nuovi sistemi di riferimento: reti regionali, transnazionali o locali, con regole e sistemi di funzionamento loro propri. Ma, nonostante questa tendenza, i sistemi innovativi nazionali svolgono ancora un ruolo fondamentale, caratterizzando le realtà economiche dei diversi Paesi.[2] C’è un legame complesso fra ruolo dei sistemi innovativi nazionali e globalizzazione delle attività economiche. Subito va rilevato che fra queste ultime sono quelle più specificamente produttive ad essere dislocate all’estero: le attività innovative (ReS, progettazione, ecc.) rimangono invece spesso nell’ambito del Paese d’origine dell’impresa, ma l’integrazione dei sistemi nazionali d’innovazione offre esternalità (infrastrutture di ricerca, educazione e formazione) che rendono possibile l’accumulazione di vantaggi tecnologici alle imprese che vi portano il loro contributo in termini di attività innovative. Sicché, se da una parte le multinazionali che investono in un determinato Paese vi favoriscono, con il proprio bagaglio tecnologico, la diffusione delle conoscenze, dall’altra, come afferma Mariotti, “appare rovesciata la relazione virtuosa tra sistema innovativo nazionale ed impresa multinazionale per quanto concerne l’attività di generazione dell’innovazione: in questo caso, è eventualmente la seconda a poter sfruttare, tramite strategie di localizzazione, le esternalità offerte dal primo piuttosto che quest’ultimo ad avvantaggiarsi dal decentramento multinazionale dell’attività innovativa delle imprese tecnologicamente di successo.”[3]
Tradizionalmente il dibattito su struttura industriale ed innovazione assegna alle piccole e medie imprese un ruolo marginale. L’attenzione si concentra di solito sulla grande impresa e sulle forme di mercato ad essa collegate, come l’oligopolio. Questa impostazione si rifà al tardo Schumpeter, che enfatizza la maggiore attitudine delle grandi unità produttive ad affrontare i costi ed i rischi della ReS, grazie alle loro cospicue risorse tecnologiche e finanziarie.
Nella letteratura tradizionale, le imprese di dimensioni maggiori sono viste come gli agenti principali del processo di innovazione tecnologica perché favorite nel reperimento di risorse e credito per l’innovazione, perché in grado di ripartire meglio i costi fissi delle innovazioni tra ampi volumi di attività e di vendita e quindi di conseguire maggiori ricavi dall’impegno in ReS. Nelle grandi imprese si sviluppano complementarità tra le ReS ed altre attività; è più facile svolgere attività di ricerca che implichino economie di scala. Inoltre per alcuni beni e processi la ReS comporta che solo le imprese che arrivano per prime ad un risultato positivo possano ottenere vantaggi cumulabili in futuro (ReS race), e ciò favorisce la concentrazione e la crescita dimensionale.
In tale ottica però si fa riferimento principalmente alla attività di innovativa legata ai risultati della ricerca formalizzata, e l’impegno delle imprese in questo senso è commisurato al volume di risorse investito nella ReS.
Tuttavia, considerando solo la spesa industriale per la ricerca e sviluppo, si usa un indicatore tendenzialmente “sbilanciato” a favore delle grandi imprese, dato che le spese per la ricerca presentano delle soglie minime non sempre compatibili con le ridotto capacità finanziarie delle imprese di dimensioni minori. Peraltro, in molti casi, la ReS formalizzata, tipica delle grandi aziende, non è l’input principale del processo innovativo: ci sono forme di conoscenza ingegneristiche o “minori” che sono fonte primaria di innovazioni industriali; né va trascurata l’importanza dei canali di comunicazione tra settori produttivi come le varie forme di cooperazione tra imprese, o le mostre e le fiere commerciali.[4]
Ed è necessario considerare inoltre le specificità produttive dei vari settori: in certi campi (farmaceutico, automobilistico, ecc.) la grande dimensione è essenziale sia per produrre sia per innovare e compiere attività di ricerca.
Prendendo in considerazione anche queste voci, il rilievo delle piccole e medie imprese cambia. Il tipo di cambiamento tecnologico da esse operato raramente si riferisce ad innovazioni radicali, frutto di ricerca endogena: spesso si tratta di un impegno costante ad adottare rapidamente tecnologie generate all’esterno, ad adattarle e migliorarle continuamente. Abbiamo un tessuto produttivo composto da un ampio numero di imprese, legate tra loro da fattori non solo economici, ma anche culturali e sociali, e fortemente radicate nel territorio, Queste imprese, come osserva Malerba, “compiono innovazione incrementale attraverso il learning by doing, by using e by interacting con i fornitori ed i clienti. Esse comunicano in maniera formale ed informale, condividono conoscenza tacita, e sono caratterizzate da un’ampia mobilità del lavoro. Il ruolo di agenzie regionali, autorità pubbliche locali, e scuole professionali locali è efficace nel supporto ai bisogni ed alle richieste delle piccole imprese dell’area”.[5]
C’è dunque una marcata distinzione tra i due subsistemi innovativi che coesistono nel panorama produttivo italiano, quello formato dalle pmi e quello delle grandi imprese ad alta tecnologia.
Il tessuto delle piccole e medie imprese
Si è già parlato del fenomeno del decentramento produttivo che ha portato le piccole e medie imprese ad avere un ruolo essenziale nel sistema economico del Paese. È ora necessario trattarne più approfonditamente, per evidenziare il carattere di questo tessuto produttivo come “sistema innovativo”.
Il primo aspetto che cercherò di evidenziare è quello che contraddistingue spesso la compagine delle pmi come “rete” o, appunto, “tessuto” di imprese che interagiscono tra loro nei cosiddetti distretti industriali, ed il peculiare rapporto che questi hanno con l’innovazione; quindi tratteggerò le principali tipologie di pmi che operano nel Paese. Quindi, in base ai dati di una indagine ISTAT sull’introduzione di innovazioni tecnologiche nelle imprese, sarà possibile analizzare quali sono i tipi e le fonti di innovazioni adottate dalle pmi, comparandole con le attività innovative svolte dall’altro subsistema, quello delle grandi aziende.
I distretti industriali
I distretti industriali sono aree in cui si raccolgono imprese di dimensioni piccole e medie, ognuna delle quali generalmente si specializza in una fase del processo produttivo che caratterizza il distretto nel suo complesso. Raramente in una sola impresa si concentrano varie fasi di produzione ed eventualmente anche la vendita del prodotto.
La divisione “orizzontale” del lavoro tra le piccole unità del distretto può costituire, secondo Marshall, un’alternativa all’organizzazione verticalmente integrata dell’impresa multifunzionale, quando le diverse fasi del processo siano separabili e possano essere svolte in stabilimenti distinti, pur se territorialmente raggruppati.
Si ha allora non più un insieme di unità produttive (imprese) ma un sistema autoreferenziale che opera come unità a sé stante.
Questo complesso economico presenta caratteristiche proprie quali flessibilità ed economie esterne.
Laflessibilità è possibile grazie alle piccole dimensioni e all’alta natimortalità delle imprese coinvolte, che da una parte hanno moderati costi fissi, e dall’altra, essendo impegnate in una sola (o in poche) fasi di produzione, possono “convertire” la propria attività più agevolmente rispetto ai grandi impianti che affrontano l’intero processo di produzione.
In una situazione di questo tipo si creano economie esterne alla singola impresa ed interne al distretto, riconducibili all’ ”atmosfera industriale” che Marshall indicava come caratteristica del distretto. Si tratta essenzialmente di un patrimonio di sapere comune, di capacità produttive cui attingono gli operatori, una conoscenza tacita immersa nel contesto del distretto e difficilmente esportabile al di fuori di esso.
Sono questi i fattori che hanno portato a vedere nel modello del distretto una risposta alla crisi della grande impresa di tipo fordista (prodotti standardizzati, scarsa specializzazione del lavoro) e una condizione per la “specializzazione flessibile”, agevolata dalla gestione decentrata e potenzialmente più dinamica delle diverse fasi di produzione.
I distretti come networks innovativi
Conle sue caratteristiche, il distretto ha un rapporto del tutto particolare con l’innovazione.
In un’ottica schumpeteriana le imprese si possono considerare come combinazioni temporanee di risorse e fattori produttivi, che il sopraggiungere dell’innovazione permette di variare. Il network innovativo affronta tale processo con una maggior flessibilità perché ciascuna impresa compie limitati investimenti irreversibili e questo le offre maggiori opportunità di “ricombinazione” dei fattori, maggiore versatilità nei confronti dell’innovazione.
L’interazione che lega le imprese nel distretto può contribuire ad aumentare la propensione ad innovare delle pmi, perché riduce i rischi legati all’incertezza tecnologica di nuovi processi e prodotti e alla difficile appropriabilità dell’innovazione.
Il network si pone nei confronti del cambiamento tecnologico come una struttura organizzativa che costituisce un’alternativa intermedia sia al mercato libero e “anonimo” (faceless market) sia rispetto all’impresa internazionalizzata. Rispetto al primo, il network riduce i costi di transazione (informazione e coordinamento) legati al cambiamento tecnologico; rispetto alla seconda presenta maggiore flessibilità ma minori garanzie sull’appropriabilità. Resta infatti il problema dei free riders che possono avvantaggiarsi dell’attività innovativa svolta nel distretto.[6]
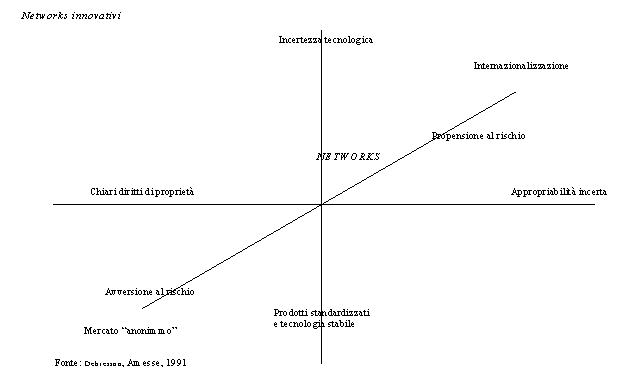
C’è poi da analizzare l’aspetto relativo al tipo di innovazione che viene immessa nel distretto. La rete di pmi reagisce in maniera efficiente all’innovazione incrementale, generalmente non trasferibile senza il supporto di una conoscenza tecnologica di base, che nel network costituisce un patrimonio comune, la cui diffusione è garantita da un insieme di regole tacite e informali[7], dalla mobilità e dai contatti interpersonali tra i tecnici. L’innovazione radicale porta invece conseguenze diverse. Se il sistema di “regole” non funziona e l’innovazione è appropriata da uno o pochi membri della rete produttiva, si creano delle leadership che fanno perdere al distretto la sua natura di “organizzazione orizzontale” e producono dipendenza delle altre imprese nei confronti dell’innovatore[8].
Le pmi in Italia
Il sistema produttivo italiano presenta aspetti che hanno favorito nel tempo la piccola e media imprenditoria e, in alcune zone, il formarsi dei distretti industriali. A questo riguardo Brusco individua alcuni fattori specifici che hanno contribuito al radicarsi del fenomeno: la preesistente prevalenza della forma di conduzione mezzadrile, la preesistenza di una rete di piccole città, l’esperienza, eventualmente conclusa o fallita, di imprese di dimensioni apprezzabili e di qualche rilievo tecnologico, una struttura di formazione professionale efficiente e l’azione accompagnatrice delle autorità locali.[9]
In più va sottolineato che i distretti industriali sono caratterizzati da omogeneità sociale e culturale, dalla presenza di una competenza diffusa che dà risalto al ruolo del capitale umano.[10]
Nell’organizzazione del distretto hanno un ruolo importante le istituzioni locali: i governi regionali e locali, le banche, le scuole professionali forniscono sostegno pubblico, risorse finanziarie e forza lavoro qualificata alle imprese. Le associazioni impegnate nell’export e nella distribuzione aiutano a superare i problemi che le piccole imprese incontrano nel collocare i loro prodotti sui mercati interni ed internazionali[11].
Nel panorama delle pmi italiane si possono individuare, sempre secondo Malerba, tre tipi di imprese: quelle comprese nei distretti industriali, le produttrici di meccanica strumentale e le imprese impegnate in settori tradizionali.
Per quel che riguarda i distretti, la loro dimensione innovativa ottimale è conformemente a quanto sopra si accennava, quella dell’innovazione incrementale. Per le innovazioni di prodotto si tratta in genere del risultato delle specializzazioni nel design di prodotto e dell’abilità di venire incontro alle richieste ed ai bisogni dei consumatori; quanto alle innovazioni di processo, derivano spesso dal learning by doing in specifiche fasi di produzione. Generalmente sono impegnati in settori a tecnologia matura e dislocati per al maggior parte in regioni centro-settentrionali come i distretti tessili di Prato, Como, Biella e Carpi; quelli calzaturieri di Vigevano, Barletta, Casarano; quelli orafi di Valenza Po ed Arezzo e così via. Alcuni di questi distretti esistono da alcuni decenni (come quelli tessili del Nord Italia); altri si sono sviluppati a partire dagli anni ‘60 e ‘70 (Prato e Sassuolo).
Il secondo gruppo, quello impegnato nella produzione di macchinari, è costituito da imprese spesso innovative e competitive in ambito internazionale. Questa compagine si caratterizza per un’elevata imprenditorialità ed una forte natimortalità aziendale: molte nuove imprese vengono avviate da tecnici ed ingegneri usciti da altre aziende dello stesso ramo, oppure create dai grandi clienti abituali.[12]
Gli operatori di questo settore generano flussi continui di innovazioni incrementali. Spesso si tratta di innovazioni mirate a risolvere specifici problemi tecnici dell’utente; il learning by interacting tra produttore e cliente gioca in questi casi un ruolo fondamentale nel processo innovativo: il miglioramento e le modifiche dei prodotti esistenti e la creazione di prodotti nuovi sono dovuti all’attitudine dei produttori ad adattarsi ai bisogni dei clienti ed a mettere a punto attrezzature specifiche per determinati segmenti di mercato.
La maggior parte di queste imprese non ha laboratori in cui svolgere ReS formalizzata: la loro conoscenza è spesso tacita, incorporata in ingegneri e personale tecnico. Non mancano però i legami con il mondo della ricerca ufficiale (ad esempio con centri di calcolo, laboratori di engineering delle Università) o il ricorso a consulenti per la soluzione di problemi specifici. In tali casi queste imprese si pongono in funzione di tramite fra gli utilizzatori e le istituzioni di ricerca: si fanno interpreti degli specifici problemi tecnici dei primi e li pongono alle seconde, fungendo da veicolo per un moto innovativo che ha la sua origine nel mercato.[13] Qualcosa di simile avviene per le pmi a cui le grandi imprese delegano compiti di subfornitura: queste sollecitano prestazioni sempre più efficienti ed affidabili e le piccole aziende fornitrici si adeguano avviando meccanismi di innovazione che possono essere definiti market pull in quanto trainati dalla domanda fronteggiata dalle grandi imprese in funzione delle quali lavorano.
Un ultimo gruppo di imprese - il più eterogeneo - è quello che opera nelle industrie tradizionali senza essere però inserito nell’ambito dei distretti industriali. L’attività innovativa di queste unità è legata, per le innovazioni di prodotto, alla capacità di adattamento dei prodotti alle esigenze di mercato. Quanto alle innovazioni di processo, esse consistono nell’acquisto di nuovi macchinari; per i settori del tessile e dell’abbigliamento, in particolare, queste imprese beneficiano dell’attività innovativa svolta a monte dai fornitori di attrezzature.
Tipi di innovazioni introdotti nelle pmi
Le pmi, che di solito hanno un numero ridotto di linee di prodotto o si concentrano in una o poche fasi di produzione di determinati beni, possono introdurre combinazioni di innovazioni più limitate rispetto alle grandi imprese, che operano a più vasto raggio, gestendo in proprio vari stages produttivi ed immettendo sul mercato una molteplicità di prodotti. A puntare sulle innovazioni di soloprocesso sono principalmente le pmi che operano nella subfornitura; quelle che invece hanno diretto accesso al mercato innovano anche, e spesso, nei prodotti.[14] In una recente indagine ISTAT sull’innovazione[15], risulta che la quota di aziende che introduce innovazioni di solo prodotto o solo processo è più alta tra le pmi che tra le grandi imprese, a prescindere dai settori di appartenenza (17,8% per le imprese con meno di 50 addetti; 11,2% per quelle con 1000 addetti ed oltre, riguardo alle innovazioni di solo prodotto; per quelle di solo processo, si aveva addirittura un 23,4% delle pmi contro il 7,4% delle grandi imprese).
Al contrario, le imprese che compiono innovazioni sia di prodotto che di processo sono più spesso le grandi (81,4%) che le piccole (58,8%).[16]
Spese innovative
Quanto poi all’impegno di spesa per le attività innovative, il passaggio da una visione “lineare” del processo innovativo, che riconduceva il cambiamento tecnologico principalmente all’attività di ricerca e sviluppo, al riconoscimento della molteplicità delle fonti innovative, ha indotto a prestare attenzione, oltre che alla spesa per ReS industriale, anche a quella per altre forme di attività innovative. Così, accanto alla generazione di conoscenze tecnologiche, hanno trovato rilievo le attività di adozione e diffusione delle tecnologie, elementi indispensabili per il pieno manifestarsi dell’impatto economico delle innovazioni.
Dalla citata indagine ISTAT è emerso che le spese per ReS restano un elemento centrale (35,8% delle spese innovative sul fatturato), ma la voce più importante (47,2%) riguarda l’adozione e diffusione di innovazioni attraverso l’acquisto e l’utilizzo di tecnologie incorporate in beni di investimento. Tale distribuzione di spese innovative registra una significativa variazione se si guarda alle dimensioni d’impresa: a privilegiare la ricerca rispetto agli investimenti sono le grandi aziende (47% contro 40,8%) mentre le piccole imprese innovano principalmente acquistando tecnologia incorporata (64,6% contro il 14,9% destinato alla ReS).[17] E’ evidente che il ricorso alla ReS è legato alla dimensione aziendale.
Per quel che riguarda le spese per altre attività innovative, come la progettazione, l’ingegnerizzazione, il marketing, le produzioni di prova, si può notare esse come, nelle imprese piccole e medie, abbiano un’incidenza maggiore che nelle grandi (11,7% del fatturato nelle imprese con più di 1000 addetti, mentre le fasce comprese tra i 20 e i 49 addetti, tra i 50 ed i 99, e quella tra i 100 e i 199 presentano rispettivamente un peso del 19%, 18,6% e 21,8% sul fatturato per questi tipi di spese: v. Tabella 1).
Un altro rilievo importante nell’ambito della distribuzione delle spese riguarda l’elevata propensione delle piccole aziende ad internalizzare le innovazioni prodotte all’esterno dell’impresa: difatti l’acquisizione di brevetti e licenze, ma soprattutto gli investimenti innovativi rivestono quote mediamente più consistenti tra le pmi che tra le grandi imprese (v. Tabella 1).
Tabella 1: distribuzione delle spese innovative per dimensione d’impresa (valori percentuali)
| Classi di addetti | ReS | Brevetti e licenze | Progettazione | Produz. prova | Marketing | Investimenti | Totale |
| 20-49 | 14,9 | 1,5 | 9,4 | 7,7 | 1,9 | 64,6 | 100 |
| 50-99 | 16,3 | 1,3 | 8,4 | 8,5 | 1,7 | 63,8 | 100 |
| 100-199 | 19,8 | 1,7 | 12,8 | 9,0 | 2,2 | 54,5 | 100 |
| 200-499 | 27,6 | 2,2 | 9,1 | 9,6 | 2,2 | 49,3 | 100 |
| 500-999 | 26,0 | 1,6 | 13,4 | 8,1 | 1,3 | 49,6 | 100 |
| 1000 e oltre | 46,7 | 0,8 | 4,8 | 5,7 | 1,2 | 40,8 | 100 |
| Totale | 35,8 | 1,2 | 7,4 | 6,9 | 1,5 | 47,2 | 100 |
|
Fonte: ISTAT, 1995 |
|||||||
Una scarsa propensione ad investire in ricerca, dunque, da parte delle piccole unità produttive, che privilegiano altre forme di attività innovative.
Al di là degli indicatori di input consistenti nelle spese sostenute dalle imprese per le attività innovative, l’indagine ISTAT rileva anche indicatori di output, tra cui la distribuzione del fatturato delle aziende in quote “imputabili” all’applicazione dei diversi tipi di innovazione: in questo modo si può quantificare l’impatto economico dell’innovazione sulla produzione, la sua ricaduta in volume d’affari.
In generale, la quota di fatturato legata a prodotti innovativi, o che comportino per l’azienda anche solo l’introduzione di innovazioni di processo, è superiore a quella attribuibile a prodotti non innovativi. Infatti in media i prodotti nuovi, migliorati o legati a nuove soluzioni di processo hanno avuto un impatto del 55,4% sul fatturato delle imprese.
Tale fenomeno risulta più evidente nelle piccole che nelle grandi imprese. La spiegazione può essere trovata principalmente nel fatto che la produzione di queste ultime è notevolmente più differenziata rispetto a quella delle prime, come sopra si accennava. Mentre per le grandi imprese l’introduzione, spesso congiunta, di prodotti o soluzioni innovative si “disperde” nel complesso di linee di prodotti e fasi di produzione che si svolgono al loro interno, per le piccole aziende anche l’adozione di nuovi macchinari o il miglioramento di un prodotto ha un significato più grande.
Quanto ai rapporti con gli altri attori del sistema innovativo, in particolare all’ attitudine a comunicare con il mondo della ricerca ufficiale, si può dire che questa sia piuttosto limitata. Nonostante il dinamismo di alcune pmi, i contatti con le università ed i centri di ricerca sono poco sviluppati. Una spiegazione è nella difficoltà di raccordare il sapere non codificato, diffuso, “contestuale” proprio delle pmi e quello codificato e formale dei laboratori di ricerca.[18]
Le grandi imprese impegnate nell’alta tecnologia
Il sistema innovativo più tradizionalmente inteso è quello composto da grandi aziende operanti nei settori ad alta tecnologia, la cui produzione passa continuamente al vaglio della concorrenza internazionale, e che svolgono al loro interno attività di ricerca e sviluppo, mantenendo contatti costanti con il mondo della ricerca ufficiale, non solo per applicarne i risultati nel processo produttivo e raccoglierne le eventuali ricadute in termini economici, ma anche per tenere aperti tutti i canali d’informazione ed aggiornarsi sulle evoluzioni della ricerca.
In Italia, però, il core che gravita attorno all’alta tecnologia non ha raggiunto i livelli di sviluppo di altri grandi Paesi industrializzati. I motivi di questa inadeguatezza sono da cercare nel limitato numero di grandi imprese tecnologicamente avanzate, che operano in oligopolio; nel loro scarso grado di internazionalizzazione.
Nonostante nel panorama produttivo questo tipo di operatori sia di solito quello più impegnato nella ricerca, in Italia le grandi imprese investono in ReS meno di quanto fanno in altri Paesi le loro omologhe. Si aggiunga che la domanda nazionale (specialmente quella pubblica) raramente stimola l’introduzione di innovazioni da parte dei produttori, essendo essa stessa poco innovativa. Quanto ai rapporti tra gli attori del sistema innovativo, la trasmissione e l’interfaccia tra Università, centri di ricerca ed industria avviene attraverso meccanismi poco sviluppati. Inoltre, la politica pubblica di sostegno all’innovazione nei settori di alta tecnologia finora si è rivelata poco organica nelle sue diverse forme di intervento.
In Italia, l’attività di ricerca e sviluppo, come quella brevettuale, si concentrano in un limitato numero di grandi imprese: concentrazione che nel nostro Paese si incontra in misura più accentuata rispetto ad altri, e che può essere considerata una caratteristica del sistema innovativo italiano. Si tratta di pochi grandi gruppi, impegnati nei settori automobilistico, chimico, farmaceutico, elettronico e della gomma.
Le fonti innovative in questi campi e l’organizzazione del processo innovativo sono simili a quelle che si incontrano in grandi imprese di altri Paesi; le innovazioni scaturiscono spesso da ReS svolta all’interno degli impianti, da attività di engineering e design, gli operatori principali collaborano con altre imprese all’interno dello stesso gruppo industriale per contratti di ricerca e sviluppo esterni. E’ abbastanza frequente la cooperazione con istituzioni di ricerca pubblica (CNR, ENEA). C’è da notare che per quel che riguarda l’intensità di ReS a livello di singolo prodotto, le imprese italiane non sono tanto indietro rispetto ai competitori esteri. E’ bassa invece l’intensità di ReS a livello dell’intero Paese, e questo si deve al fatto che le imprese italiane operano in genere su prodotti a basso contenuto tecnologico.
Negli anni ’80 questo ristretto club di grandi aziende si è reso protagonista della crescita dell’impegno industriale nella ricerca e sviluppo che, secondo Malerba, è stata “la continuazione di un processo di accumulazione tecnologica cominciata da alcune di queste imprese durante gli anni ’50 ed i primi anni ’60, e interrotta negli anni ’70.”[19] Nel periodo di ricostruzione subito dopo la guerra, infatti, cominciarono ad emergere alcuni operatori in determinati settori, come Olivetti nei computer, Lepetit nella farmaceutica, Donegani (Montedison) nella chimica, il CNEN e l’INFN nell’energia nucleare. Ma a tali rilevanti risultati di ricerca non erano legate applicazioni industriali su larga scala ed attività di supporto come design, engineering e marketing. Mancava un reale coinvolgimento nelle attività legate all’alta tecnologia; si aggiunsero i problemi derivanti dall’ aumentato costo del lavoro. La conseguenza fu che varie imprese interruppero i loro sforzi nella ricerca e perseguirono il contenimento dei costi e un’efficienza statica, piuttosto che privilegiare le prospettive dinamiche offerte dall’impegno nell’innovazione tecnologica. Si affermava dunque una tendenza fortemente pro-ciclica degli investimenti dell’industria italiana nella ricerca e sviluppo: al profilarsi dei primi segnali di crisi, i primi a cadere sono stati i progetti di ricerca a rendimento più differito.[20]
Nei primi anni ’80, la ristrutturazione produttiva ed il ritorno al profitto permisero alle imprese italiane a tornare ad investire in ReS. Questo nuovo impegno si concentrava in specifiche aree tecnologiche, legate alla specializzazione produttiva delle varie imprese, che inoltre sviluppavano accordi verticali ed orizzontali di cooperazione con istituzioni ed altre imprese.
Le piccole imprese innovative
Sono parte integrante del core innovativo italiano anche alcune piccole imprese hi-tech che operano nell’elettronica, nel software, nella biotecnologia e nei servizi. Alcune hanno consolidati vincoli di collaborazione con grandi imprese del proprio settore, come le piccole aziende impegnate nell’elettronica nella zona del Canavese, vicine all’Olivetti, o le società di software e servizi nell’area di Milano. Altre sono legate a parchi scientifici.
Distinguo queste imprese dal tessuto di pmi di cui ho precedentemente analizzato le caratteristiche perché esse si pongono in maniera diversa nei confronti dell’innovazione.
Il processo innovativo si concentra nel design, nelle attività di ricerca, non sempre formalizzate in laboratori di ricerca e sviluppo. Si nota in queste imprese una certa apertura alle cooperazioni con l’esterno nel campo della ricerca, soprattutto da parte di quelle imprese che più hanno sviluppato capacità tecnologiche al proprio interno.
Una forma di innovazione diffusa in questo gruppo di operatori è l’introduzione di componenti, hardware e software, nel sistema produttivo: di solito si tratta di strategie mirate a specifiche applicazioni finali o adottate in funzione di determinati clienti.
I fattori che determinano la nascita di nuove piccole imprese innovative sono le condizioni della domanda in determinati segmenti di mercato e le cosiddette “interdipendenze dinamiche”[21]. In settori come il software, o l’elettronica, ottengono successo imprese che offrono prodotti atti a soddisfare esigenze specifiche dei clienti, che utilizzano le tecnologie esistenti adattandole a nuove applicazioni o a potenziali utilizzatori. Si tratta di aziende entrate in segmenti di mercato legati a determinati prodotti, e che hanno raggiunto elevate capacità tecnologiche senza arrivare ad avere allo stesso tempo grandi dimensioni. Sono più rari i casi in cui l’entrata di nuove imprese sul mercato è legata all’introduzione di prodotti nuovi basati sull’innovazione tecnologica.
Per interdipendenze dinamiche si intende quel fenomeno per il quale le capacità avanzate proprie dell’industria che le ha sviluppate e consolidate diventano fattori di propulsione per industrie nuove, come nei casi in cui le tecnologie avanzate nelle produzione di macchinari industriali è legata allo sviluppo dell’industria robotica.
Insomma le piccole imprese che innovano non sono svantaggiate rispetto alle grandi, anzi, si pongono sul loro stesso livello; la questione è, più che altro, che esse rappresentano solo una piccola quota delle pmi. Si pone quindi, a questo riguardo, il problema di allargare, più che di intensificare, la base innovativa.[22]
Ad influenzare il funzionamento del core innovativo italiano concorrono, poi, altri fattori, come le condizioni generali della domanda, l’internazionalizzazione del sistema produttivo ed i rapporti dell’industria con le Università ed i centri di ricerca.
Per quel che riguarda le condizioni della domanda in Italia, si può dire che non abbiano stimolato l’introduzione di innovazioni: le grandi imprese hanno generalmente preferito acquistare all’estero componenti ed attrezzature avanzate che non fossero disponibili in patria, piuttosto che incentivarne la potenziale offerta innovativa all’interno del Paese. Si invoca un ruolo più incisivo in questo senso anche della domanda pubblica[23], che finora raramente ha contributo con consapevolezza a stimolare le capacità innovative del mondo produttivo: di solito la pubblica amministrazione si è limitata ad acquistare prodotti esistenti da produttori che usavano tecniche collaudate. D’altra parte l’operatore pubblico è legato a ingombranti procedure burocratiche, a normative complesse. Anche la domanda militare, che in molti Paesi è un fattore importante di progresso tecnologico, in Italia è quantitativamente minore e più propensa all’importazione rispetto ai partners internazionali.
Lo scarso grado di internazionalizzazione ha funzionato da schermo protettivo per l’industria italiana, che ha operato in qualche modo al riparo dall’intensa competizione tecnologica internazionale. Il sistema delle multinazionali italiane è polarizzato: da una parte poche grandi holding che detengono la maggior parte degli investimenti italiani all’estero; dall’altra, un buon numero di imprese piccole e medie, impegnate in settori che vanno dall’alta tecnologia alla manifattura tradizionale poco presenti con i loro investimenti sulla scena internazionale. Inoltre le aziende italiane all’estero, più che alle tecnologie, mirano ad inserirsi in specifiche nicchie di mercato.[24]
Solo di recente l’Italia si è portata in una posizione che altri Paesi hanno raggiunto da diversi anni, quella del saldo attivo degli IDE. In passato la quota di investimenti esteri in Italia è stata ben superiore a quella degli investimenti italiani all’estero, e soprattutto negli anni ’60 e ’70 ha svolto un ruolo insostituibile per la formazione di settori tecnologicamente avanzati nel Paese (soprattutto i comparti elettronico e chimico): col tempo, però, gli investimenti greenfield hanno lasciato il posto ad acquisizioni di attività preesistenti e la strategia delle imprese multinazionali in Italia si è orientata a impadronirsi di quote di mercato, al controllo di marchi e di canali distributivi. L’apporto di modernizzazione tecnica dall’estero è, così, fortemente diminuito. Da parte loro, le imprese di alta tecnologia, che altrove sono protagoniste dei processi di internazionalizzazione, non hanno raggiunto in Italia una forza paragonabile a quella delle loro omologhe in altri Paesi e di conseguenza sono meno partecipi di questo processo (per quanto investano all’estero più della media delle imprese manifatturiere italiane).
Quanto ai rapporti dell’industria italiana con le Università e gli istituti di ricerca pubblica, un altro punto debole del sistema innovativo italiano è rappresentato dai meccanismi di interfaccia tra questi operatori, che sono meno sviluppati che in altri Paesi. Sono pochi i centri di eccellenza nelle Università, limitata la mobilità dei ricercatori sia dentro che fuori il sistema universitario; la collaborazione dei centri di ricerca pubblici e degli atenei con le imprese è resa difficile dalla pesante struttura burocratica.
Osservazioni
La crescita innovativa degli anni ‘50 e ‘60 ha visto in primo piano settori di produzione a basso contenuto tecnologico. Le difficoltà degli anni ‘70, dovute all’aumento del costo del lavoro e dell’energia, sono state superate grazie ad un processo di ristrutturazione che ha raggiunto il suo compimento negli anni ‘80 e che ha dato al complesso industriale italiano un profilo particolare. Nel decennio scorso è cominciato un processo di convergenza con gli altri Paesi maggiormente industrializzati, che, se può dirsi compiuto dal punto di vista economico, non lo è da quello tecnologico. Sicché per l’Italia si pone il problema di scegliere se restare un Paese tecnologicamente “inseguitore” o se puntare su alcuni settori in cui portarsi all’avanguardia per garantirsi una crescita futura su basi tecnologiche più avanzate e stabili.
L’evoluzione passata ha fatto emergere due subsistemi innovativi. Uno è formato dal tessuto delle piccole e medie imprese, specializzato in settori tradizionali, caratterizzato da un forte legame con l’ambiente in cui le imprese si collocano e da una certa omogeneità di condizioni tecniche. L’attitudine al cambiamento tecnologico qui si manifesta con innovazioni incrementali, miglioramenti degli impianti esistenti, rapida diffusione delle novità tra produttori che interagiscono con gli utenti e fra di loro. L’impegno nella ReS formalizzata è comprensibilmente scarso ed i contatti con la ricerca pubblica ed universitaria non sono frequenti. Ma si può dire che nel complesso, il livello tecnologico raggiunto dalle piccole e medie imprese è considerevole tenendo conto delle caratteristiche che le contraddistinguono.
Meno soddisfacenti, invece, le prestazioni innovative del core tecnologico composto da grandi imprese, piccole aziende innovative e strutture di ricerca. I suoi punti deboli sono nell’impegno profuso nella ReS, che si rivela minore rispetto a quello dei concorrenti internazionali, nel limitato numero di grandi imprese tecnologicamente avanzate, che agiscono in oligopolio, nella loro scarsa internazionalizzazione. Ci sono piccole imprese che operano nell’ hi tech con risultati ragguardevoli, ma sono poche. La difficoltà e macchinosità dei rapporti con i centri di ricerca e le Università, le condizioni “deboli” della domanda e l’intervento pubblico poco organico non creano, inoltre, un contesto favorevole e stimolante per l’attività innovativa.
Il sistema produttivo italiano ha mostrato di avere grande vitalità, affrontando le difficoltà con mezzi che lo rendono unico: forti imprenditorialità individuali e familiari, consolidati legami con il territorio.[25] Ma a questi fattori, che hanno permesso a determinate realtà produttive italiane di aver successo esaltandone lo spirito di adattamento alle esigenze del mercato se ne contrappongono altri, come un core tecnologico altamente concentrato, la difficoltà a gestire vaste organizzazioni ed un intervento pubblico poco incisivo, che non hanno portato il sistema di ReS ad essere competitivo a livello internazionale.
[1]LEONCINI: “Progresso tecnologico incrementale e radicale. Nozione di sistema tecnologico”, in Economia e politica industriale, 1996, n.89, p.104.
[2] LUNDVALL: “L’economia dell’apprendimento”, in Economia e politica industriale, n.89, p.141.
[3] MARIOTTI, ”Internazionalizzazione e fattori tecnologici nell’industria italiana” in Economia e politica industriale, 1993, n.79, pp.240-41.
[4]ARCHIBUGI, CESARATTO, SIRILLI : “Fonti delle conoscenze tecnologiche e organizzazione industriale: una riconsiderazione critica”, in Rivista di Politica Economica, 1988, n.2, pp.166-170.
[5] MALERBA: “The national innovation systems: Italy” in NELSON: “National systems of innovation”, 1993, pp.230,231.
[6] DE BRESSON, AMESSE, in Research Policy, n. 20, 1991, p.365-66.
[7] BIANCHI, BELLINI, “Public policies for local network of innovators” in Research Policy, n.20, 1991, p.491.
[8] MAGGIONI, “The economic analysis of science and technology parks: theoretical suggestions and the italian experience”, in Sviluppo Economico, vol1, 1994-95, p.154.
[9] BRUSCO, “Small firms and industrial districts: the experience of Italy”, in Economia internazionale, luglio 1986, p.85.
[10] BECATTINI, “Commento alla relazione di Brusco”, in Economia internazionale, luglio 1986, p.99.
[11]MALERBA, 1993, op. cit., p.236.
[12]MALERBA, 1993, op. cit., p.238.
[13] BARABASCHI, “Nuotare in mare aperto”, in Industria e sindacato, 1997, n.1, p.35.
[14]BARABASCHI, op.cit., p.35.
[15]ISTAT: “Indagine statistica sull’innovazione tecnologica”, anni 1990-92, Roma, 1995.
[16] BARBIERI, RAPITI: “I risultati diell’indagine ISTAT sull’innovazione tecnologica: aspetti strutturali e diffusione del fenomeno con particolare riferimento alle dimensioni d’impresa”, in “Innovazione e risorse umane nell’economia della conoscenza”, CNR-ISRDS, 1996, p.55
[17] ARCHIBUGI, EVANGELISTA, PERANI: “La spesa per l’innovazione delle imprese italiane”, in “Innovazione e risorse umane nell’economia della conoscenza”, CNR-ISRDS, 1996,pp.70-71
[18] ALESSANDRINI, STERLACCHINI: “Ricerca, formazione e rapporti con l’industria: i problemi irrisolti dell’Università italiana”, in Economia e politica industriale, 1995, n.89, p.47.
[19] MALERBA, 1993, op. cit., p.249.
[20] ALESSANDRINI, STERLACCHINI, 1995, op. cit., p.41.
[21] MALERBA, 1993, op. cit., p.250.
[22] ARCHIBUGI, EVANGELISTA, PERANI, op. cit., p.75.
[23] Nel Rapporto OCSE su “Tecnologia, produttività, e creazione di occupazione” del 1996 il ruolo potenziale dei governi nello stimolare una domanda tecnologicamente più esigente è così sottolineato: “I governi hanno un importante compito nel dare forma ai mercati emergenti di servizi collegati in rete, sia direttamente, in quanto consumatori, sia nel fornire alla società e agli agenti economici una prospettiva di come le nuove attività potranno nascere e svilupparsi…Come grandi potenziali utenti dei servizi d’informazione e comunicazione per le proprie esigenze interne e per i servizi al pubblico, i governi possono favorire lo sviluppo di nuove applicazioni, stimolare la loro diffusione e rendere familiare al pubblico il loro utilizzo…I governi dovrebbero aumentare gli sforzi per facilitare l’accettazione sociale, incoraggiando la comprensione da parte dell’opinione pubblica della scienza e della tecnologia e del loro impatto, in modo da stimolare la domanda di consumo di nuovi prodotti e servizi e rendere più facile l’adattamento dei lavoratori ai mutamenti dei requisiti di capacità professionale e di apprendimento.”
[24] REVIGLIO, “Internazionalizzazione e sviluppo delle imprese pubbliche”, in “L’impresa innovativa”, a cura di Carlo Maria Guerci, Milano, 1988, Edizioni Sole 24 Ore, pp.234,235.
[25]MALERBA, 1993, op. cit., p.257.