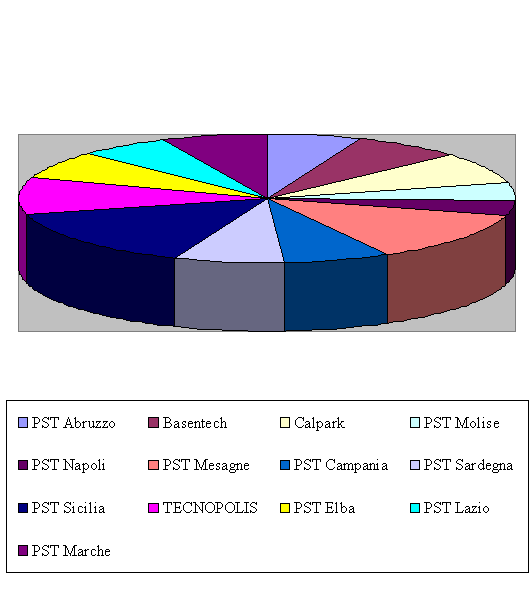CAPITOLO IV
STRUTTURE PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
In un’economia come la nostra, che assegna un ruolo chiave a sviluppo, scambio e diffusione di conoscenze nel contesto produttivo, i canali attraverso i quali i risultati della ricerca possono raggiungere le imprese e diventare innovazioni rivestono un’importanza essenziale. Soprattutto per quelle fasce produttive che , per vari motivi, non svolgono attività di ReS e sono distanti dalle istituzioni accademiche e dai centri di ricerca, come le pmi e le imprese che operano in settori a tecnologia medio-bassa (e che comunque sono interessate alle innovazioni, quanto meno di processo).
Il sistema produttivo italiano presenta una rilevante presenza di piccole e medie imprese: un panorama eterogeneo, che si confronta con la ricerca con approcci differenti, opera in tecnologie mature, medie ed in alcuni casi nuove, ha punte di eccellenza per quel che riguarda l’introduzione di innovazioni, esporta molto e crea occupazione. Si tratta di imprese molto legate alle proprie realtà locali, a volte parte di realtà più articolate (distretti, rapporti di subfornitura con grandi aziende), che impiegano generalmente manodopera qualificata. Per questo la diffusione di conoscenze legata al territorio dovrebbe andare incontro alle particolari esigenze di questo tipo di imprese.
In generale l’efficacia dei flussi informativi è importante per garantire alle imprese l’accesso a innovazioni legate a studi e ricerche che si svolgano, come spesso accade, in ambiti diversi da quello produttivo.
Tra gli strumenti di diffusione si hanno la letteratura scientifica, le mostre e le fiere tecnologiche.
Ma la peculiarità del nostro sistema produttivo richiede di considerare il peso della dimensione «locale» in cui molte imprese agiscono, e a portare la politica della ricerca e dell’innovazione nel quadro delle specifiche aree territoriali, il cui sviluppo richiede (ovvero è favorito con) un’accelerazione dei processi di diffusione dell’innovazione e l’organizzazione di canali per la mobilità della conoscenza e delle tecnologie sul territorio.
È opportuna, quindi, la creazione, a livello locale, di sistemi di cooperazione organizzata tra soggetti diversi per la promozione e la diffusione di nuove attività e nuove imprese, la presenza di strutture per l’accesso e l’utilizzo di tecnologie, a cui gli operatori di mercato coinvolti nel processo innovativo possano fare riferimento.
Le strutture di servizio reale
Una delle modalità secondo cui avviene la conversione applicativa dei risultati della ricerca (trasferimento tecnologico) è la predisposizione di centri di servizi reali alle imprese, particolarmente importante in un tessuto produttivo con le caratteristiche sopra esposte, perché incentrato sul decisivo legame impresa-territorio e tarato per aziende di dimensioni medio-piccole.
Questo tipo di struttura sta trovando in Italia una certa diffusione. Si tratta di centri creati su iniziativa o in collaborazione con soggetti pubblici locali: assumono forma giuridica autonoma, di solito privatistica. Le imprese partecipano direttamente al capitale sociale, mentre la presenza pubblica tende a diminuire progressivamente nel tempo, pur conservando una propria rappresentanza nei consigli di amministrazione, per assicurare la continuità degli scopi perseguiti.
I servizi offerti da questi centri mirano a «incidere in maniera strutturale sui processi di modernizzazione e di sviluppo delle imprese locali»[1].
Questi interventi operano in quattro direzioni: diffusione dell’innovazione, promozione di relazioni tra le imprese, funzioni interne alle imprese ed economie esterne.
Gli strumenti per la diffusione delle informazioni operano a vari livelli: dalla divulgazione ad ampio raggio al sistema produttivo regionale, all’assistenza in materie di legislazione e normative tecniche fino alla consulenza diretta alla singola impresa. Rientrano in questo genere: le Agenzie regionali per la modernizzazione tecnologica delle imprese minori; i Consorzi Città Ricerche, promossi dall’IRI, dal CNR e dall’UnionCamere nelle più importanti aree metropolitane, i Centri di ricerca applicata nel Meridione, nati con il Progetto speciale 35/1976 e l’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea).
Quest’ultima operava presso il MURST come Task-force Ricerca Europea già dal 1989: nel 1990 è diventata Associazione senza scopo di lucro, costituita da ENEA, FAST, Confindustria e Mondimpresa, e sostenuta, in fase di avvio, dal MURST e dalla Comunità. In seguito il numero dei soci è cresciuto e l’APRE ha esteso la sua presenza sul territorio nazionale con sportelli a Milano, Genova, Bologna, Trieste, Venezia, Torino, Ancona e Cagliari. Nel 1992 l’UE le ha attributo la funzione di Relay Centre per l’Italia. Il suo contributo è stato importante per il miglioramento dell’informazione riguardante i programmi di ricerca comunitari.
Quanto agli Innovation Relay Centers, si tratta di strutture atte ad assistere le imprese, soprattutto piccole e medie, nel loro rapporto con l’innovazione: gli obiettivi sono l’assistenza alla partecipazione a programmi di ricerca industriale, sviluppo tecnologico e cooperazione commerciale finanziati dall’Unione Europea, l’individuazione delle esigenze tecnologiche aziendali, il reperimento e la diffusione di informazioni tecnico-economiche e l’individuazione di partner per progetti di sviluppo tecnologico. Le attività svolte generalmente consistono in seminari e workshop informativi, visite aziendali atte ad individuare specifiche esigenze ed a prospettare appropriate soluzioni ai problemi tecnologici già segnalati dall’impresa, ricerche di partnership e diffusione di informazione sui programmi comunitari, nazionali e regionali di sostegno all’innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo economico e imprenditoriale.
L’Unione Europea ha selezionato, nel 1994, sette Relay Centers per l’Italia: ALPS, che opera in Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, coordinato dalla Camera di Commercio di Torino; LARICE, IN Lombardia, coordinato dal Consorzio MIP Politecnico di Milano; IRENE per il Triveneto, l’Emilia Romagna e le Marche, coordinato dall’ENEA di Bologna; il RECITAL, attivo in Toscana e Umbria (v. Case Study), coordinato dal Consorzio Pisa Ricerche; il CIRCE, per il Lazio e l’Abruzzo, coordinato dal CNR-UTIBNOT di Roma; il MEDIA, OPERANTE IN Calabria, Sicilia e Sardegna e coordinato dal Consorzio Catania Ricerche ed infine l’IRIDE, per la Campania, la Puglia, la Basilicata ed il Molise, che fa riferimento al Tecnopolis di Bari.
Gli strumenti di promozione di relazioni tra le imprese mirano a sviluppare o a rafforzare le reti di relazioni che legano tra loro gli operatori di un distretto industriale, per favorirne la cooperazione nell’organizzazione produttiva. Le prime iniziative di questo genere si sono avute in Emilia Romagna, dove hanno cominciato ad operare vari centri di servizi per le imprese, buona parte dei quali a carattere settoriale: CEMOTER (macchine movimento terra), CENTRO CERAMICO (ceramica), CERCAL (calzature), CESMA (macchine agricole), CITER (tessile e abbigliamento) e QUASCO (costruzioni). Sulla scia dell’esperienza emiliana, altre Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Toscana, Umbria) stanno sperimentando politiche analoghe nei confronti di concentrazioni di imprese operanti nella stessa area produttiva.
Il carattere specifico e settoriale di servizio alle imprese è evidente anche in iniziative come i Centri settoriali. L’ENEA, in collaborazione con le istituzioni locali e gli agenti economici presenti sul territorio, promuove Progetti di sviluppo tecnologico in «aree sistema « come i distretti tessili di Prato, Como e ceramico di Sassuolo.
Gli interventi sulle funzioni interne delle imprese hanno l’obiettivo di potenziarne determinate attitudini (internazionalizzazione, promozione e commercializzazione, qualità totale) per favorirne la competitività. Particolarmente importante risulta il controllo di qualità, che permette alle aziende di mantenere o migliorare le proprie posizioni in un panorama di piccoli operatori impegnati nella produzione di beni sempre più differenziati: in un contesto del genere, infatti, la qualità è un fattore discriminante. In varie aree sono sorte iniziative per l’offerta di servizi di prova, omologazione e certificazione, di informazione su normative e standard tecnici nazionali. Alcuni centri hanno l’obiettivo specifico di offrire alle imprese informazione (tecnologica, commerciale, sui risultati resi disponibili dalla ricerca), un risorsa che le aiuta nello svolgimento di varie funzioni interne.
Per quel che riguarda, infine, gli interventi atti a creare economie esterne, essi si basano sulla predisposizione di un ambiente favorevole alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese con la fornitura di servizi comuni, la concentrazione di attività di ricerca e stabili appositamente attrezzati. Operano in questo senso realtà come i Businness Innovation Center (BIC), i Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) e la Agenzie di sviluppo di area.
I Parchi Scientifici e Tecnologici
La funzione dei Parchi scientifici e tecnologici dovrebbe essere quella di promuovere lo sviluppo regionale puntando sulla ricerca e sulla diffusione delle innovazioni, coltivare le potenzialità tecnologiche di un’area creando esternalità che ne favoriscano la messa in atto, «accentuare la velocità creativa di sinergie che si possono impiantare nel circuito ricerca - innovazione - sviluppo competitivo». [2]
L’auspicio è che queste strutture agiscano come catalizzatori di forze ed interessi già presenti nella regione, inserendosi su una struttura economica ricettiva all’innovazione: è opportuno, quindi, che sul territorio in cui il Parco si colloca ci siano già determinate condizioni che ne favoriscano l’attività. L’ OCSE evidenzia, tra queste, la contiguità con Università e centri di ricerca, le possibilità di collegamento alle reti internazionali di trasporto e comunicazione.
Ciò che caratterizza il Parco, in qualunque contesto si collochi, è la sua azione di liason office, che crea, supporta e sviluppa una delicata rete di relazioni tra: a) istituti di ricerca, università; b) imprese; c) autorità pubbliche, istituzioni locali, cittadinanza. Lo svolgimento di questa funzione è favorito dall’instaurarsi di un ambiente che facilita la comunicazione informale tra il personale addetto alla ricerca e quello impegnato nella produzione, e dall’abbattimento degli ostacoli che frenano la mobilità delle risorse umane tra istituzioni accademiche e imprese.
Il Parco come Network
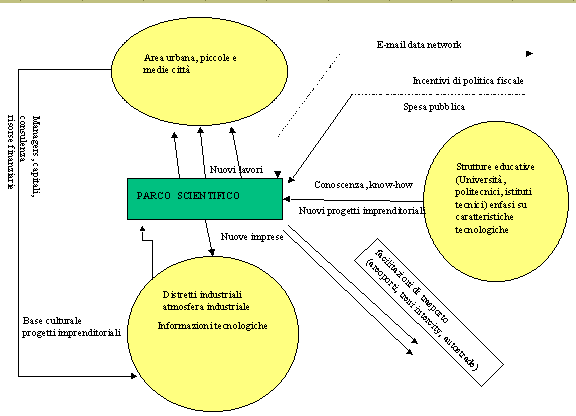
Fonte : Baldini, 1984[3]
Recentemente però l’approccio è cambiato, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, che rendono possibile il collegamento tra gli operatori interessati ai processi di ricerca ed innovativi, tanto che le ultime tendenze in fatto di localizzazione dei Parchi vedono prevalere aree non urbane, non a contatto con strutture universitarie né imprenditoriali.[4]
Definizione di Parco Scientifico
A partire dagli anni ‘50 si sono avute molte esperienze di Parchi, in aree geografiche e situazioni economiche diverse. In genere si tratta di organismi che attuano un collegamento tra sistema industriale e strutture di ricerca universitarie e governative. A seconda però del tipo di operatori coinvolti e del ruolo specifico svolto, si hanno varie tipologie di Parchi.
Alcune definizioni ufficiali hanno inquadrato la fisionomia del Parco scientifico come «un’area attrezzata, in prossimità di strutture universitarie e/o di ricerca avanzata (centri di eccellenza), posta in contiguità con aree urbane centrali, in grado di favorire l’insediamento di nuove attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico, anche sotto forma di imprese»[5] o come «iniziativa su base territoriale, situata in prossimità geografica di istituti di istruzione superiore o centri di ricerca avanzata, che presenta collegamenti operativi con tali organismi; è volta ad incoraggiare la creazione e la crescita di aziende basate su nuove conoscenze; promuove attivamente il trasferimento di tecnologia dalle istituzioni accademiche e di ricerca alle aziende ed alle organizzazioni insediate nell’ambito o nei pressi del Parco stesso». [6]
Le funzioni principali dei Parchi scientifici e tecnologici sono l’attività di ricerca, sviluppo e progettazione, la preparazione di nuovi prodotti ed il loro sviluppo fino all’arrivo al mercato. Le imprese che operano nel Parco di solito incentrano il loro lavoro di ReS sull’elaborazione di prototipi, delegandone altrove la fabbricazione: sono rari i casi in cui provvedono alla produzione diretta di elementi ad alta tecnologia.[7]
Altre esperienze sono state classificate come Parchi tecnologici (dove l’attività produttiva ha maggiore importanza che nei Parchi scientifici, perché comprendono imprese impegnate nella applicazione commerciale dell’alta tecnologia), Parchi di ricerca (la cui attività è principalmente di ricerca anziché di sviluppo e il cui elemento caratterizzante è il collegamento con le Università e gli istituti di ricerca), Centri di innovazione (che promuovono creazione di imprese ad alta tecnologia e forniscono loro servizi di consulenza finanziaria, commerciale e tecnologica; a volte sono inseriti in contesti più ampi come i Parchi tecnologici), Incubatori commerciali (dove si concentrano imprese nuove, a cui si cerca di garantire un certo tasso di sviluppo fornendo supporto manageriale, servizi comuni ed edifici: qui la componente tecnologica è spesso marginale), Parchi commerciali (lo scopo è creare un ambiente di alta qualità per una vasta gamma di attività, dalla produzione alla vendita: il collegamento con le strutture di ricerca è secondario), Tecnopoli (che cercano di valorizzare il potenziale universitario e scientifico presente su un territorio e metterlo a disposizione del tessuto industriale dell’intera regione), Poli tecnologici (dove si raggruppano tutte le attività strategiche per il processo innovativo, dalla formazione di capitale umano alla ricerca base e applicata, ai servizi finanziari e tecnici), Distretti tecnologici (in cui, sul preesistente distretto industriale si innesta il Parco tecnologico).[8]
L’avvento di nuove tecnologie di comunicazione ha cambiato radicalmente il modo di operare nella ricerca, e ha reso possibile una nuova struttura del Parco scientifico: ai Parchi tradizionalmente intesi, dotati di rilevanti impianti fisici, di personale permenente e di configurazione “burocratica”, si è affiancato un nuovo modello, quello del “Parco virtuale”, composto da una microstruttura che mette in relazione imprese, centri di ricerca ed Università, strutture istituzionali. Il Parco Virtuale opera come agenzia, avvalendosi delle più avanzate tecnologie di comunicazione e puntando sulla propria agilità per essere efficiente. Questo tipo di operatore persegue lo stesso obiettivo dei Parchi “immobiliari”, non creando nuove strutture in cui mettere in comunicazione i vari agenti, ma usando nuove modalità di approccio. Alla base c’è la consapevolezza di una domanda di innovazioni “latente” da parte di imprese (specialmente quelle medie e piccole) che hanno una chiara visione delle dinamiche di mercato e delle proprie esigenze di riduzione dei costi, ma non sempre colgono l’impatto delle tecnologie innovative nella loro produzione.[9]
L’esperienza dei Parchi: una panoramica internazionaleI primi esempi di Parchi scientifici si sono avuti negli Stati Uniti: attorno a grossi agglomerati di attività di ricerca altamente innovative si sviluppavano iniziative industriali d’avanguardia, di dimensioni medio-grandi (come la Silicon Valley e la Route 128 di Boston). In genere, alla base c’erano già un tessuto economico sviluppato ed una dotazione di infrastrutture sufficiente. Si ravvisa una certa differenza tra le prime esperienze degli anni ‘50, nelle quali i promotori erano soggetti privati (Università ed imprese) e l’operatore pubblico entrava principalmente dal lato della domanda (soprattutto per le commesse militari), e quelle successive degli anni ‘70, che hanno visto una maggior correlazione tra Parchi e contesto nazionale e una maggiore importanza assegnata alle fasi di trasferimento tecnologico e diffusione dell’innovazione.)
Un altro Paese in cui i Parchi sono stati considerati uno strumento importante è la Gran Bretagna. Anche qui si tratta di un contesto economicamente avanzato, dove la responsabilità dell’innovazione e affidata alle imprese che hanno accumulato in passato un vasto patrimonio scientifico, anche grazie ai tradizionali collegamenti con le Università. Legame che si è evoluto nel tempo in maniera sistematica e con il sostegno dell’operatore pubblico: si pensi al progetto »Link», che prevede finanziamenti per programmi di ricerca industriale svolti in collaborazione con Università ed enti di ricerca in settori come biotecnologie, materiali avanzati ed elettronica. Quanto ai Parchi, il periodo del loro maggiore sviluppo è stato il decennio scorso (anche se il primo Parco è nato nel 1971). Oggi se ne contano 42. Da anni non si stanno realizzando nuovi Parchi, anche se vari progetti sono allo studio. Va notato, però, che è cresciuta la dimensione di quelli esistenti e che è aumentata la loro offerta di occupazione e il coinvolgimento delle imprese esistenti.
In Francia, dagli anni ’70 ad oggi, sono sorti 35 Parchi. L’esigenza di promuovere la crescita su tutto il territorio e non solo nelle aree urbane maggiori, ha portato, dopo un periodo iniziale di sostegno ai Parchi, a sviluppare progetti di tecnopoli che coinvolgessero le strutture universitarie e gli enti di ricerca rendendo disponibile il loro potenziale scientifico agli operatori economici presenti nelle regioni in cui sono situati.
Il Giappone ha maturato un proprio sistema di ricerca, che privilegia la fase di sviluppo sperimentale rispetto a quella della ricerca applicata, come avviene nei più avanzati Paesi europei e negli USA. La creazione di concentrazioni scientifico industriali – aree residenziali vicine a zone industrializzate, in cui si integrano strutture di ricerca – è uno strumento di politica industriale ben collaudato (in Giappone sono nati, sotto gli auspici pubblici, i primi esempi di tecnopoli) . I Science Parks giapponesi, o meglio le «aree tecnologiche», sono fortemente pianificati dall’alto.
Una delle esperienze più riuscite di Parco scientifico e tecnologico è quella australiana di Adelaide. In questo caso, gli scopi della programmazione pubblica (l’incentivo alle imprese a produrre innovazione per modernizzare il tessuto produttivo e l’emancipazione tecnologico scientifica dall’Inghilterra) sono stati raggiunti con molta efficacia: il Parco di Adelaide ha un centro di ricerca avanzatissimo nel settore dell’elettronica e la regione ha assistito ad un imponente rilancio industriale.
I Parchi in Italia
L’Italia presenta varie realtà di ricerca e diffusione tecnologica assimilabili ai Parchi scientifici e tecnologici propriamente detti, ed altre strutture che più genericamente possono essere definite concentrazioni territoriali di attività innovative[10].
Ve ne sono alcune di origine pubblica, come le aree di ricerca del CNR, i centri di ricerca ENEA ed i laboratori dell’INFN. Altri esempi sono le città-ricerche promosse dall’IRI e dal CNR, che prevedono la partecipazione di più operatori.
Un’altra categoria è quella delle cosiddette aree sistema e dei distretti industriali, zone in cui si concentrano attività produttive ad alto contenuto tecnologico, che richiedono adeguati supporti di ReS, e quindi la disponibilità di aree appositamente attrezzate. La loro origine è solitamente spontanea: si è tentato di farne uno strumento di intervento per superare squilibri regionali di sviluppo, ma senza successo. Esito positivo hanno avuto invece le iniziative di razionalizzazione delle infrastrutture e dei servizi offerti alle imprese dei distretti (pur con il permanere, spesso, di sprechi e sovrapposizioni).
Vi sono infine i Parchi tecnologici tradizionalmente intesi, esperienze che in Italia si riconducono essenzialmente a due modelli, il primo volto alla razionalizzazione pianificata e progettuale ed allo sviluppo di iniziative ad alto contenuto tecnologico e scientifico già esistenti (e che perciò si differenzia dalle aree sistema di origine spontanea, dalle aree attrezzate e dai distretti industriali), mentre il secondo prevede un progetto ab imis cui si dà identità con la creazione di strutture nuove.
Un esempio della prima specie può essere considerato quello dell’Area di ricerca di Trieste; quanto alla seconda tipologia, ci sono diverse esperienze, come la creazione di parchi che prevedono la messa in comune di servizi qualificati in un’area ad alta concentrazione innovativa (es. Tecnocity a Torino), i progetti di servizi a rete in alcuni distretti industriali, la realizzazione di centri indirizzati alla fornitura di servizi ed alla formazione di personale, come nel caso del Tecnopolis, presso Bari, oppure il recupero di aree dismesse, parzialmente attrezzate dal punto di vista tecnologico, come la Bicocca a Milano.
La mappa dei Parchi in Italia è cambiata con l’intervento governativo per la creazione di una rete di PST nel Mezzogiorno, in base all’intesa interministeriale del 3-2-1992, che ha stabilito i criteri per la presentazione delle proposte riguardanti i Parchi[11]. L’attuazione dell’intesa, con il decreto legislativo n.96 del 1993, è stata delegata al MURST, che ha approvato e finanziato progetti riguardanti 13 Parchi (l’obiettivo sarebbe quello di attivarne 20) situati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 e nei territori ex-lege 64: si tratta di TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS, a Valenzano, presso Bari; PASTIS-CNRSM, (PST ionico-salentino) a Mesagne (Brindisi); PST di ELBA, a Marciana (Livorno); PST della SARDEGNA, a Cagliari; PST di SALERNO e delle AREE INTERNE della CAMPANIA; l’AREA METROPOLITANA di NAPOLI (TECHNAPOLI); TECNOMARCHE ad Ascoli Piceno; PA.LMER a Latina (PST del Lazio meridionale); CALPARK a Rende (Cosenza); PST dell’ABRUZZO a l’Aquila; BASENTECH e PST del MOLISE, a Campobasso (v. allegato).
I 13 Parchi sono impegnati in vari settori: nei progetti presentati ed approvati dal Ministero si può notare una generale attitudine alle tematiche ambientali, agroalimentari (Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia, Salerno, Marche, Sardegna), l’attenzione ai rapporti di collaborazione con le pmi (Abruzzo, Salento, Napoli) alla protezione del patrimonio culturale ed archeologico (Salento, Marche, Salerno); la gamma dei progetti spazia dalla riattivazione di settori tradizionali (Sardegna) a punte di avanguardia tecnologica come i dispositivi per il riconoscimento della voce e le teleoperazioni (Elba), le biotecnologie (Napoli, Salento).
Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle risorse umane: ciascun proponente ha dovuto presentare progetti di formazione per operatori di parco ed operatori di progetto: nel primo caso si tratta di corsi destinati a senior managers (87 in tutto, con uno stanziamento di oltre due miliardi) ed a giovani laureati (83 destinatari, per una spesa individuale di circa 160 milioni). Nel secondo caso l’obiettivo è rifocalizzare le competenze e la professionalità del personale che opera nei progetti di innovazione, e soprattutto sviluppare, in giovani laureati, le competenze idonee ad accompagnare la diffusione dell’innovazione nelle strutture produttive, creando la figura del tutor d’impresa, per un costo complessivo di circa 38 miliardi. L’impatto occupazionale previsto riguardo a questi interventi non è tanto quantitativo (in tutto, nel programma ministeriale[12]si è parlato di 273 nuovi occupati) quanto qualitativo, sia per la riqualificazione del personale esistente che per la formazione di nuovi operatori. Ad oggi queste strutture occupano circa 500 addetti.
Attualmente i progetti avviati in queste strutture attraversano una fase di start-up. È significativo considerare quale sia stata l’evoluzione del progetto complessivo dal punto di vista delle risorse finanziarie. Nell’intesa di programma del 1991 si prevedeva di stanziare 1100 miliardi ( 400 a carico del Ministero del Mezzogiorno, 100 a carico del Mimistero del bilancio e 600 a carico del MURST). Dopo due anni venivano meno i 100 miliardi del Bilancio e solo parte dei 400 del Mezzogiorno derano resi disponibili (restando intatti i 600 della Ricerca). La selezione dei programmi presentati entro il 1994 (114) ne ha promossi 45. A quel punto la spesa prevista nel programma approvato dal Comitato tecnico scientifico del MURST era scesa a 359 miliardi per progetti di innovazione e 35 miliardi per progetti di formazione. Ne sono stati impegnati 184 (il 51,2%) e l’importo effettivamente erogato è, ad oggi, di 33 miliardi (il 9,4% circa).
Altre iniziative stanno prendendo piede in altre aree, specialmente del Nord Italia, senza finanziamento né riconoscimento pubblico, il che evidenzia da una parte la vivacità dell’attitudine innovativa del sistema economico, ma dall’altra la mancanza di indirizzi strategici dall’alto e la possibile vulnerabilità a medio-lungo termine di queste strutture.
Strumenti normativi per i Parchi
La legislazione italiana non prevede strumenti finanziari appositi per i PST, ma rende disponibili quelli offerti da misure più a vasto raggio come la legge 46/82, la legge per lo sviluppo delle pmi (317/91), quella per le immobilizzazioni tecniche nelle imprese (1329/65, legge Sabbatini), la legge 181/89 per il potenziamento delle pmi localizzate in zone di crisi siderurgica la legge 44/86 per l’imprenditoria giovanile nel Sud e la legge 488 del 1992 per le imprese di zone depresse del Meridione e del Centro-Nord.
La legge 46/82, che è lo strumento principale e più a vasto raggio della nostra legislazione nel campo della ricerca e sviluppo, prevede il finanziamento attraverso lo strumento del contratto, di progetti proposti da imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici ed amministrazioni pubbliche. Esso configura una commessa pubblica di cui il proponente è uno dei soggetti summenzionati, e la cui esecuzione è affidata ad organismi che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 2 della legge in questione (imprese industriali, consorzi tra imprese industriali, enti pubblici economici, società di ricerca costituite con il FRA, centri di ricerca industriale); l’utilizzo di tale strumento comporta: il finanziamento del progetto a totale carico dello Stato, l’acquisizione alla proprietà dello Stato committente di tutti i risultati contrattuali, con il diritto di utilizzazione esclusiva da parte del contraente a titolo oneroso.
Il ricorso a questa possibilità offerta dalla legge 46 non esclude altre opportunità esistenti, che richiedono azioni di coordinamento, concertazione e complementarietà. In particolare ci si riferisce:
alle leggi regionali finalizzate al sostegno dell’innovazione tecnologica e alla promozione dei servizi innovativi per le piccole e medie imprese;
alla legge 317/91, che da una parte privilegia, come strumento principale di intervento, il credito di imposta, ma dall’altra società consortili miste a capitale pubblico e privato aventi come scopo la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, una configurazione che ben si attaglia alle società, spesso consortili, che gestiscono i Parchi;
ai quadri comunitari di sostegno dei Fondi Strutturali, riferibili alle regioni dell’Obiettivo 1 e dell’Obiettivo 2, nei quali ricerca e innovazione rientrano negli assi prioritari di intervento a livello regionale e multiregionale (periodo 1994-96); la terza e quarta azione del Quarto Programma Quadro Comunitario di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (periodo 1994-98), finalizzate rispettivamente alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, ed alla stimolazione della formazione e della mobilità dei giovani ricercatori nel contesto comunitario.
Profili
Tra le diverse realtà operanti nel Paese, si possono tracciare alcuni profili che evidenziano la varietà di origini, condizioni ed evoluzioni dei Parchi, permettendo un confronto ed una classificazione delle varie esperienze. Ci sono le strutture formatesi attorno a centri di ricerca ed università (Area a Trieste, Tecnopolis a Bari), nelle quali, almeno agli inizi, il perseguimento dell’eccellenza scientifica è stato privilegiato sulla creazione di legami con il mondo produttivo; i complessi influenzati da grandi operatori privati che, riorganizzando le proprie attività produttive, progettano la trasformazione di zone industriali dismesse in aree ad alta intensità tecnologica e di ricerca (come nel caso di Pirelli-Bicocca a Milano e di Tecnocity a Torino); i casi di stretta connessione tra strutture innovative e produttori, nei quali l’accento è posto più sull’attività di diffusione tecnologica ed assistenza che sulla ricerca vera e propria (Consorzi Città Ricerche). Infine mi è sembrato interessante descrivere l’evoluzione dei rapporti tra strutture di ricerca e imprese in un’area particolare come l’Emilia Romagna, il tentativo, compiuto in passato, di impiantare un Polo tecnologico non ha coinvolto il vivace tessuto locale di pmi, e si sono cercate strade alternative.
Area Science Park, Trieste
Contesto. La scelta geografica è stata felice, perché pur non trovando nella regione un contesto economico particolarmente avanzato, l’Area ha beneficiato di altri fattori positivi: l’innata vocazione agli scambi commerciali della zona, e, conseguentemente, la solida rete di attività finanziarie ed assicurative; la presenza di istituzioni scientifiche di prestigio nazionale ed internazionale; l’elevata scolarità e la presenza attiva di personale qualificato (il 2% degli addetti alla ricerca e sviluppo su base nazionale opera nella Provincia di Trieste, che conta solo lo 0,4% della popolazione italiana [13]).
Origini. L’idea all’origine di Area risale agli anni ’70,quando il Parlamento espresse la precisa volontà di creare un punto di riferimento a livello nazionale per i settori dell’alta tecnologia: il Parco è sorto quindici anni fa ed è effettivamente una delle esperienze più riuscite nel suo genere.
La «massa critica» del Parco si è costituita intorno ai centri di ricerca e formazione, che oggi ospitano circa 800 ricercatori. Alcune tra queste istituzioni hanno raggiunto livelli di eccellenza. Fra questi il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB), i laboratori dell’INFN (particelle elementari) e dell’INFM (tecnologie avanzate superfici e catalisi: TASC), il Consorzio interuniversitario per le biotecnologie (CIB), il Centro ricerche e studi per le tecnologie biomediche e sanitarie (CRSTBS), il centro ecologia teorica ed applicata (CETA).
L’Area è gestita da un Consorzio che dipende dal MURST: il suo compito è stato inizialmente quello di fornire una serie di servizi (tecnici, logistici e tecnologici) indispensabili al funzionamento del Parco. In seguito ne ha forniti altri, di più specifici: gestione di finanziamenti alla ricerca per piccole utenze non attrezzate a farlo in proprio, promozione del Parco e delle sue componenti, disponibilità di reti informatiche per collegare i laboratori tra loro ad alta velocità, ecc.
Situazione attuale. La disponibilità di servizi qualificati, know-how ha originato attività imprenditoriali in settori avanzati (nuovi materiali, biotecnologie): in alcuni casi si tratta dello spin-off dei Centri di ricerca e formazione. Tra queste nuove imprese legate al parco si possono citare: Polytech (laboratorio per i biopolimeri tecnologici), il Center for advanced research in space optics (Consorzio Università di Trieste / Officine Galileo), la TECNA (dispositivi diagnostici).
Imprese esterne, inoltre, hanno insediato in Area laboratori ed uffici per reperire know-how, strumentazione avanzata e collegarsi con istituzioni, centri di ricerca ed imprese presenti nel Parco. Fra questi INSIEL (software), ITALTABS (tecnologie sanitarie), EIDON (telecomunicazioni avanzate).
Il Parco, infine, ospita un progetto di ricerca internazionale, il laboratorio di luce di sincrotrone ELETTRA, per lo studio della struttura della materia.
Uno dei punti di forza dell’Area è la multidisciplinarietà delle ricerche condotte al suo interno, che favorisce lo scambio di esperienze di scienziati e ricercatori in un ambiente informale, cosa che consente di attuare una «fertilizzazione incrociata» tra i vari settori.
Milano-Bicocca
Contesto. La struttura sorge in una delle aree storicamente più avanzate dell’economia italiana, per iniziativa di uno dei grandi gruppi industriali, la Pirelli, che, con pochi altri, in passato, è stato tra i maggiori protagonisti dell’avanzamento tecnologico del Paese.
Origini. Negli anni ’60 nasceva a Milano l’idea di costruire una «cittadella della scienza» attorno alla quale si potessero insediare imprese innovative. Iniziativa poi ripresa dalla Pirelli negli anni ’80, con un piano di attività mirato a realizzare benefici tecnologici per il tessuto economico e nel contempo a recuperare un’area industriale dismessa, che fino a metà degli anni ’70 era stata sede di attività produttive, poi dislocate altrove in seguito alla razionalizzazione degli impianti (la Pirelli vi ha mantenuto solo i laboratori di ricerca ed alcuni reparti di produzione). È quindi un privato a dare il via al progetto, in un primo momento: naturalmente per la realizzazione era indispensabile il coinvolgimento delle autorità. Il Polo tecnologico è nato con un protocollo d’intesa tra Comune di Milano, Provincia di Milano e Regione Lombardia, oltre che, naturalmente, la Pirelli, nel 1985. È iniziata così una proficua collaborazione tra pubblico e privato per creare, all’interno di una zona ormai urbana, un’area dedicata alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologie.
È stata costituita un Società Progetto Bicocca, che ha proceduto alla progettazione urbanistica e scientifica del complesso. Sono stati presentati vari progetti, in accordo ai quali il Comune di Milano ha predisposto una variante del Piano Regolatore che definisce la Pirelli Bicocca come un’area di recupero urbanistico. Quanto alla progettazione scientifica, è stata condotta da un apposito Comitato coordinato da Umberto Colombo e ha visto fra gli altri contributi quello di Carlo Rubbia.
Situazione attuale. Gli obiettivi del Parco sono la creazione e la gestione di sinergie tra ricerca e sviluppo, produzioni di alto profilo tecnologico e formazione professionale; la promozione di meccanismi di trasferimento tecnologico tra comparti produttivi (orizzontale) e tra ricerca pubblica e imprese innovative (verticale); l’instaurazione di collaborazioni tra Università, centri di ricerca e imprese; la creazione di un incubator per la promozione di imprese hi-tech; la promozione di corsi post lauream e di iniziative di formazione permanente. I settori nei quali le attività del Parco si versano maggiormente sono l’edilizia, l’ambiente, l’energia, la robotica, le biotecnologie e l’areospazio.
Tra i risultati più rilevanti la nascita di una centrale sperimentale a celle a combustibile dell’AEM, il trasferimento di alcuni istituti del CNR precedentemente dispersi in varie parti della città, la formazione di personale qualificato. Già avviata la collaborazione con l’Università: la Bicocca è sede provvisoria dal 1991 del corso di laurea in scienze ambientali, e dal ’97 di quello in scienze statistiche (che comprende stages in aziende di settore e favorisce in questo modo l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro[14]).
Oltre al centro direttivo Pirelli, presente dalla fondazione, la struttura ne ospita altri (fra cui quello della Siemens) in un contesto che si avvia a diventare polo direzionale ed universitario.
Tecnocity, Torino.
Contesto. Il panorama produttivo piemontese ha la sua punta tecnologicamente più avanzata nel triangolo Torino-Ivrea-Novara. In questa zona le attività economiche gravitano attorno a due grandi gruppi industriali: Fiat e Olivetti. Nei confronti di questi due agenti, la pluralità delle altre imprese minori si pone in una sorta di rapporto gerarchico leader-subcontraente[15]; i loro rapporti reciproci, invece, sono impostati a scarsa cooperazione e forte concorrenza sui prezzi. La presenza di due grandi poli industriali nell’area non permette l’instaurarsi di quelle condizioni che altrove gettano le basi dei distretti tecnologici.
L’Università ed i centri di ricerca non hanno qui solidi legami con le imprese e rivestono un ruolo marginale nella produzione (nonostante alcune consolidate eccezioni, come la collaborazione tra Fiat e Politecnico di Torino).
Origini. Il Parco fu concepito come il core innovativo per l’area torinese nei primi anni ’80 dalla Fondazione Agnelli. Il modello ispiratore era la Route 128 di Boston. Da sottolineare, però, che il concetto di prossimità fisica tra operatori di ricerca ed economici, intrinseco all’idea stessa di parco scientifico, è stata qui sostituita dall’enfasi posta sul ruolo che avrebbero svolto le telecomunicazioni: Tecnocity era inteso come «Telescience Park». Nel 1985 fu istituita l’Associazione Tecnocity, che comprendeva le principali aziende, banche ed associazioni di categoria del Piemonte.
Hanno contribuito al successo dell’esperienza la larga disponibilità di infrastrutture moderne, lavoratori specializzati, risorse finanziarie e la lunga tradizione imprenditoriale dell’area. In questo senso, il profondo coinvolgimento della Fiat nel progetto potrebbe provocare comportamenti imitativi di altre imprese ed attrarre operatori esterni. D’altra parte, proprio questo fattore può frenare l’entrata nel Parco di altre aziende, per il timore che il gruppo torinese possa sfruttare la situazione per proprie strategie interne[16]. Altri punti di debolezza del Parco sono la struttura oligopolistica che inibisce la cooperazione tra pmi, e di conseguenza la velocità di circolazione di informazioni ed innovazioni, e l’assenza della caratteristica comunicazione informale che si instaura tra ricercatori che operano nello stesso ambiente («cafeteria effect») dovuta alla mancanza di prossimità fisica cui sopra si accennava.
I Consorzi Città Ricerche. Si tratta di una rete di consorzi operanti a stretto contatto con le imprese locali, impegnati nella diffusione più che nella produzione di innovazioni tecnologiche, nella valorizzazione di risorse esistenti e nella modernizzazione di settori tradizionali piuttosto che nella creazione ex novo di centri scientifici e tecnologici. Una formula concepita negli anni ’80 da IRI e CNR, che partecipano come membri fondatori alle varie strutture di questo genere presenti nel Paese, assieme alle Camere di commercio, alle Finanziarie regionali e alle imprese più importanti ed innovative dell’area.
È difficile tracciare un bilancio preciso di questo tipo di esperienza, data la sua storia relativamente recente. Tuttavia alcune osservazioni possono essere fatte riguardo ai potenziali fattori di successo e ai punti deboli che queste strutture possono presentare. Per i primi, va sottolineata positivamente l’importanza dell’impostazione a rete che può evitare duplicazioni negli sforzi di ricerca e favorire l’allocazione razionale dei fondi di ricerca pubblici; valida anche l’ attitudine «realistica» volta a favorire ed a coordinare lo sviluppo di centri di eccellenza eventualmente già presenti, ad andare incontro ad esigenze tecnologiche già chiaramente espresse dagli operatori economici presenti. Inoltre i vari Consorzi sono coinvolti, come coordinatori o come semplici associati, nei sette Innovation Relay centers operanti nella penisola. Ma se il progetto ha nell’impostazione i suoi punti di forza, potrebbe avere nella natura dei suoi promotori dei lati deboli: i principali agenti (CNR, IRI, Università, autorità regionali) sono pubblici e, di conseguenza, i Consorzi potrebbero risentire dell’andamento generale della spesa pubblica per ReS, che almeno fino alla prima metà degli anni ’90 si è rivelato restrittivo. La rilevanza dei partners (sia pubblici che privati) associati nei Consorzi potrebbe ostacolare il coinvolgimento di altri attori nel Parco e farne un club esclusivo[17],[18].
Emilia Romagna. Dal punto di vista produttivo è un’area con caratteristiche spiccate: storicamente è una delle regioni in cui il potenziale economico delle pmi si è espresso con maggiore evidenza e le relazioni tra imprese sono state favorite dallo svilupparsi di appositi servizi reali a carattere settoriale (v. sopra, in «Strutture di servizio reale»). Trattandosi di piccole e medie imprese, operanti generalmente in settori tradizionali, la loro propensione alla ricerca è piuttosto bassa. Questo contesto produttivo non è stato, in passato, terreno fertile per la collaborazione tra aziende, centri di ricerca e Università: tre anni fa il tentativo di avviare un polo tecnologico gravitante intorno all’Università bolognese è fallito proprio perché le pmi si sono rivelate ricettive a questo tipo di politica.
In Emilia Romagna gli operatori scientifici più importanti sono:
l’Università di Bologna, i cui dipartimenti più attivi nella ricerca applicata sono quello di Elettronica, Informatica e Sistemistica, quelli di Fisica, Medicina, Energia, Farmacia, Chimica industriale;
l’ENEA, che, presente nella regione dal 1960, impiega 450 addetti, ha avviato più di 100 programmi di ricerca, di cui circa 90 prevedono collaborazioni industriali (che coinvolgono 300 imprese); il Dipartimento per l’innovazione coordina il Relay Center IRENE per l’Emilia Romagna;
il CNR, che conta 15 Istituti nell’area bolognese ed altri a Ferrara, Parma, Reggio.
La necessità di venire incontro alle specifiche esigenze del tessuto produttivo locale ha fatto maturare alcuni progetti, alternativi ai modelli di polo o parco tecnologico, standard non sempre adatti alle pmi. Fra questi:
la creazione di una Agenzia regionale per la promozione tecnologica (per ora alla fase di studio di fattibilità) promossa dal CNR, dalla Regione, dall’Ente Valorizzazione Economica del Territorio (ERVET) e dall’Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico (ASTER);
il TIM (Training Innovative Technology) per il trasferimento di tecnologia alle pmi; il Progetto VERNE e l’Osservatorio della Ricerca per favorire la diffusione di informazioni sulle ricerche svolte in ambito accademico, tramite workshop e banche dati[19]
I Business Innovation Centers (BIC)
Si tratta di strutture che allevano piccole e medie imprese fornendo servizi comuni che ne favoriscano lo sviluppo, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività. In Italia operano 22 centri di questo genere: ne esiste uno in quasi ogni regione, ed in alcuni casi ne operano anche due. A gestire questa realtà è la Spi, società dell’IRI, nata per gestire la reindustrializzazione delle aree siderurgiche in crisi (leggi 181/89 e 513/93) ed investita nel 1990 del nuovo compito di creare una rete di incubatori d’impresa, avvalendosi anche di finanziamenti comunitari.
Il primo dei BIC è sorto a Trieste nel 1989. In seguito altre strutture simili sono state impiantate a Genova (a Campi di Genova, in una zona sulla quale operava l’industria delle armi, acquisita dalla Spi: nei primi due anni sono state attratte nell’area solo 25 imprese, poi il processo si è accelerato ed oggi l’incubatore lavora a pieno carico), in Veneto (dove il BIC è sprovvisto di un incubatore, anche se fornisce servizi e sostegno alle pmi del padovano), e nel Meridione, dove è stata creata una rete BIC/CISI (che è la denominazione delle iniziative Spi nel Sud Italia) che ha come nodi Taranto (operativo dal 1992), Pozzuoli (dal 1994, con 262 posti di lavoro), Marcianise (dal 1995, con 223 addetti).
Tra il ’95 ed il ’96 è stata avviata la seconda generazione di BIC, progettati quasi del tutto ex-novo, a Massa in Toscana, a Teramo in Abruzzo, a Gorizia (il che ha portato a due il numero dei BIC in Friuli Venezia Giulia, a Campobasso, a Catania, ed a Casarano, in Provincia di Lecce[20].
La Spi ha esaminato oltre 1300 progetti, ha investito per 1700 miliardi nella creazione di 388 nuove imprese. Quelle uscite dall’assistenza della società per ora sono solo 101, anche se vantano un tasso di successo del 95%. I posti di lavoro generati finora sono 8700.
Nel complesso il giudizio sull’esperienza dei Business Innovation Centers in Italia può dirsi positiva, e lo stesso per l’operato della Spi, anche se vengono mossi rilievi alla gestione del personale (80 dipendenti) che, secondo studiosi e sindacalisti, potrebbe essere più produttiva, ed allo scarso coordinamento tra le agenzie di promozione.[21]
Per i prossimi cinque anni la Spi ha presentato un «Programma per il rilancio delle aree in crisi del Paese» il cui obiettivo è creare, con un investimento di 1400 miliardi, 80 nuove imprese e 6200 nuovi posti di lavoro di cui oltre la metà al Sud.
Tabella 1: bilancio dell’attività della Spi dal 1992 al 1996
| Progetti esaminati | 1300 |
| Imprese realizzate dalle SPI | 136 |
| Imprese realizzate dai BIC/CISI | 252 |
| Totale imprese realizzate dal sistema BIC/CISI | 388 |
| Investimenti effettuati | 1700 mld |
| Nuovi posto di lavoro avviati | 8700 |
| Iniziative smobilizzate (comprese aziende già uscite dai BIC) | 101 |
| Tasso di successo | 95% |
| Investimento per addetto | |
| - nelle iniziative promosse direttamente dalla SPI | 250 mil |
| - nelle iniziative insidiate nei BIC/CISI | 60 mil |
| Risorse complessive disponibili* | 1000 mld |
| *leggi 181/1989 e 513/1993; fondi comunitari; fondi regionali. |
Fonte: Sole 24 ore, 12/03/1997 |
Osservazioni
Si pone il problema dell’efficacia di una politica dell’innovazione condotta con lo strumento dei Parchi scientifici e dei Poli tecnologici. L’orientamento dell’Esecutivo è quello di dare ai Parchi un ruolo di motore nello sviluppo economico locale, di farne dei «sistemi innovativi territoriali», in cui le aziende si inseriscano e possano maturare le proprie potenzialità tecnologiche. In questo senso si è sottolineato il bisogno di assimilare il concetto di Parco tecnologico più ad un luogo aperto, in cui tutti gli operatori sono invitati allo scambio ed al confronto, che ad un laboratorio in cui l’attività di ricerca svolta non è immediatamente attingibile.
Con riferimento alle peculiarità del nostro sistema produttivo, lo strumento del Parco è, in potenza, un modo per incidere sulle realtà locali di piccole e medie imprese che non sempre trovano lo slancio per realizzare eventuali attitudini all’alta tecnologia. È anche un’alternativa alle politiche innovative tradizionali, che agiscono attraverso sovvenzioni dirette alle imprese che innovano e svolgono ricerca al loro interno, misure queste più adatte ad aziende di dimensioni medio-grandi, che hanno un rapporto avviato con le istituzioni di ricerca da una parte e con l’operatore pubblico dall’altra.[22]
Una politica pubblica volta a creare esternalità positive per la produzione e la diffusione di innovazioni imita, asseconda, in un certo senso, la propensione del nostro sistema economico a creare spontaneamente, in alcuni casi, network che collegano tra loro aziende operanti nelle stesse filiere (distretti industriali). Sotto questo punto di vista, progettare un Parco, impiantare un incubatore in un’area significa creare una struttura «artificiale» che funge da ambiente intermedio tra le imprese e l’ambiente circostante, convogliando gli stimoli innovativi del secondo verso le prime, e fornendo i servizi tecnologici e le attività di ricerca necessarie al soddisfacimento di esigenze specifiche del tessuto produttivo locale. Parchi, incubatori e simili svolgerebbero, con riguardo in particolare alla ricerca ed all’innovazione, una funzione analoga a quella dell’ «atmosfera industriale» che secondo Marshall si instaurava tra gli operatori del distretto.
La premessa essenziale, resta comunque, la preesistenza di condizioni tecnologiche avanzate e di esigenze di sviluppo chiaramente espresse dagli operatori locali. Lo dimostra il confronto con altri Paesi: una politica innovativa di sostegno a Poli tecnologici e Parchi scientifici è giustificata dove il sistema presenti condizioni particolarmente favorevoli. Dal modello «spontaneo» degli Stati Uniti, a quello diretto dall’alto tipico del Giappone, a quello europeo di concertazione con le autorità locali, tutti i casi in cui esperienze di questo genere hanno avuto successo prevedono la preesistenza di patrimoni scientifici rilevanti, di efficienti istituzioni di ricerca, di eccellenti Università nonché di tradizioni tecnico professionali che forniscono in loco capitale umano specializzato.
In conclusione, se da una parte «sfruttare» le caratteristiche del nostro sistema produttivo introducendo strutture per l’innovazione nei network delle pmi può rivelarsi fattore di successo, dall’altra si rischia di trasformare il Parco da complesso di ricerca avanzata che sollecita il tessuto produttivo locale a sistema di recupero per aree depresse.[23]
Tentare di trapiantare una realtà come il Parco scientifico al di fuori del tipo di contesto che ne favorisce il successo è un’iniziativa che lascia spazio a riserve. In questo casi l’impegno per la realizzazione di strutture di ricerca avanzate potrebbe rivelarsi uno spreco, mentre la semplice razionalizzazione ed il potenziamento di servizi esistenti sarebbe una soluzione migliore.
Allegato al Cap.IV.
Delibera del Comitato tecnico scientifico ex-lege 46 di approvazione del Piano di intervento relativo ai PST nel Mezzogiorno
P.S.T.: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELL'ABRUZZO
|
PROGETTI DI INNOVAZIONE approvati n.2 |
Costi previsti* |
|
1) adeguamento tecnologico e gestionale delle pmi |
8.740 |
|
2) aree protette interne e produzioni agroalimentari di qualità |
9.940 |
|
PROGETTI DI FORMAZIONE |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
450 |
|
|
1.370 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
*N.B.: costi espressi in milioni di lire, IVa inclusa
P.S.T.: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO BASENTECH
|
Progetti di innovazione approvati n.2 |
Costi previsti* |
|
1) realizzazione di un sistema prototipale di sviluppo industriale/sociale legato all’ambiente e al territorio |
17.000 |
|
2) realizzazione di un sistema prototipale di sviluppo industriale connesso con l’indotto SNIA-FIAT |
8.000 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
600 |
|
|
1.826 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico della calabria
|
Progetti di innovazione approvati n.3 |
Costi previsti* |
|
1) cooperazione ricerca – impresa e generazione di nuove imprese innovative |
11.150 |
|
2) sperimentazione di servizi innovativi alle imprese produttrici di software |
5.500 |
|
3) sperimentazione di un sistema innovativo concorrente al miglioramento della capacità competitiva della filiera agroalimentare |
9.640 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
640 |
|
|
1.920 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico del molise
|
Progetti di innovazione approvati n.3 |
Costi previsti* |
|
1) tecnologia della filiera suina per l’allevamento per l’allevamento delle carni |
3.130 |
|
2) valorizzazione del latte e dei prodotti lattiero- caseari tipici molisani |
1.980 |
|
3) sviluppo di tecnologie per la produzione e la difesa da organismi nocivi dei cereali e derivati delle patate |
7.300 |
|
Progetti di formazionE |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
300 |
|
|
914 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
120 |
|
|
800 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico dell’area metropolitana di napoli
|
Progetti di innovazione approvati n.8 |
Costi previsti* |
|
1) sperimentazione del modello di funzionamento e realizzazione delle PST dell’Area Metropolitana di napoli |
10.000 |
|
2) qualità per la pubblica Amministrazione |
4.222 |
|
3) telelavoro |
5.135 |
|
4) promozione, sviluppo, riconversione, qualità di pmi |
12.045 |
|
5) audit e monitoring su aziende ad elevato impatto ambientale |
1.100 |
|
6) divulgazione della cultura scientifica e imprenditoriale città della scienza |
7.590 |
|
7) biotecnologie mediche ed alimentari |
11.900 |
|
8) sistemi tecnologici per la gestione integrata delle modalità viaggiatori, della logistica industriale e dei sistemi di trasporto merci |
2.990 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
1.340 |
|
|
4.021 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
240 |
|
|
1.600 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico ionico salentino
|
Progetti di innovazione approvati n.5 |
Costi previsti* |
|
1) caratterizzazioni e certificazione dei materiali |
9.000 |
|
2) sistema pilota per la diffusione di servizi a cluster di pmi dell’Area Ionico salentina |
17.000 |
|
3)materiali avanzati per il settore agroalimentare : membrane organiche |
6.000 |
|
4) sviluppo di un servizio pilota finalizzato a qualificare, espandere e potenziare le nicchie di mercato biomedicale dell’implanto protesi e di biomateriali per la rigenerazione i tessuti duri e molli |
8.000 |
|
5) progetto di ricerca archeologica e archeometrica per valorizzazione e recupero del patrimonio archeologico ionico-salentino |
7.000 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
1.200 |
|
|
3.425 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
1.280 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico di salerno e delle aree interne della campania
|
Progetti di innovazione approvati n.4 |
Costi previsti* |
|
1) valorizzazione della qualità delle risorse ambientali e produttive del sistema economica locale e riqualificazione delle peculiari interazioni |
6.940 |
|
2) metodi e strumenti per la produzione del software, la formazione e le applicazioni |
8.000 |
|
3) metodologie e tecnologie per la gestione e l’attuazione di interventi di recupero e consolidamento nel centro storico di salerno |
3.500 |
|
4) diffusione e divulgazione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’area beneventina |
4.500 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
550 |
|
|
1.690 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico della sardegna
|
Progetti di innovazione approvati n.3 |
Costi previsti* |
|
1) ambiente e territorio |
12.800 |
|
2) rivitalizzazione dei settori produttivi tradizionali |
2.950 |
|
3) sistema integrato di sevizi per l’innovazione e l’incubazione di imprese |
4.900 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
500 |
|
|
1.500 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
192 |
|
|
1.280 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico della sicilia
|
Progetti di innovazione approvati n.6 |
Costi previsti* |
|
1) meccanizzazione e tipizzazione di produzioni zootecniche |
7.000 |
|
2) sviluppo e sperimentazione di tecniche e tecnologie di maricoltura off-shore |
9.000 |
|
3) sviluppo tecnologico settore delle terrecotte e del restauro |
7.000 |
|
4) nuovi modelli e soluzioni per le applicazioni di tecnologie informatiche |
7.000 |
|
5) conservazione biologica e preparazione di segmenti e frutti interi di agrumi per il consumo fresco |
3.500 |
|
6) progetto qualità |
21.500 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
1.350 |
|
|
4.020 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
192 |
|
|
1.600 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico tecnopolis csata novus ortus
|
Progetti di innovazione approvati n.3 |
Costi previsti* |
|
1)cluster |
38.000 |
|
2) pregrifos |
2.500 |
|
2) trials |
3.900 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
1.090 |
|
|
3.250 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
192 |
|
|
_ |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico dell’elba
|
Progetti di innovazione approvati n.2 |
Costi previsti* |
|
1) sviluppo di sistemi di biosensori per l’ambiente e la salute |
2.000 |
|
2) dispositivi, con reti neurali e sensori, per riconoscimento voce e teleoperazioni varie |
20.300 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
570 |
|
|
1.630 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico del lazio meridionale
|
Progetti di innovazione approvati n.3 |
Costi previsti* |
|
1) sviluppo e creazione d’impresa |
8.000 |
|
2) progetto qualità |
7.000 |
|
3) progetto ambiente |
2.684 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
430 |
|
|
1.290 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
p.s.t.: parco scientifico e tecnologico teknomarche
|
Progetti di innovazione approvati n.5 |
Costi previsti* |
|
1) applicazioni tecnologiche flessibili |
9.200 |
|
2) prototipazione integrata |
2.200 |
|
3) meccanizzazione agricola |
2.450 |
|
4) valorizzazione delle tecnologie del freddo |
5.500 |
|
5) materiali patrimonio culturale |
3.000 |
|
Progetti di formazione |
Costi previsti * |
|
A) Per operatori di progetto A1- rifocalizzazione professionale personale esistente A2- nuovi occupati tutor d’impresa |
|
|
550 |
|
|
1.640 |
|
|
B) Per operatori di parco B1- aggiornamento senior B2 – formazione neo-laureati |
|
|
144 |
|
|
960 |
STANZIAMENTI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE
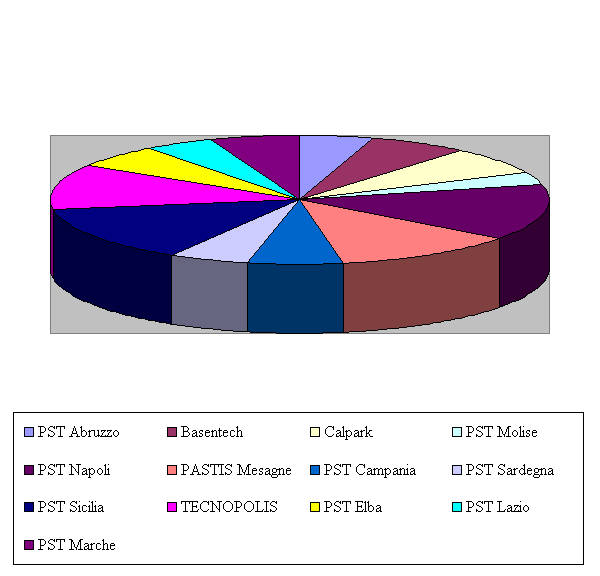
STANZIAMENTI PER PROGETTI DI FORMAZIONE