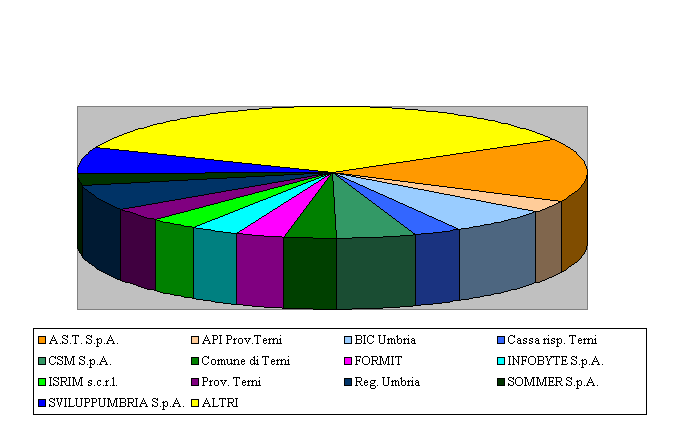Case study
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI TERNI
Contesto industriale
Il PST di Terni nasce nel
1994 con una struttura diversa da quella della maggior parte dei Parchi
italiani, prototipo di Parco virtuale.
Il contesto in cui agisce è
quello di una zona a declino industriale. Infatti è compresa nelle aree
dell’Obiettivo 2.
Una tradizione industriale
relativamente recente ha portato l’area di Terni a specializzarsi nel settore
siderurgico e chimico.
Alla fine del secolo scorso
Terni diventa sede della omonima società siderurgica[1].
Nel 1934 questa passa allo Stato e viene inquadrata nella Finsider, a cui fanno
capo anche gli altri gruppi siderurgici italiani: ILVA, Dalmine, SIAC.
L’industria siderurgica in Italia presenta per molti decenni una rilevante
presenza pubblica. Fuori dalla gestione Finsider, infatti, gruppi produttori di
acciaio di portata analoga sono solo Fiat, Falck, Cogne, Breda, Radaelli.[2]
I principali stabilimenti
Finsider sono stati incorporati, sul finire degli anni ’80, dall’ILVA: fra
questi anche la Terni Acciai Speciali. La privatizzazione dell’ILVA ha portato
nel ternese il colosso tedesco Krupp, che in cordata con la Agarini ha
acquistato la AST (Acciai Speciali Terni) SpA, uno dei due blocchi risultanti
dalla messa in liquidazione dell’ILVA.[3]
Cultura
imprenditoriale e cultura industriale.
Nell’area di Terni non si è
radicata particolarmente una cultura imprenditoriale e una propensione al
rischio. La presenza di una grande industria che per decenni ha dato lavoro
alle famiglie non ha favorito lo sviluppo di una leva imprenditoriale, sicché
al sopravvenire del declino industriale l’area non presentava risorse umane
proprie che la risollevassero, soprattutto per quel che riguarda il management,
che per molto tempo era stato “importato” da fuori.
La zona ha sofferto di
fattori limitativi anche se non “sostanziali”: lontananza dai mercati, carenza
di infrastrutture, trasporti, servizi ed incentivi finanziari. Altri fattori
hanno influenzato negativamente lo sviluppo economico dal punto di vista
sostanziale, con riferimento alle pmi, alla grande impresa, e al sistema
complessivo locale.
Le imprese con meno di 50
addetti costituiscono il 99,6% del totale delle unità presenti nella zona (si
veda la tabella 1). Non hanno sviluppato però l’”atmosfera industriale” che
rende tale il distretto. Questi operatori non hanno sviluppato una vera e
propria cultura imprenditoriale concorrenziale, innovativa e di
prodotto/mercato finale. Hanno risentito di un’eccessiva dipendenza dalla
grande impresa, conservando per sé una visione di corto raggio dell’impatto
tecnologico sulla produzione, limitandosi ad adottare innovazioni che
assicurassero riduzioni di costi e non impegnandosi a conoscere le possibilità
offerte dallo sviluppo tecnologico, né tantomeno a sollecitare con le proprie
esigenze l’attività degli operatori di ricerca.
Quanto alla grande impresa, è stata sempre
impegnata in un solo settore (siderurgico) e non ha sviluppato efficienti
processi di trasferimento esterno delle esperienze condotte nei propri impianti
e delle innovazioni applicate nei propri processi di produzione.
Ne ha risentito il sistema
complessivo locale, dove non sono maturate relazioni e cooperazioni, perché
ostacoli burocratici, isolamento e divergenze degli operatori locali ne
impediscono lo sviluppo.[4]
Quanto alla cultura industriale, questa è
senz’altro presente. Generazioni di operai metallurgici hanno assimilato
capacità tecniche e specializzazione grazie ad una consolidata pratica di learning on job. In seguito la
formazione di capitale umano è stata “istituzionalizzata” in strutture
apposite: c’è a Terni un istituto di formazione tecnica e recentemente è sorta
la facoltà di ingegneria dei materiali. Inserimento recente e necessario per
colmare un vuoto avvertito da tempo.
Quanto alla cultura industriale, questa è
senz’altro presente. Generazioni di operai metallurgici hanno assimilato
capacità tecniche e specializzazione grazie ad una consolidata pratica di learning on job. In seguito la
formazione di capitale umano è stata “istituzionalizzata” in strutture
apposite: c’è a Terni un istituto di formazione tecnica e recentemente è sorta
la facoltà di ingegneria dei materiali. Inserimento recente e necessario per
colmare un vuoto avvertito da tempo.
Unità
locali per classi di addetti: composizione percentuale[5]
|
Classi di addetti |
1971 |
1981 |
1991 |
|
0-1 |
50,6 |
48,5 |
44,4 |
|
2 |
24,6 |
23,3 |
23,9 |
|
3-5 |
15,4 |
17,2 |
20,5 |
|
6-9 |
4,5 |
5,4 |
5,9 |
|
10-19 |
2,6 |
3,4 |
3,1 |
|
20-49 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
|
50-99 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
100-199 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
200-499 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
500-999 |
… |
0,1 |
… |
|
1000 e oltre |
… |
… |
… |
|
totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: ISTAT, 1994.
Esigenze del territorio, “diagnosi” ed
obiettivi del Parco
La mancanza di una cultura imprenditoriale
affermata e di consapevolezza dell’importanza strategica di ricerca e
innovazione sono i problemi principali che il Parco scientifico e Tecnologico
di Terni fronteggia. D’altra parte la zona offre dei punti di forza: la
presenza dell’industria siderurgica ha permesso di avere sul territorio validi
operatori di ricerca che si cerca ora di “proiettare” verso il mercato con
un’offerta diversificata rispetto al passato.
Fattori, dunque, che possono
controbilanciarsi. L’obiettivo primario del Parco è stato ed è quello di
elevare il livello
tecnologico
(e, a monte, quello culturale) del tessuto produttivo. Per promuovere e
generare innovazione, il Parco fa leva sugli agenti presenti nel territorio:
imprese, strutture di ricerca, strutture finanziarie. In particolare, si cerca
di saldare e far interagire il settore dell’offerta di innovazione (cioè il
sistema tecnico scientifico costituito da Centri di ricerca, Università e
società di servizi reali) con quello della domanda, vale a dire il mercato
locale delle imprese; sviluppare la collaborazione tra i diversi agenti che
operano sul territorio, sia sul lato della domanda di innovazioni, sia su
quello dell’offerta. Per le prime si cerca di organizzare la cooperazione su
tematiche innovative di interesse comune, mentre per i secondi l’obiettivo specifico
è di aumentarne l’efficacia operativa e la finalizzazione economico
industriale.
Caratteristiche specifiche del settore
siderurgico e aspetti della ricerca dell’acciaio.
Nel decennio scorso il settore siderurgico ha
attraversato un grave periodo di crisi, tanto che lo Stato ha attuato un piano
di risanamento per della siderurgia, con la legge 181/1989, che prevedeva
l’attivazione di un fondo speciale di reindustrializzazione nelle aree di crisi
siderurgica (Genova, Terni, Napoli, Taranto) e l’intervento di promozione
industriale da parte della SPI.
Con gli anni ’90 le prospettive del settore
sono cambiate. Sul piano internazionale, è aumentata e si è diversificata la
domanda di acciaio (soprattutto per uso costruzioni) ed è cresciuta
l’efficienza produttiva e la competizione sui prezzi. Quanto all’Italia, la
siderurgia nazionale (laminati piani e prodotti lunghi) è caratterizzata da una
grande industria privata di laminati piani che per essere competitiva ha
privilegiato l’innovazione finanziaria all’innovazione tecnologica, da
un’elevata frammentazione dell’industria dei prodotti lunghi, con conseguente
estrema diversificazione delle problematiche di produzione non generalizzabili,
e con uno spettro di prodotti molto limitato e a valore aggiunto relativamente
basso, da siderurgie senza centri di ricerca corporate.
La partecipazione di capitali esteri nella
privatizzazione delle siderurgie degli acciai speciali piani e lunghi, ha
assegnato alla ricerca ruoli e responsabilità che la siderurgia nazionale non
aveva ancora colto appieno. Ne è conseguita una stabilizzazione delle strutture
di ricerca esistenti (in questo caso, il CSM) e la loro proiezione in ambito
sovranazionale.[6]
Il Parco: Forma societaria e associati
Il PST di Terni, costituito come società
consortile a responsabilità limitata, ha attualmente 60 associati,
riconducibili a cinque categorie fondamentali di soggetti:
Enti pubblici (Regione
Umbria, Provincia e Comune di Terni, Comune di Narni);
Associazioni di categoria;
Centri di ricerca e
formazione.
Imprese (oltre 40 in
rappresentanza sia della grande impresa che delle pmi)
Banche locali.[7]
Il capitale sociale iniziale
ammonta a 243 milioni, ma l’Assemblea ha deliberato un aumento fino a 500
milioni.
Il PST intende operare, con
meccanismi anche complessi, in vari campi di attività, puntando al possibile,
con senso di realismo, a sviluppare, tra i differenti attori, collaborazioni,
aggregazioni e sinergie su determinate filiere tecnologico-produttive correnti
sia con le realtà e con le specializzazioni esistenti sia con le potenzialità
di diversificazione e di sviluppo economico del territorio. A livello di azioni
specifiche la missione del Parco prevede le seguenti fondamentali aree di
intervento:
·
diffusione dell’innovazione e trasferimento tecnologico
verso le pmi;
·
progetti di ricerca per singole pmi di portata economica di
norma contenuta;
·
progetti integrati di Ricerca/Innovazione di forte impegno e
valenza strategica, implicanti diffuse collaborazioni e connessioni in rete a
livello locale, nazionale ed internazionale;
·
creazione e attrazione di nuove iniziative imprenditoriali
ad alta tecnologia;
·
formazione specialistica e mobilità delle risorse umane;
·
servizi ausiliari all’impresa (financing per ricerca e
innovazione, proprietà industriale e contrattualistica, marketing e brokeraggio
tecnologico, ecc.)
Le tipologie di intervento del
Parco sono la fornitura di servizi di informazione e di consulenza/assistenza
tecnica (interventi a spot di piccole dimensioni, «problem solving»); la formulazione
di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico (su scala di laboratorio
e/o industriale di impegno limitato).
Il PST svolge essenzialmente un
ruolo di snodo e di interfaccia tra domanda e offerta: interviene direttamente
nelle fasi di promozione e individuazione di idee, progetti e opportunità per
innovazione e sviluppo, di ricerca di partners e contributi
tecnico-specialistici, di canalizzazione dei progetti, nei più opportuni
programmi e strumenti (locali, nazionali, comunitari) di supporto finanziario.
In alcuniu casi il Parco cura il coordinamento ed il project management della
fase attuativa; la realizzazione del progetto è demandata a soggetti associati
e/o a terzi dotati dei necessari specialisti e mezzi operativi.
Gli interventi e i progetti sinora
promossi o avviati riguardano prevalentemente i seguenti settori, che possono
ritenersi prioritari con riferimento
alle realtà e potenzialità del ternese:
·
i materiali speciali, particolarmente quelli metallici e
compositi;
·
la meccanica e l’impiantistica;
·
l’ambiente e l’energia;
·
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con
particolare riguardo alle tecnologie dello Spettacolo e alle tecnologie per
l’automazione e il controllo di processi
·
Progetti approvati e avviati:
·
costo totale: 6,6 mld; contributi: 4,8 mld (0,9 da fonti
esterne, non regionali)
·
diffusione dell’innovazione (progetto RETECH)
·
Innovation Relay Center Toscana/Umbria (RECITAL)
·
Accademia Europea Effetti Speciali diretta da Carlo Rambaldi
·
Progetto ADAPT sulla manutenzione di impianti e di edifici
Progetti approvati da
avviare
·
Costo totale: 34 mld; contributi: 22,5 mld (di cui 17,5 da
fonti esterne)
·
Progetto di Ricerca “Valorizzazione energetica di rifiuti
urbani e industriali e di biomasse”
·
Due programmi per il sostegno finanziario alle pmi umbre per
attività di ricerca /innovazione in collaborazione con Centri di ricerca o
altre imprese (TERRI e PERRI)
·
Due progetti di formazione multiregionali : METALLEADER e
INNOPLUS
·
Progetto per l’innovazione territoriale transregionale
(LINK) proposto e coordinato dalla Scuola S.Anna di Pisa
·
Progetto “Metodi e tecnologie innovative per progettazione
Parchi tematici e realizzazione creazioni animate”
Progetti presentati in
istruttoria
·
Costo totale 54 mld; contributi 37,5 mld, di cui 37 da fonti
esterne;
·
Piani di potenziamento di reti di ricerca in aree
depresse (progetto Tecnopolit LISES)
·
Mostra di creazioni artistico-tecnologiche del settore
effetti speciali
·
Parchi tematici a valenza mista (ludica-culturale,
artistica-scientifica) sul territorio
Iniziative specifiche
TERRI e PERRI
Nell’ambito dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) il PST ha promosso e gestisce misure volte ad incentivare la cooperazione nella ReS delle pmi locali e delle istituzioni qualificate nel settore Ricerca e Tecnologia .
TERRI e PERRI (Terri: PIC ResiderII, Azione C, Misura 7.d.5; Perri: PIC PMI, Azione B, Misura 7.5) sono due programmi in base ai quali la Regione Umbria concede alle pmi contributi a fondo perduto per la copertura di parte dei costi che esse sostengono nella realizzazione di progetti di ricerca finalizzati all’innovazione di prodotto e di processo svolti in collaborazione con altre pmi, con istituzioni e centri di ricerca, Università e centri di trasferimento tecnologico.
La dotazione finanziaria
complessiva per i due progetti supera i 5 miliardi (2 per il progetto Perri, 3
mld e 120 milioni per il Terri).
In questo modo le piccole e
medie imprese, singole o associate, vengono agevolate nell’introduzione di
innovazioni con il cofinanziamento al 50% (fino ad un massimo di 200 milioni)
per progetti da esse presentati in base ai quali stipulano una convenzione con
il Parco per l’attuazione.
RETECH
E’ un progetto avviato nel
1995, cofinanziato all’80% dalla Regione Umbria, nell’ambito del DOCUP –
obiettivo 2, della durata di due anni. Il soggetto attuatore, il PST, ha mirato
a individuare e definire la struttura dell’offerta locale di tecnologia e
ricerca, da una parte e di domanda e opportunità di innovazione nelle pmi
dall’altra, ha elaborato progetti di ricerca e trasferimento tecnologico e
commissionato dimostratori di tecnologie per il territorio all’ISRIM ed al CSM.
Il progetto ha coinvolto risorse per 4 miliardi, e sarà proseguito e sviluppato
nel triennio1997-99.
Innovation Relay Centre Toscana /Umbria (RECITAL)
Questo organismo è
cofinanziato al 55% dall’UE, si inserisce nella rete degli Innovation Relay
Centers nazionali (7) ed europei (50). Questo tipo di struttura (v. Cap. IV)
promuove l’informazione su iniziative comunitarie ed agevola la presentazione
di progetti di ricerca in ambito europeo grazie ai collegamenti con i centri
analoghi in tutta Europa. Per il biennio ‘95-’97 il progetto ha comportato un
costo pari a 220 miliardi.
Progetto LINK
L’iniziativa è proposta e coordinata
dalla Scuola S.Anna di Pisa ed implica azioni specifiche volte a sperimentare
nuove metodologie nei servizi tecnologici e nella formazione. Il progetto ha
respiro nazionale e coinvolge quattro parchi (Pisa/Pontedera, Benevento,
Brindisi ed, appunto, Terni) inseriti in quattro aree geografiche di cui si
cerca di esaltare la specializzazione.
Per Terni, gli interventi
riguardano i settori dei materiali, della computer-grafica-multimadiale-effetti
speciali, finanza speciale d’impresa, tele servizi per le pmi. Il progetto
comporta un costo di 3,5 miliardi.
Accademia Degli Effetti Speciali
L’iniziativa di creare
l’Accademia degli effetti speciali è nata nell’ottica di promuovere la
diversificazione del panorama economico locale, avvalendosi delle esperienze
consolidate nell’area (Centro multimediale di Terni, iniziative per il cinema
del Comune di Narni ed in generale la rilevanza del settore spettacolo in
ambito regionale). L’obiettivo è quello di formare una nuova figura
professionale, quella del “creatore” di effetti speciali, coniugando arte e
creatività con scienza e tecnologia e ponendosi come punto di riferimento del
settore.
La Scuola è la prima del
genere in Italia e in Europa. Diretta dal Maestro Carlo Rambaldi, coinvolge una
ventina di esperti del ramo e attrae nuove specializzazioni e pmi per creazioni
artistiche, micromeccanica, computer-grafica, scenografia.
Oltre alla creazione di
competenze nel campo dello spettacolo, l’Accademia può dar luogo a ricadute
socio-economiche a livello locale e regionale (arte turismo e festivals),
coadiuvate anche dal progetto riguardante i Parchi tematici e le Creazioni
animate, approvat6o ed in via di attuazione.
CSM
Il contesto in cui opera il
Parco è dunque quello di un’area che ha subito un processo di
“deindustrializzazione” che oggi cerca di diversificare e riorientare le
proprie attività. Emblematico di questa realtà mi è sembrato il caso del CSM,il
maggior centro di ricerca applicata operante nella zona e che partecipa alla
Srl con una quota del 5% circa.
Il Centro era legato all’attività
siderurgica dell’ILVA, ma in seguito alla privatizzazione del gruppo
industriale pubblico, ha modificato la sua struttura e le sue funzioni.
Struttura
Fino alla privatizzazione
dell’ILVA, il CSM apparteneva alla SOFIM, società del gruppo IRI, che deteneva
l’87% della proprietà, mentre il restante 13% era diviso tra Fiat e
Finmeccanica. Il Centro operava presso gli stabilimenti siderurgici di Taranto,
Terni, Genova. La sede centrale era a Castel Romano. Dopo la privatizzazione
del gruppo siderurgico, le sorti del Centro sono rimaste legate principalmente
alla AST, che ha continuato, per quel che riguarda la ricerca nei materiali, il
cammino già avviato dall’ILVA e ha mantenuto i rapporti di collaborazione con
il Centro, mentre il Gruppo Riva, che ha acquisito gli impianti di Taranto e
Genova (ILVA Laminati Piani), non ha assunto impegni sistematici nella ricerca.
Dal 1997 il Centro è una società
per azioni, cui partecipano la SOFIM con una quota del 25% circa delle azioni
(parte delle quali sono in vendita); le Acciaierie Speciali Terni SpA (cioè il
gruppo Krupp-Agarini-Tiessen)
con il 15%; la multinazionale argentina Tekint, a nome di Dalmine di Bergamo,
con l’8%; il gruppo americano Vesuvius (ceramici e refrattari) con un altro 8%
e la Fincantieri con il 10%. Il resto appartiene a piccoli azionisti. Resta
quindi sotto il controllo pubblico circa il 45% delle azioni (le quote SOFIM e
Fincantieri), mentre il resto è in mano a privati. È rilevante il fatto che
azionisti, e committenti, di notevole peso siano tre gruppi multinazionali di
grandi dimensioni (Krupp, Tekint e Vesuvius).
Le principali commesse di ricerca
vengono dalla AST, e di conseguenza le attività del Centro si sono concentrate
a Terni, che è diventata la sede più importante fra quelle in cui esso opera,
mentre quelle di Taranto e Genova sono state ridimensionate, essendo venuta
meno la collaborazione stabile con gli impianti siderurgici lì dislocati.
Il mutare della situazione ha
sollecitato anche una maggiore versatilità degli obiettivi di ricerca
perseguiti dal CSM, che dall’iniziale specializzazione siderurgica è passato ad
interessarsi anche allo sviluppo di altri materiali: è particolarmente attivo
nel settore dei ceramici, e ha avviato una nuova sede a Trento impegnata
proprio in questo campo.
Il Centro conta oggi circa 350
addetti. Da due anni non assume nuovo personale, ma si avvale della
collaborazione di neolaureati borsisti presso il CSM o sotto contratto di
ricerca.
Funzioni.
Il CSM produce know-how e brevetti
nel campo della siderurgia e dei ceramici.
È il principale centro di ricerca
operante nel Parco di Terni. Ha avviato rapporti di collaborazione con
l’Università di Perugia e Terni, favorendo la mobilità dei suoi ricercatori,
alcuni dei quali insegnano nell’Ateneo (Facoltà di Ingegneria dei Materiali), e
coopera con l’ISRIM e il MURST su temi di interesse ecologico.
Il Centro ha avviato con il BFI di
Düssendorf un rapporto di partnership in progetti CECA.
Inizialmente il Centro era
impegnato in attività modellate sulle esigenze dell’ILVA: i risultati della
ricerca venivano applicati in impianti siderurgici a ciclo integrale ed
elettrico. Inoltre il CSM assicurava al gruppo siderurgico pubblico servizi di
consulenza ed assistenza tecnica.
Dopo la privatizzazione dell’ILVA e la costituzione in SpA del
Centro, la domanda che quest’ultimo ha dovuto fronteggiare è cambiata: i
committenti sono aziende con una prospettiva d’azione ed una strategia
imprenditoriale diverse da quelle che potevano essere proprie di un’azienda di
Stato. Questo comporta implicazioni favorevoli e possibili ostacoli all’attività di ricerca.
Le implicazioni favorevoli sono
legate al diverso tipo di incentivi che le due diverse situazioni presentano:
un’istituzione che collabora con un ente pubblico o con l’industria di Stato
(come era il CSM fino al 1997) ha minori stimoli alla produttività ed alla
competitività rispetto ad un soggetto che si cala nella logica di mercato
perché interlocutore di imprese private che ne sono allo stesso tempo
proprietari e committenti.
Il CSM, con la sua struttura
societaria di SpA, rappresenta un unicum nel panorama dei centri di ricerca
siderurgica europei: laddove gli altri centri si caratterizzano per essere
centri di costa di imprese siderurgiche o fondazioni supportate da consorzi
siderurgici, il CSM dave svolgere attività di marketing per identificare la
propria committenza su un mercato libero, almeno nei settori tecnolo e
commerciali di interesse non diretto dei propri azionisti.
Il mutare degli incentivi assume
poi un significato particolare in un caso come questo, perché riguarda un
operatore che svolge attività di ricerca: l’interazione con i produttori
industriali ed il mercato può rappresentare un valido metodo per la valutazione
dei risultati della ricerca svolta.
Un altro aspetto favorevole della
mutata struttura del CSM e dell’ambito
in cui esso opera è la logica cooperativa di respiro europeo che esso ha
acquisito e che gli ha consentito di affrontare problematiche di interesse degli
azionisti di alto rischio, richiedenti rilevanti risorse finanziarie, e ha reso
possibile la presenza di esperti del centro in comitati di consultazione e
monitoraggio di organismi comunitari.
La collaborazione ha permesso di
cogliere tempestivamente le tendenze tecnologiche in atto, anticipando esigenze
di mercato o cambiamenti strutturali nei cicli di fabbricazione che altrimenti
in Italia sarebbero venuti a compimento con ritardo. Se da un lato questo ha
permesso agli azionisti di essere presenti sul mercato con prodotti di punta e
tecnologie di frontiera, dall’altro ha reso il CSM un centro di ricerca
anticipatore di innovazioni sostanziali.
Quanto agli ostacoli, essi
riguardano il tipo di ricerca che un Centro di questo tipo può svolgere, o, in
altri termini, il genere di progetti che i committenti sono disposti a
finanziare. Tradizionalmente la ricerca pura, non legata ad applicazioni
produttive ed a ritorni economici immediati, viene compresa tra le funzioni
delle Università e degli enti di ricerca pubblici, mentre l’interesse delle
imprese alla ricerca si limita allo sviluppo sperimentale o al massimo alla
ricerca applicata. In effetti, anche nel caso considerato, i finanziamenti che
il CSM riceve riguardano generalmente progetti di ricerca su scala pilota o su
scala effettiva. Alcuni progetti d’avanguardia (ad esempio lo sviluppo di un
nuovo tipo di colata per nastri in acciaio, attivo da dieci anni) vengono
avviati dal Centro senza la partecipazione di imprese, i cui finanziamenti
sopraggiungono appena si raggiungono i primi risultati passibili di
applicazione operativa. Si tratta di progetti che possono essere definiti di
ricerca base «finalizzata» e che generalmente proseguono come ricerca
applicata. Ora, il problema è se il passaggio dalla collaborazione con un
soggetto pubblico a quella con dei privati possa limitare il raggio d’azione
del centro. Essendo cambiata la sua struttura da poco più di un anno, è ancora
presto per avere delle evidenze.
Un’osservazione
che comunque è possibile fare riguarda la dipendenza del Centro (e degli
istituti di ricerca in generale) dalle strategie seguite dai committenti,
pubblici o privati che siano. Una struttura di ricerca legata principalmente
all’operatore pubblico risentirà dell’andamento degli stanziamenti attuati per
la ricerca a livello nazionale, determinati dalle linee politiche tracciate dai
governi centrali: una politica di bilancio restrittiva taglia i fondi destinati
alla ricerca (specialmente in Italia). Allo stesso modo, un centro studi
finanziato dai privati avrà maggiori o minori risorse a seconda che le imprese
siano o meno favorevoli all’impegno nella ricerca, atteggiamento che in un
privato può subire l’influenza dell’andamento del mercato o di strategie
aziendali adottate dal soggetto. Nel caso del CSM, il “pericolo” è
rappresentato soprattutto dalle più recenti linee di condotta del gruppo Krupp,
che ha chiuso in Germania vari suoi centri di ricerca. D’altra parte la varietà
della composizione degli azionisti può essere per il CSM una salvaguardia da questa ed altre
eventualità negative.
SOCI E QUOTE DEL PARCO
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI TERNI
(quote versate al 07.01.98)