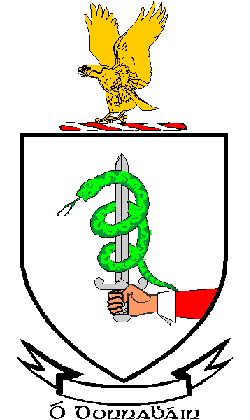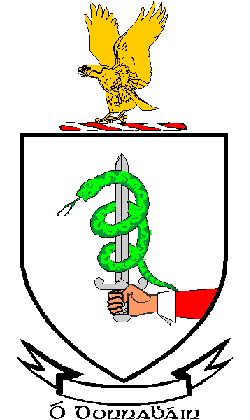Articolo
pubblicato nel gennaio-marzo 1996
JAMES
DICKEY: L’UOMO "ENERGIZZATO"
Il 19 gennaio
1997 è morto a Columbia, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, il
poeta James Dickey. Aveva 73 anni. Nonostante fosse uno tra i più
importanti poeti contemporanei americani un solo quotidiano italiano
ha riportato, con poche righe, la notizia.
Questa
disattenzione è in parte dovuta al fatto che James Dickey non apparteneva
a nessun gruppo o scuola di poesia, era un solitario – rispetto
al mondo letterario – che è sempre rimasto al di fuori e al
di sopra di qualsiasi moda letteraria. Non ha quindi goduto della
popolarità nazionale e internazionale, per esempio, dei poeti del
cosiddetto Beat movement (Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti
e altri) e negli stessi Stati Uniti è conosciuto più come autore
di romanzi di successo – il più conosciuto è Dove porta
il fiume (trad. Bruno Oddera, Mondadori) grazie anche alla riduzione
cinematografica, Un tranquillo week-end di paura, che gli
è valsa una nomination all’Oscar per la sceneggiatura
nel 1972 – romanzi che egli stesso dichiarava di aver scritto
"per pagare i conti" (Playboy Interview, Novembre
1973, su Internet, indirizzo http://www1.playboy.com/dickey/7311.html).
Come poeta invece era generalmente noto soprattutto presso gli intenditori
e gli appassionati di poesia.
James Dickey
era un personaggio fuori del comune, arrivato alla poesia seguendo
un percorso poco convenzionale. Nato nel 1923 vicino ad Atlanta,
nella Georgia, da ragazzo ai libri e agli studi preferiva lo sport
e vinse una borsa di studio universitaria proprio come giocatore
di football americano. Dopo il primo anno di università si arruola
nell’aviazione e presta servizio nel Sud del Pacifico, partecipando
a pericolose missioni notturne su aerei sperimentali. È nei periodi
di inattività tra una missione e l’altra che Dickey, per alleviare
la tensione, comincia a leggere "tutto quello su cui riuscivo
a mettere le mani" (Playboy Interview).
Tornato
dalla guerra profondamente cambiato, si iscrive alla Vanderbilt
University per approfondire la sua nuova passione, la letteratura.
Intraprende quindi la carriera universitaria fino a quando non viene
richiamato sotto le armi per la guerra in Corea. Tornato negli Stati
Uniti lavora come pubblicitario per la Coca-Cola. È solo dopo la
pubblicazione della sua prima raccolta di poesie, "Into the
Stone", che lascia il lavoro e riprende, una volta per tutte,
a dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e all’insegnamento.
Tiene l’ultima lezione alla University of South Carolina cinque
giorni prima di morire, attaccato ad una bombola d’ossigeno.
James Dickey
ha pubblicato oltre 20 raccolte di poesie, vincendo nel 1966 il
prestigioso National Book Award con la raccolta "Buckdancer’s
Choice". La natura e la guerra sono gli scenari più comuni
nella poesia di Dickey: l’orrore della guerra, la condizione
umana, la forza talvolta violenta e impenetrabile della natura sono
i veicoli attraverso i quali egli tenta di arrivare fino alla essenza
più profonda dell’uomo, fino a scoprirne quella qualità indefinibile
che lo distingue da ciò che lo circonda e che al contempo, paradossalmente,
ve lo accomuna.
Uno degli
scopi della poesia, secondo Dickey, è quello di risvegliare la forza
naturale, le emozioni, l’intuito che si sono sopiti nell’uomo
moderno attraverso la parola o l’immagine poetica "sovraccarica"
di significati come mezzo per arrivare a vivere una vita più piena,
viva e consapevole, per trasformarsi in quello che definisce come
energized man, l’uomo energizzato. Nelle poesie di Dickey
infatti sono presenti parole e versi sovraccarichi di significati
che creano non pochi problemi alla traduzione, costruite su catene
di immagini, percezioni, emozioni che si intersecano e si confondono
in modo sorprendente (nelle interviste dice spesso che "il
sorprendente è ciò che rende eccitante la poesia: più ce n’è
meglio è"). Esemplare in questo senso è la poesia "Bevendo
da un elmetto" in cui l’orrore della guerra in tutta la
sua ferocia e cieca violenza si riassume in tre sorprendenti versi:
"Nella battaglia, un cimitero / Avanzava con le truppe / Fra
cannicci e rotoli di corda" (Elmetti, trad.
Franca Bacchiega, Passigli, Firenze 1992, p. 209).
Non solo
la guerra, evento di per sé carico di drammaticità per qualsiasi
essere umano, ma anche un rapporto profondo con la natura può diventare
per Dickey un momento di altrettanto drammatica tensione interiore.
È quanto succede nella poesia "Springer Mountain" in cui
il poeta si trasforma in cervo: "Si sta muovendo. Ed io con
lui // Giù per la collina che rabbrividisce, muovendomi / Fra gli
alberi e intorno, dentro / E fuori a ceppaie e macchie / D’alloro
e pini secchi, / Fra rami che mi segnano i fianchi e rovi / Che
mi fanno rallentare, indifeso e sicuro, / Serpeggiando fino alle
acque della vita" (Elmetti, p. 87).
È attraverso
queste immagini forti, che condensano in sé tutte le emozioni che
un uomo prova in determinate condizioni che Dickey cerca la trasformazione
di sé, del proprio modo di percepire la vita, di riconquistare un
rapporto reale con la natura e con la memoria collettiva (e naturale)
dell’uomo. Solo così l’uomo come tale può sperare di ritrovare
non solo se stesso ma anche un senso profondo di comunità e di continuità
con i suoi simili. Ancora nella poesia "Bevendo da un elmetto",
per esempio, il poeta che beve dall’elmetto di un soldato morto
e che poi lo indossa arriva a percepire gli ultimi pensieri del
soldato, vede un bosco californiano di sequoie giganti dove scorrazzano
due ragazzi, uno biondo, il fratello del morto. È una immagine straordinaria
che sconvolge il poeta, lo trasforma in qualcos’altro da sé:
il soldato morto è entrato in lui, si sono fusi in un unico essere.
E infatti conclude il poema sperando di andare un giorno in quel
bosco per incontrare il ragazzo biondo e per dirgli del fratello
morto, per "narrargli dov’ero vissuto / Cosa s’era
versato, cosa s’era sparso, cosa s’era ingoiato: // E
dirgli che ero io quell’uomo".
Non sempre
tuttavia la produzione poetica di James Dickey raggiunge i traguardi
che si prefigge: c’è un lungo periodo di transizione tra le
prime e le ultime raccolte dove spesso la sua sperimentazione con
nuove forme di espressione non regge la tensione e risulta, in qualche
occasione, più vicino alla prosa che non alla poesia. Ma come hanno
notato i critici più attenti e gli estimatori di Dickey, si è trattata
di una fase importante nella evoluzione del poeta che si è così
distaccato da un certo modo di fare e di intendere la poesia nella
cultura di lingua anglosassone, superandola. Ne parla lui stesso
quando racconta che per progredire come poeta, per evolversi, per
rafforzare la propria voce, si è dovuto liberare dell’eredità
che pesa su tutta la letteratura anglosassone del grande poeta inglese
T.S. Eliot e che Dickey descrive come "la nozione di un’arte
del tutto sufficiente a se stessa dove la sola cosa importante è
ciò che rimane sulla pagina e che non ha niente a che fare con la
personalità dello scrittore" (Playboy Interview). Per
Dickey invece la personalità dello scrittore è importante, è una
parte necessariamente integrante dell’opera, ogni scrittore
trova un proprio modo di esprimersi passando attraverso la propria
personalità; nella personalità di uno scrittore, attraverso la sua
biografia si può arrivare a una comprensione più profonda e apprezzarne
in modo più soddisfacente l’opera. Dickey quindi non si è mai
accontentato di scrivere secondo i canoni ma si è impegnato nella
ricerca di una forma poetica che vestisse come un guanto il suo
pensiero, il suo stesso modo di essere, arrivando così a risultati
che nessun altro poeta contemporaneo di lingua anglosassone è finora
riuscito ad avvicinare. In questo ha ragione il poeta Chris Lott
che nell’articolo "James Dickey: An Appreciation"
(Eclectica, rivista telematica su Internet, indirizzo http://www2.polarnet.com/~eclectic/v1n5/
dickey.html) arriva a definirlo come "un vero e proprio rivoluzionario
[...] la cui opera è sottovalutata non solo per quanto concerne
l’alto valore educativo, ma anche per la rara bellezza, per
il coraggio, l’onestà e l’intensità".
Pier
Franco Donovan
*
* *
SPRINGER MOUNTAIN
Quattro maglioni tessuti
su di me,
Tutti neri, trasudanti e in attesa,
E un cappuccio di lana del giaccone da pastore
Abbottonato stretto, mi tiene fuori
Gli occhi con la vista congelata
Per lo sguardo fisso solo su una pianta.
Sono qua dove non sono stato mai,
Avvolto dalle mie più calde vesti
In attesa che la luce strisci, debole
Dalle foglie alle foglie morte, sulle foglie
Giù per la montagna sul versante occidentale.
I cervi addormentati nella luce, sopra di me, lontano
Si sono già svegliati,
e mossi,
Al passo col sole che s’inoltra strano
In basso tra le maglie fitte della macchia
Dove il mio respiro nell’aria prende forma
Come un elmetto bianco uscito dai polmoni.
Il solo albero in cui spero, si ritrae
E raggiunge le braccia del suo oro.
Il mio sguardo cade di traverso
Fra due rametti sulla china del terreno,
Poi scende come un dio dal fradiciume
Morto del tronco di una quercia mezza marcia
Piantata dritta davanti alla mia fronte.
I miei femori si sbloccano gemendo
Per lasciare che il
corpo
S’arrampichi a scovare in mezzo all’humus
Nuovi rialti fatti di rametti infranti.
Sulla schiena il fascio delle frecce
Risuona e le punte si scalfiscono.
M’arrampico fra i ciocchi lentamente
Sulle mie gambe rinate con dolore,
Le mie orecchie sviluppano un udito acuto
Tra gli animali che non vedo,
Mentre passo sotto esili
rami immobili
Conservati nella forma, tutta notte, come
Dal pensiero di una luce prevedibile.
Il sole m’entra apertamente
Nella bocca, e ne è espirato bianco,
Ma non ci sono cervi
in nessun luogo intorno a me.
Mi siedo e aspetto come fossi nell’oscurità.
Il sudore va a morire
alla radice
Dei capelli: un cervo
si materializza
Mentre scende, s’arresta, osserva.
Il sole si ferma e attende che le corna
Avanzino. Potrei anche
essere lì
In mezzo a quelle, sollevato sulle ossa della testa,
Come un uomo su un albero animale
Inchiodato finché la luce sopraggiunga:
Il sogno di un cacciatore non temuto
Che l’ha creato nel cervello al buio
E sollevato con la luce fra le corna,
Nudo, ringiovanito
A quarant’anni, come non sono stato mai.
Appendo l’arco a un ramo.
Il daino balza via e poi si ferma,
E io avanzo, staccandomi
Dalla mia ombra sfilando
Dalla testa un maglione dopo l’altro,
Pesanti, scuri e calo giù i calzoni
Fino a scalciarli via,
Stivali, calze, tutto ciò che indosso,
Via. Il mondo prende fuoco.
E immetto una luce insopportabile
Nel respiro spellato vivo dagli involucri:
E penso, cominciando con onore,
Come un animale che ama
Con l’intera ossatura delle corna:
Mi sovrasta il verde dell’eccesso
Come per i cervi d’inverno in mezzo alle abetaie
Scalpitanti a sognare uomini
Che si inginocchiano con loro, nudi, a rompere
Il ghiaccio dei torrenti con le loro facce
A bere dalle sorgenti-vita delle bestie.
Si sta muovendo. Ed io con lui
Giù per la collina che
rabbrividisce, muovendomi
Fra gli alberi e intorno, dentro
E fuori a ceppaie e macchie
D’alloro e pini secchi,
Fra rami che mi segnano i fianchi e rovi
Che mi fanno rallentare, indifeso e sicuro,
Serpeggiando fino alle acque della vita
Dove stagnano pietrificate nel letto di un torrente
Tuttavia sciolte e defluenti dalle colline
Al tocco di un volto d’animale,
Colmo di gioia ovunque
io giunga
Con l’oro del mio petto denudato,
La mia pazza risata pura come un drappo sacro,
Il cervello intontito e acuto nel tentativo
Di sviluppare ramificazioni, contento che non sia possibile.
Per pochi passi a fondo nella danza
Per quello che più sono e che sarei
E posso esser solo una volta nella vita.
Si è dileguato, e io zoppico
Cercando nel mondo i miei vestiti,
Un uomo mite, di mezza
età
Che sorride e scuote il capo,
Nello stupore di serbarlo per l’eternità.
Indosso lana calda,
I quattro maglioni alla rovescia
Con i lacci agli stivali sciolti e saltellanti,
Poi libero dal ramo l’arco teso
E mi giro, tracce di zoccoli un po’ ovunque
Sulle mie vesti da caccia in buono stato,
Per cacciare, sotto Springer Mountain,
Cervi per la prima volta e l’ultima.
(Da
Elmetti, Passigli, Firenze 1992, pp. 83-89)
I VAGABONDI, AL RISVEGLIO
I vagabondi, al risveglio,
Non sempre si ritrovano
Con l’acqua degli scoli che gli scorre sulle gambe
E il guanciale-marciapiede
Che s’indurisce quando il sonno da questo si svapora.
Di solito, lo ignorano
Ma nutrono speranze
su dove stanno andando.
Prezioso è l’aprirsi degli occhi,
Come la forma che il
corpo assume
Disteso nel modo in cui è caduto,
Incurante nell’afflosciarsi a terra
In preda all’alcool.
Con l’ubriachezza a fior di palpebra
Come bimbi nel sonno d’attesa del Natale,
Aspettano che la luce
splenda
Ovunque essa lo decida.
Spesso li porta a osservare
Dai vetri dei quartieri ricchi,
Dove sagome di cera umanizzata
Sembrano bloccate a metà del movimento
La testa girata, e come impedite
Dai vestiti. Niente di speciale, genera
Quasi disappunto.
Sperano aspettando
Ben altro:
Nel barcollare per ore
L’altra notte, avessero potuto liberarsi
Della città, in qualsiasi modo; e
Potessero giacere, sbucati da una siepe,
In un giardino di rose, pesticciato,
Con la testa sul fianco
di un bulldog,
O di un mastino, il cui respiro
Fosse come quello della
terra, naturale
O di riuscire, una volta all’anno
(Una qualsiasi alba), a risvegliarsi
In una chiesa, non sull’asse-bara
Di un banco d’ultima fila, o tra stracci di caldaia,
Ma sui gradini dell’altare
Dove le candele spalancavano
gli occhi
Con la loro luce onni-vedente
Mentre i vetri verdi
delle invetriate
Scendono su loro come foglie sacre.
Chi altro ha per Missione l’incertezza,
Di quello che vedrà uscendo dal suo sonno
Un bimbo, un poliziotto, un’effigie?
Chi altro è morto e
poi risorto?
Senza sapere mai come vi sono giunti,
Potrebbero avere camminato
Sopra l’acqua, attraverso i muri, fuori dalle tombe,
Attraverso il ‘campo del vasaio’, i fienili
I bassifondi dove i loro cuscini-pietra
Rifiutavano d’indurirsi, grazie
Alla speranza di una luce mattutina,
Con l’acqua che
scorre sulle loro gambe
Più simile, di quanto non lo sia, a una coperta viva.
(Da
Elmetti, Passigli, Firenze 1992, pp. 165-169)
IL CONDUTTORE
Alla fine della guerra
mi sollevai
Dalla branda nella tenda e camminai
Dove l’isola scendeva in bianche pietre
Fino a diventare mare verde.
Nella luce che folgorava il mio cervello
Come la nuova idea di pace, procedetti
Finché, cantando, mi trovai a nuotare.
Sopra il mezzo da sbarco
affondato
Che aveva preso l’isola, galleggiai,
E come un cardo giunsi
Sull’ampio flusso d’acqua, a riposare
Fuori mano, le mie lunghe gambe d’ombra
Puntate sul fondo dove la mia anima
Avrebbe potuto mettere radici e germogliare, secondo la sua legge.
Sotto di me un mezzo
cingolato arrugginito
Sul fondo si muoveva col movimento
Che assumono le cose osservate tra le lacrime
Di gioia, o di dolore atroce,
Quando giacciono tranquille
Al di là di questa e quello. M’immersi lentamente
E scivolai sul sedile di guida fracassato.
Guidando nel paese di
coloro che annegarono
Su di un respiro sigillato e segretamente trattenuto,
Dieci piedi sotto l’acqua, sedetti, quieto,
Adattandomi al bruciante sguardo
Dei morti ad occhi aperti, dopo la battaglia.
Vidi, attraverso il mutevole soffitto
Quella pelle lirica e increspata, inserita
Tra morte e vita, in
perenne tremito,
Sopraggiungere un aereo, perfettamente
Silenzioso, pure non avrei potuto dire
Perché ero vivo, o perché sedevo
Coi miei polmoni a forma di campana,
Al volante di un mezzo cingolato in un’onda
D’attacco che andava ad arenarsi sui coralli.
"Divento puro spirito",
provai
A dire, in una nuvola di bolle, luminosa
Ma stavo diventando solo
Ossessionato, poiché essere così
E sprofondare fuori vista e perdere
Il potere del linguaggio alla presenza
Dei morti, con occhi che mutano nel verde,
E alla fine balzar fuori
verso il cielo
Per un pelo troppo tardi, dove un altro
Saltò, mancando d’afferrare il suo
Respiro, nel luogo dove quello giace in battaglia
Come in pace, disponibile, segreto
Radioso e immenso, saturo di luce,
Per migliaia di miglia sopra l’acqua.
(Da
Elmetti, Passigli, Firenze 1992, pp. 197-201) |