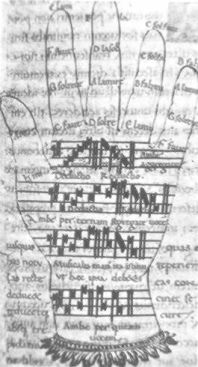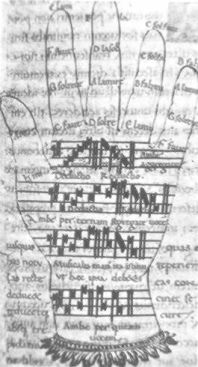 |
Uno dei primi tentativi di stabilire regole di notazione musicale è dovuto a Guido d'Arezzo (997 - 1050), ed è noto come mano musicale.
Prima di questo periodo, i sistemi di notazione si limitavano ad indicare l'andamento della melodia, gli accenti e poco altro. Questi simboli erano chiamati neumi: essi risalgono all'VII secolo, ed originariamente erano posti sopra il rigo delle parole da cantare. |
 |
Il problema è che, mancando il rigo musicale, l'altezza dei suoni era affidata alla memoria ed all'orecchio degli esecutori (questa notazione è detta in campo aperto).
I grandi centri religiosi europei, come Cluny, San Gallo, Nonantola e Benevento adottarono proprio sistemi neumatici (ne esistevano 15 famiglie): nell'immagine sono riportati quelli usati in San Gallo, in Svizzera.
Tra l'altro, i neumi non davano nozioni sulla durata dei suoni, cosa che venne introdotta successivamente (un esempio è nella seconda colonna dell'immagine). |
 |
Col tempo la notazione venne perfezionata aggiungendo un riferimento per l'altezza dei suoni, consistente in una riga rossa che indicava il Fa.
Non bastando, si aggiunse alla riga rossa una seconda riga di colore giallo, che indicava il Do. |
 |
Intorno al 1000 D.C. fu proprio Guido d'Arezzo a portare le linee a tre, ed infine a quattro: nacque così il rigo musicale, detto tetragramma.
Esso presentava ancora le due righe colorate per indicare il Do ed il Fa. |
 |
Successivamente, al posto delle righe colorate, venne inserito un simbolo per riferire le note, più precisamente si usava una C per il Do, ed una F per il Fa (erano proprio i nomi usati per le note).
Rimaneva, a questo punto, il problema della durata delle note. Per risolverlo, si pensò di rappresentare i suoni lunghi con un simbolo, ed i suoni brevi con un altro: in particolare il punctum (quadratino nero) indicava suoni di durata maggiore del virga (un quadratino con una gambetta). |
Esistono in effetti alcuni esempi in cui la scrittura attuale viene integrata da altri simboli: è quello che accade nel Kontakte di Stockhausen, in cui si possono notare simboli completamente estranei all'alfabeto musicale, ma anche indicazioni di tempo espresse in secondi. Tutto questo fa parte dello stesso movimento di ricerca che ha portato all'attuale strutturazione della scrittura musicale, che peraltro ha dimostrato finora di non perdere validità.
Esistono scritture assolutamente fuori dallo schema classico, come si potrebbe vedere in Roland Kayn: il suo Phasen è formato da colori e forme, completamente fuori dalla scrittura a noi conosciuta, creando un forte parallelo con l'arte figurativa e perde, stavolta volontariamente, la fedeltà all'intenzione originale del compositore.