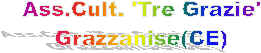
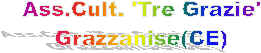
| le origini | le strade | le chiese | le ricette | allevamento della bufala | il miracolo di S. Massimiliana |
(dott. Fulvio Zito in Grazzanise, ieri e oggi, quale sviluppo?, 1985)
Il bufalo (lat. scient. Bubalus) secondo gli studiosi avrebbe avuto due diverse origini: una nell'Asia orientale, da soggetti con corna schiacciate e solcate, l'altra nell'Africa del Nord, da soggetti con corna a sezione trasversale rotondeggiante. Dalle culle di origine il bufalo si è diffuso in varie zone del globo ed è stato sfruttato per scopi diversi a seconda del luogo di allevamento: in Oriente è utilizzato come animale da lavoro, principalmente per la coltura del riso; lungo la valle del Nilo, in Egitto, è invece sfruttato come animale da latte. Per quanto riguarda l'Italia, si alleva particolarmente in Campania, nella zona dei "Mazzoni" tra il Volturno e il Garigliano e in provincia di Salerno. Un minor numero di capi si trova nelle province di Frosinone, Siracusa e Foggia. L'allevamento bufalino in Italia è rivolto principalmente alla produzione di latte e carne, e all'utilizzazione nei lavori agricoli.
I bufali sono rustici, hanno costituzione robusta, sono più longevi e soprattutto molto più resistenti degli altri bovidi alla distomatosi, strongilosi, piroplasmosi, anaplasmosi, malattie tipiche degli ambienti paludosi in cui vivono.
Il latte di bufala è di colore bianco niveo; si caratterizza per proprietà chimiche tali da farlo diffrenziare dalle altre specie di animali domestici. Il contenuto in grasso del 7,5-10 per cento fino al 14 per cento supera quello presente in ogni altro tipo di latte ed è per questo che la resa nella caseificazione sale al 18-24 per cento. In Italia il latte di bufala non è destinato al consumo diretto, bensì alla produzione di quei rinomati latticini (mozzarelle, provole fresche o affumicate) che sono vanto dei "Mazzoni".
Particolare attenzione merita poi la carne di bufala. E' stato dimostrato che essa possiede buone qualità alimentari e buon valore nutritivo. Rispetto a quella bovina ha fibre muscolari più compatte, grana più grossolana e maggior peso specifico, colore più carico che si accentua con l'avanzamento dell'età. Inoltre il grasso è più denso e più chiaro; i caratteri organolettici sono pari, se non addirittura superiori, a quelli della carne bovina. L'attitudine al lavoro del bufalo, come quella del bue, con lo sviluppo della meccanizzazione e il progresso tecnologico, non è più richiesta.
Sino ad alcuni anni fa l'allevamento bufalino era sinonimo di ambiente latifondistico, paludoso, con tipica e grossolana vegetazione, che solo questa specie sapeva e poteva utilizzare.
E proprio nelle nostre zone, in cui maggiormente erano presenti queste condizioni, nacquero le "Pagliare". Erano delle aziende bufaline, rette da una ferrea gerarchia di addetti ai lavori, nelle quali le bufale venivano allevate allo stato brado. Il latte veniva trasformato nella stessa "Pagliara" che perciò fungeva anche da caseificio.
La gerarchia della pagliara era costituita da tanti personaggi con obblighi, responsabilità, gradi e mansioni diverse. All'apice, dopo il proprietario ovviamente, c'era il "fattore", il quale aveva la carica di supervisore e di massima autorità competente. Nelle aziende in cui non era presente la figura del fattore, lo scettro del comando era impugnato dal "minorente". Questo era un personaggio importantissimo dell'organizzazione: godeva della massima fiducia del proprietario e curava la disposizione e l'assegnazione dei compiti. Scendendo nella scala gerarchica, si incontrava il "guardiano". Anche la sua posizione era molto ambita, in quanto il "guardiano" era persona di prestigio e di "rispetto". Egli, manco a dirlo, svolgeva mansioni di sorveglianza. Figura emblematica della "Pagliara" era anche il "buttero". Uomo di grande esperienza che curava, con grande perizia, il contatto con gli animali. Esperto dei formaggi prodotti nella "Pagliara", era poi in grado di chiamare per nome, in occasione della mungitura, tutte le bufale. Veniva poi il "cambiante" che era l'addetto al pascolo della bufala: siccome gli animali venivano allevati con il sistema brado ed erano liberi di ruminare tutta l'erba che desideravano, compito del "cambiante" era quello di dirigere le bufale nella direzione voluta e di non far disperdere i capi. Cerano infine ruoli di minore importanza svolti di solito dai ragazzi. Si andava dal "garzone" che obbediva al comando di tutti gli altri, fino al "vitellaro" e al "porcaro" che erano adibiti alle cure di vitelli e porci (questi ultimi venivano sfamati con il siero del latte che residuava dalla lavorazione dei formaggi).
Per l'alimentazione degli animali ogni "Pagliara" era autosufficiente, in quanto l'estensione dei terreni del proprietario-latifondista permetteva una produzione di foraggio tale da soddisfare e addirittura superare il fabbisogno dell'azienda. Oggi l'allevamento della bufala è diventato più razionale, passando dal sistema brado alla vita stallina, alla stabulazione libera.
Hosted by ![]()
Copyright © - Ass. Cult. "Tre Grazie". All rights reserved.
Webmaster: Franco Tessitore