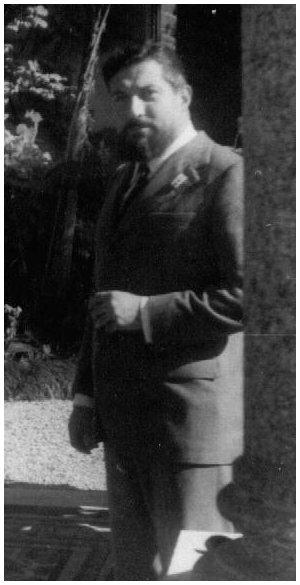 Appena lo Speleo Club Roma fu costituito mi trovai, quale membro del Consiglio Direttivo, incaricato dell’attività, a decidere, d’accordo con gli amici, le linee portanti della nostra prossima e più lontana attività: anzitutto completare l’esplorazione di Luppa, causa quasi principale della nostra fondazione, campionare e rilevare il vicino inghiottitoio dell’Ovito di Pietrasecca e, poi, caccia libera per nuove cavità, più profonde nelle speranze, nei massicci montuosi del Lazio, più o meno vicini alla Capitale: Soratte, Cornicolani, Sabini, Lucretili, Prenestini, Lepini, Simbruini, Ausoni e Aurunci ... ma anche addestrarci per compiere grandi esplorazioni più lontano ... Maucci mi aveva parlato dell’Antro del Corchia e per noi un -500 appariva, come in fondo allora realmente era, una impresa quasi himalayana. Tanti soci onorari, grandi nomi della geologia universitaria: Penta, Onorato, Scersella, Maxia, Sauro, trovati condiscendenti per i buoni uffici del carissimo Michele de Riu, che assunse l’incarico di Vice Presidente, in attesa dell’arrivo alla cattedra di Geologia a Roma di Giuseppe Accordi; De Riu ebbe la tessera numero 1, Chimenti, segretario del gruppo, la n° 2, io la n° 3; non ricordo l’ordine di tesseramento degli altri fondatori. Quando venne Accordi alla fine del ‘59 e assunse la presidenza dello Speleo Club Roma, gli fu data la tessera numero zero.
Appena lo Speleo Club Roma fu costituito mi trovai, quale membro del Consiglio Direttivo, incaricato dell’attività, a decidere, d’accordo con gli amici, le linee portanti della nostra prossima e più lontana attività: anzitutto completare l’esplorazione di Luppa, causa quasi principale della nostra fondazione, campionare e rilevare il vicino inghiottitoio dell’Ovito di Pietrasecca e, poi, caccia libera per nuove cavità, più profonde nelle speranze, nei massicci montuosi del Lazio, più o meno vicini alla Capitale: Soratte, Cornicolani, Sabini, Lucretili, Prenestini, Lepini, Simbruini, Ausoni e Aurunci ... ma anche addestrarci per compiere grandi esplorazioni più lontano ... Maucci mi aveva parlato dell’Antro del Corchia e per noi un -500 appariva, come in fondo allora realmente era, una impresa quasi himalayana. Tanti soci onorari, grandi nomi della geologia universitaria: Penta, Onorato, Scersella, Maxia, Sauro, trovati condiscendenti per i buoni uffici del carissimo Michele de Riu, che assunse l’incarico di Vice Presidente, in attesa dell’arrivo alla cattedra di Geologia a Roma di Giuseppe Accordi; De Riu ebbe la tessera numero 1, Chimenti, segretario del gruppo, la n° 2, io la n° 3; non ricordo l’ordine di tesseramento degli altri fondatori. Quando venne Accordi alla fine del ‘59 e assunse la presidenza dello Speleo Club Roma, gli fu data la tessera numero zero.Consigliati e scientificamente guidati da Giancarlo Negretti, valido alpinista e geologo scrupolosissimo, dedicammo circa quindici uscite alla grotta di Pietrasecca, rilevandola topograficamente e geologicamente e scoprendo una piccola prosecuzione oltre il sifone dato da Segre per terminale. Poi diverse puntate primaverili nel primo tratto di Luppa ed anche oltre il sifone, fino al salone Franchetti. Camponeschi felicemente aveva scoperto un passaggio ampio al di sotto del cosiddetto "sifone Dolci", che era una stretta finestrella a pelo d’acqua, ove di solito i voluminosi come me si incastravano faccia in giù senza poter respirare e venivano spinti o tirati dai compagni di squadra. Marcello Chimenti, già famoso per aver ottenuto con una lettera "strappacore" un treno di gomme dalla Ceat per la jeep del Circolo, mise in gioco tutta la sua abilità di petitore appassionato e nobilmente modesto, e dalla Snia Viscosa ci giunsero 350 metri di corda di delfion, allora le prime e migliori per roccia: quando le ritirammo le esponemmo sulla scalinata dell’Istituto di Geologia affinché tutti le vedessero. Dalla Pirelli ottenemmo il 50% di sconto su quattro mute a secco modello Procida ... anche queste le indossammo, senza sopra niente, passeggiando per l’abitato di Pietrasecca onde sottolineare i nostri mezzi per affrontare la grotta di Luppa!
E quando, a fine estate, mi recai con Bertolani e Camponeschi a pre-armare la cavità per la spedizione decisiva di settembre, i paesani che "tifavano" per noi ci avvertirono: "fate presto, perché il Circolo viene a fare Luppa il tale giorno ...". Da un nostro simpatizzante di Carsoli avemmo addirittura l’offerta di una "squadraccia" per tener lontani i concorrenti, proposta che ovviamente declinammo. Rimediammo telefoni, filo e razioni K dal Comando Militare territoriale, in base alla Circolare Operativa n. 108 ... Min. Difesa Esercito ... e, con una settimana di anticipo sul Circolo, ci accampammo nel prato antistante l’antro di ingresso di Luppa: sette tende, gagliardetto nero col pipistrello bianco e vessillo nazionale al vento, e, per i primi due giorni, una dozzina di presenti. Ma quando un mulattiere che portava i viveri dal paese giunse con un biglietto sgrammaticato che annunciava l’arrivo del C.S.R. a Pietrasecca, eravamo solo in sei: Angelucci, Bertolani, Camponeschi, Laureti, Pasquini e Volpini. La cavità era già stata armata fino al sifone "Camponeschi", la linea telefonica stesa fino al salto da 20 metri, da noi intitolato a Franco Marinotti, Presidente allora della Snia Viscosa (le corde!), non avevamo canotti ma solo le mute Pirelli ... era tangibile la pressione del Circolo ... ; e nella notte montammo a turno la guardia e quando vedemmo - o credemmo di vedere - una luce tremolante nella macchia che chiudeva a occidente la valle, io e Laureti uscimmo silenziosamente in ricognizione armati di scure l’uno e di machete l’altro: era proprio una bella avventura!
Bertolani, per imprescindibili impegni, dovette rientrare prima a malincuore a Roma, proprio il giorno in cui il Circolo pose il suo campo a circa duecento metri dal nostro. A me sembrava vedere uno di quei quadri del quattrocento con i vari campi avversi, tipo Guidoriccio da Fogliano ... esageravo evidentemente le proporzioni, ma il clima era quello, a un tempo barbarico e cavalleresco. La notte ci commuovevamo guardando il cielo stellato e una falce di luna, nel silenzio della valle cosparsa dalla dolce ombra del Monte Guardia d’Orlando, e così immaginavamo facessero anche i Saracini, là nel loro campo di cui intravedevamo le fioche luci. Prima di entrare, quando l’a me carissimo Italo purtroppo ci aveva lasciato, ero sceso con lui a Carsoli e avevo fatto ricorso all’Arma dei Carabinieri, fida speranza di ogni giusta causa (ma era così?), e ne ero tornato scortato da un brigadiere e un milite che, cercato il dirigente del campo inimico, Giorgio Marzolla, gli avevano intimato che, poiché agivamo in accordo con lo Stato Maggiore (sic!), non ardissero di entrare nella grotta di Luppa fintantoché noi non li avessimo autorizzati!
La "birbonata" sotto il profilo sportivo era veramente grossa, ma non per questo meno divertente: ricordo che ascoltavamo questo borbonico precetto ridacchiando, nascosti dietro una siepe di rovi presso il fosso. A questo punto, dovevamo proprio entrare! E ci aveva preso una pigra riluttanza all’azione, per noi la più sperata da anni. Decidemmo di entrare l’indomani, poi al mattino indugiammo e, alla fine, dopo una memorabile mangiata di agnello cottoci dalla gastalda del Casale di Luppa venuta a far da cuoca all’imbocco della grotta, io, Antonello Angelucci e Biagio Camponeschi verso le quattro del pomeriggio, carichi di viveri e del necessario per pernottare, entrammo in grotta, scortati fino al salto Marinotti da Laureti e Volpini, che tornarono fuori a presidiare il campo di sette tende vuote. In poco più di quattro ore eravamo al salone Franchetti, a -160 metri di profondità, ove cenammo con le razioni militari da combattimento e ci ponemmo a dormire sul grande deposito fangoso, nei nostri sacchi letto, protetti da un gran telo di plastica. Biagio si addormentò subito, prima di me sicuramente anche Antonello, io rimasi un poco sveglio meditando. Sì, avevo già pernottato cinque o sei volte in grotta, tre anni prima al Berger, ma era nel quadro di una grande operazione con decine e decine di colleghi di tutto il mondo, avevo già dormito una notte a Pietrasecca con Chimenti e Negretti, ma eravamo a due passi dall’uscita ed era "addestramento", ora eravamo soli a circa un chilometro dall’ingresso, per fini operativi, soli in tre, legati da fraterna fiducia e da entusiasmo: era un momento di profonda bellezza e i chiaroscuri della volta ricordavano una antica cattedrale, come fossi scolpito supino sopra di un sarcofago ... e un dilatato senso di pace avvolse anche me nel sonno.
Naturalmente la prosecuzione oltre il già esplorato fu come di frequente ridicola: al fondo del Pozzo Patrizi c’era un profondo lago ove non trovai fondo né appiglio lungo le pareti, e che pertanto permise ad Antonello, una volta riusciti parzialmente disarmando e fatta una corsa al paese, di estrarre una penna da disegno e, sotto gli occhi di alcuni membri del C.S.R. che ciondolavano al Bar Del Duca, chiudere il rilievo nel foglio appeso al muro e scriverci "lago terminale".
Nel "duello" per me affascinante, tra lo Speleo Club e il Circolo, i Monti Carseolani, che il mio amico Bertolani particolarmente aveva cari quali antica sede di adolescenziali villeggiature, continuarono a rappresentare un frequentato campo di battaglia. Avendo dovuto ritardare il loro ingresso, nel settembre ‘59, alla grotta di Luppa, in quanto occupata dalla nostra spedizione, i membri del Circolo si erano dati a ricognire le altre cavità della regione e nella vicina grotta di Val di Varri avevano scoperto una nuova diramazione che conduceva al fiume sotterraneo, oltre il sifone terminale fino allora noto, e che portò l’asse principale all’attuale quasi chilometro di sviluppo. Ma ovviamente non lo dissero a nessuno ... la notizia tuttavia filtrò: Mario Franchetti, nel corso di un’amichevole chiacchierata sui motivi della scissione, si lasciò scappare che io non immaginavo nemmeno quanto in realtà era lunga Val di Varri! Per tutto il ‘60 cercammo la prosecuzione, con stolida costanza nelle concamerazioni sopra e attorno al "lago dei rospi", senza trovarla, ma fu nel novembre del ‘61, durante il nostro 2° corso di Speleologia, che Renato Ribacchi con una squadra di allievi, dovendo attendere il suo turno di discesa nel breve salto accanto alla cascata iniziale, andò a curiosare oltre i massi crollati a destra dell’antro di ingresso e trovò tracce di passaggio che lo portarono oltre la piccola strettoia, alla saletta, e quindi al gradino roccioso che immette nel grande scivolo che arriva al fiume ... nella foga della scoperta disattese forse un po’ i suoi doveri di capo squadra e l’allievo Augusto Spernanzoni, ora primario psichiatra in un ospedale romano, volò per alcuni metri, per fortuna senza gravi esiti, tranne un gran livido al fondo schiena e una fuoriuscita di liquor dalle narici; a me, accorso preoccupato, l’olimpico Ribacchi relazionò l’incidente con la frase: "è caduto Spernanzoni, gli esce della roba dal naso, spero non sia liquido cerebrale ...!"
Ma il C.S.R., pur avendo esplorato l’intera cavità, aveva poi dormito sugli allori senza aver fatto alcun rilievo, fidando nel fatto che noi ignoravamo il passaggio. E qui, nella primavera del ‘62, scatenammo una serie di puntate per effettuare il rilievo, con particolare attenzione al dislivello (a pianta già disegnata, con Gianni Stampacchia ricontrollai in una notte tutti i gradini e le rapide, usando una livella e un metro rigido). Il C.S.R. tardivamente mandò una squadra a rilevare: i nostri velocissimi Carosone e Trigila, comandati ad una verifica di eventuali prosecuzioni nel ramo fossile a destra del sifone terminale, li scavalcarono nel grande scivolo franoso ... e al ritorno non li trovarono più. La spiegazione della rapida ritirata venne la domenica successiva quando, sommozzando (si fa per dire) nel lago della cascata che sta sotto il primo ponte di roccia a cercare una lampada a carburo cadutavi dentro, recuperai tra i massi del fondo con la lampada anche un tascapane militare alleato con dentro bussola, eclimetro, fettuccia metrica e un blocchetto su cui si leggevano ancora le prime battute del rilievo a partire dallo scivolo. Decisi di incamerare tutto quale "preda bellica" per il gruppo ma Bertolani eccepì che andava tutto cavallerescamente restituito al Circolo (forse gli piaceva anche l’ovvia ironia del gesto); Camponeschi difese il mio punto di vista e, alla fine, decisi di tenermi tutto io, così lo Speleo Club non era immischiato in questa "mala azione", se così si può chiamare il recupero di oggetto trovato abbandonato in luogo inaccessibile quale un oscuro lago ribollente dentro una grotta.
Sulla cavità presentai una nota morfologica al IX Congresso Nazionale di Speleologia, a Trieste, dello stesso anno (1963), ma già nel ‘61 l’interessante cavità ci aveva dato, a causa della "voce" sulla prosecuzione, un insperato successo: lo scheletro di un uomo preistorico!
Dopo l’incidente mortale di Adriana Androsoni, il Presidente Bruno Accordi aveva proposto di sospendere ogni uscita in grotta per un mese o due, al fine di riconsiderare le nostre tecniche (e di questo parlerò altrove più diffusamente); il C.D. aveva a malincuore accettato ma io, memore critico dei divieti avuti al Circolo, e anche allora disattesi, non mi sentii di negare il materiale a chi voleva "uscire" in grotta e così autorizzai il grintoso Gianni Stampacchia a condurre una squadra - dove? - a Val di Varri per cercare la favoleggiata prosecuzione. Di quella squadra faceva parte anche Filippo Gammarelli che, alla fine dell’inutile ricognizione, si trattenne buon ultimo sotto la scaletta che portava all’esterno, colto da improvvisa necessità fisiologica. E mentre attendeva alla bisogna, si accorse di essere "guardato" da due orbite vuote che sporgevano dal fango della breve galleria che risale alquanto a monte della cascata: si trattava proprio di un cranio e, ai suoi richiami, Stampacchia e gli altri ridiscesero il salto e constatarono che c’erano anche altre ossa sparse qua e là. Come vidi il frammento che mi avevano portato, malgrado le miei modestissime esperienze di scavo con Blanc e Radmilli, capii subito che era materiale preistorico; lo feci vedere poi alla docente di Paleontologia, Angiola Maria Maccagno, e ne ebbi conferma. Il Professor Accordi ci fece presente tutti i rischi del caso: anzitutto nessun prelievo improvvisato e selvaggio - eravamo giovani laureati, assistenti e studenti di geologia, e lo Spelo Club era sotto la sua autorevole presidenza - e poi: ... segnaliamo il ritrovamento alla Sopraintendenza dell’Aquila, competente per quell’area (anche se la grotta è in comune di Pescorocchiano, che è provincia di Rieti, e quindi Lazio), e così facciamo uno sgarbo ai colleghi romani dell’Università, o ci mettiamo nelle mani di questi e ci urtiamo col Professor Cianfereni dell’Aquila? ... Il dubbio fu risolto nel peggiore (o migliore?) dei modi: dopo un paio di settimane di faticoso contenimento dei soci sempre più entusiasti della scoperta e invasati da furori preistorici, mentre ignaro mi trovavo con Stampacchia a Torino a rappresentare il gruppo al Simposio di Speleologia "Italia ‘61", uno squadrone andò sul posto e prelevò, per fortuna accuratamente, diretto da Biagio Camponeschi, tutti i frammenti che riuscì a grattare dal fango ma, ahimè, seguito da reporter e fotografo di "Paese sera", che ne trassero un paginone ove si faceva sì una bella propaganda allo Speleo Club Roma e al suo spirito di ricerca, ma condensando in una giornata (quella ove "per caso" si erano trovati i giornalisti ...) la scoperta e lo scavo: proprio quella figura che Accordi non voleva farci fare ... il materiale fu poi per il tramite della Professoressa Maccagno consegnato a Mario Radmilli, che allora era alla Sopraintendenza dell’Aquila, e proprio da Radmilli, che ora è titolare di Paletnologia a Pisa, ho avuto recentemente la conferma che si trova in un deposito a Viareggio: si tratta di uno scheletro quasi completo, con ogni probabilità fluitato dal torrente Varri dopo lo sbancamento della sepoltura per una piena, e riferibile all’industria litica trovata entro la "grotta superiore", insediamento di cacciatori appenninici della fine del neolitico, caratteristicamente longilinei e con ossa lunghe e sottili.
Avevamo già rilevato e studiato l’inghiottitoio di Pietrasecca nell’inverno del ‘59, anche con un pernottamento in grotta, credo il primo nell’Appennino Centrale, ricognito la breve e fetida risorgenza di Tufo (vi si gettano le acque nere del soprastante paese), battuto invano gli altri tre bacini chiusi dei Carseolani (Roccaberardi, Pozzoleonardo e Monte Piano), discesa l’unica cavità verticale, il Pozzetto delle Cretare presso Pescorocchiano, sottostante una modesta coltre argillosa (onde il nome), visitato il grottone presso Tramonti, quando un’altra inaspettata occasione ce la diede, naturalmente senza saperlo e volerlo, il Circolo Speleologico Romano.
Già al III Convegno degli Speleologi dell’Italia Centrale a Perugia, nel marzo 1962, avevo scandalizzato il Prof. Mario Pavan, allora segretario della S.S.I., dichiarando che avremmo rispettato ogni precedenza di lavoro in grotta, purché dichiarata ufficialmente "prima", ma che il semplice ritrovamento di materiale di armamento in corso di chiaro impiego in una cavità ci sarebbe solo servito ad andare più avanti nella stessa grotta, e il segreto delle operazioni in programma da parte di un gruppo non avrebbe difeso nessuna esclusiva quando ne fossimo venuti a conoscenza per caso o per malizia ... ma, proprio in quella sede e forse in seguito al mio discorso, addivenimmo ad un accordo preliminare tra i gruppi romani, allora mi pare solo tre (il Circolo, lo Speleo Club e l’URRI), per una linea di comportamento leale e cortese nell’attività esplorativa. A perfezionare tale accordo fummo convocati qualche mese dopo nella sede dell’URRI e per lo Speleo intervenimmo io e Biagio Camponeschi, per il C.S.R. parlò - ma c’erano anche altri che non ricordo - Mariano Dolci. Era sulla fine dell’estate, se non già autunno, la sera di un martedì o mercoledì ... ma la domenica prima Antonio Mariani e Renato Ribacchi in caccia di grotte nella nota zona, non ricordo se indirizzati o di loro iniziativa, o su informazioni raccolte a Pescorocchiano, comparvero a Civitella nella valle del Salto, dove "scopersero" l’omonima risorgenza (detta anche di Nesce). Gli abitanti del luogo li indirizzarono, scambiandoli per amici di quelli che avevano visto la domenica prima, e che l’avevano svuotata con un lungo lavoro di pompa a motore, che avevano lasciata poi in deposito lì in paese; senza smentire la falsa opinione dei buoni villici, i due ricognirono rapidamente la lunga cavità, di solito sifonante, per qualche centinaio di metri ed avinsero che il Circolo aveva solo terminato il lavoro di svuotamento e doveva tornare quanto prima a completare ricerche ed esplorazioni. Io e Camponeschi cercammo, davanti al perplesso rappresentante dell’URRI, di far dichiarare a Dolci che il Circolo stava operando alla risorgenza di Val di Varri (tale è inequivocabilmente la sorgente di Civitella), cioè a comportarsi "in pratica" secondo quel codice di comportamento che "in teoria" stavamo approvando, ma sul volto espressivo del vecchio amico scorgevamo i segni di un conflitto interiore, domandandosi in cuor suo se potesse fidarsi di noi o se questo codice di comportamento fosse solo un barbarico espediente per carpirgli i piani di battaglia del suo gruppo: non si fidò! Se avesse parlato ci avrebbe bloccato ma ... in istrada io e Biagio ci guardammo con un sospiro e decidemmo di agire al più presto: onde non rischiare di essere preceduti, con una serie di telefonate la sera stessa riuscimmo a far partire per Civitella, la mattina dopo, a metà settimana, una quindicina di soci suddivisi in due squadre di rilievo, una squadra fotografica ed una di subacquei; Bertolani e Ribacchi diressero il rilievo dei due rami in cui si divide la galleria, Giancarlo Costa scattò bellissime fotografie, io e Lucio Valerio ci immergemmo nel sifone che solo Lucio, grazie all’ARO, riuscì a varcare, mentre io rimasi a metà strada ad attenderlo, impacciato da un bibombola ad aria. Lasciatemelo dire: questo era allora lo Speleo Club Roma!!
Il giorno dopo ancora il tempo si guastò, piovve a dirotto e la grotta per alcuni anni tornò ad essere solo una grossa sorgente impenetrabile; il Circolo la domenica recuperò la pompa in paese, senza poter entrare: avevano in pratica lavorato per noi.