Centro Per Il Potenziamento Cognitivo
“VEDERE VOCI”
UN VIAGGIO NEL MONDO DEI SORDI *
...Guida di viaggio a cura di Lucia Berardinelli
Conoscere
l'altro per comprendere sé
Vi è dunque un linguaggio - la lingua dei segni usata dai sordi - che presenta un'organizzazione "altra" rispetto a quella che ci è familiare: un'organizzazione completamente visiva (legata allo spazio invece che al tempo e perciò altra rispetto al parlato).
Anzi, per la precisione, esistono differenti lingue nazionali dei segni, passate e presenti (americana, francese, cinese, yiddish e italiana) - da non confondersi con le forme segnate delle lingue locali, che sono mere traslitterazioni, prive della struttura presente nelle vere lingue dei segni.
Al di là delle specifiche differenze, tutte queste lingue utilizzano in modo peculiare il linguaggio.
Come afferma Sacks, proprio per questa sua peculiarità, la lingua dei segni fornisce un'occasione preziosa per guardare al linguaggio verbale, al parlato, con occhi nuovi. Il suo differire ci sprona a comprenderne meglio natura e meccanismi della nostra lingua, che ci è talmente abituale da divenire difficilmente per noi oggetto d'indagine, almeno quanto ai suoi significati più profondi, comunicativi e cognitivi.
In questo senso, nonostante la diffusione molto limitata, la lingua dei segni riveste una notevole importanza per chi s'interessa della complessità dei codici linguistici e del modo in cui essi possono plasmare il pensiero.
Seguendo l'indagine di Sacks sul danno che può portare
- allo sviluppo del linguaggio e del pensiero - la sordità prelinguistica ** (diversamente da quella postlinguistica), risulta prima di tutto, con evidenza, che noi non parliamo né pensiamo con parole o segni soltanto, ma con parole o segni che rimandano gli uni agli altri in un modo particolare. Risulta dunque l'importanza della capacità di proposizionare, ossia combinare adeguatamente i singoli segni in proposizioni.
Ciò che si perde, infatti, nella sordità prelinguistica (se non si interviene in modo tempestivo) è proprio questa capacità "combinatoria". E tale perdita si traduce nell'incoerenza e atrofia del pensiero stesso.
"Il sordo privo di linguaggio può veramente essere come un idiota, e in un modo particolarmente crudele, in quanto l'intelligenza, benché presente e forse ricca, è bloccata fintanto che dura la mancanza del linguaggio".
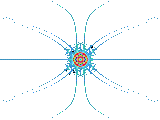
Rimuovere
la diversità o lasciarsene affascinare
I sordi congeniti, i sordomuti, furono ritenuti degli idioti e lasciati nella più assoluta ignoranza culturale e sociale per migliaia di anni - afferma Sacks, nell'ambito della sua ricostruzione storica della considerazione sociale di queste persone, di grande interesse anche per il modo in cui fa emergere la forza del pregiudizio.
"Incapaci di apprendere il linguaggio parlato, pertanto muti; incapaci di godere di un libero scambio di comunicazioni perfino con i genitori e i familiari; tagliati fuori, salvo che nelle grandi città, anche dalla comunità dei loro simili".
Solo verso la metà del 700 si cominciò a porre rimedio a questa situazione.
I filosofi illuministi rimasero infatti chiaramente affascinati dalle questioni e dai problemi singolarissimi sollevati da esseri umani che apparivano privi di linguaggio. Cominciarono quindi a interrogarsi sui motivi per cui degli uomini - che pure avevano tutto quanto occorreva per provare sensazioni, per acquisire idee e combinarle - rimanessero stupidi.
Le prime risposte che emersero furono che i sordi non possedevano simboli per fissare e combinare le idee.
Ma alla base di questa concezione - commenta Sacks - stava una convinzione erronea, tipica della nostra cultura, e cioè che i simboli dovessero necessariamente essere parole.
Convinzione che è anche una riprova della nostra radicata tendenza alla pigrizia mentale, della difficoltà che incontriamo nel considerare possibilità davvero altre rispetto a quelle che rientrano nel nostro normale universo.
Perché in effetti già agli inizi della nostra tradizione culturale qualche pensatore aveva suggerito che le cose potessero stare diversamente.
Ad esempio, nella Grecia del V secolo a.C., Socrate sosteneva (secondo quanto troviamo scritto nel Cratilo di Platone):
"Se noi non avessimo né voce né lingua, ma ciò nondimeno volessimo manifestare l'uno all'altro le cose, non ci sforzeremmo, come fanno ora i muti, di significare il nostro intendimento con le mani e con il capo e con il resto del corpo?".
Eppure...
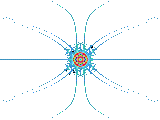
Mancare
di qualcosa e tuttavia essere completi
Solo recentemente si è compreso che la lingua dei segni è una lingua completa, capace di esprimere non solo tutte le emozioni, ma anche qualsiasi proposizione, una lingua che permette a chi la usa di discutere qualsiasi argomento, concreto o astratto, con altrettante efficacia e ricchezza grammaticale della lingua vocale.
Tale lingua è però un linguaggio visivo che determina la nascita di un sistema di pensiero visivo, nel quale la costruzione del mondo avviene in un modo radicalmente diverso dal nostro. Il riferimento spaziale è infatti essenziale nella lingua dei segni, mentre la nostra lingua (che combina i suoni in parole e le parole in sequenze più lunghe), è legata essenzialmente al tempo.
Molto interessante a questo proposito è la dichiarazione di intenti di Sacks: tale lingua va studiata "dall'interno", per cogliere le regole di quella che egli definisce la "grammatica dello spazio", e quindi anche il modo in cui si strutturano (a un tempo) proposizioni e pensieri, nel contesto di una relazione segno-pensiero non mediata dalle parole, e da tutto ciò che esse comportano.
Quando segnano - dice Sacks - i sordi costruiscono una scena completa: ogni oggetto, ogni persona hanno una collocazione spaziale; tutto viene visualizzato con una ricchezza di particolari che di rado si trova in una conversazione tra udenti. È come se fossero degli scenografi.
Anche questa caratteristica rende il linguaggio dei segni un terreno di confronto importantissimo, dal momento che la caratteristica fondamentale del nostro linguaggio è invece la scissione della parola da tutte le altre dimensioni (tramite sua trascrizione) e il procedere monolineare.
Procedere che, secondo studiosi della cultura come Havelock, Ong, McLuhan e filosofi come Derrida, si tradurrebbe nell'organizzazione razionale del pensiero tipica della tradizione occidentale, che ordina gli eventi in catene lineari di cause ed effetti, e che nella cultura contemporanea entra in crisi, non risultando più efficace nel rispondere alle esigenze di un mondo in cui la simultaneità e la compresenza di diverse dimensioni tornano a imporsi.***
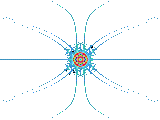
Negli anni Sessanta del XX secolo si è cercata di creare lingue intermedie tra quella parlata e quella dei segni: l'inglese segnato, l'italiano segnato, ecc.
Ma si è trattato di una soluzione illusoria, che ha portato soltanto - a giudizio di Sacks - a un impoverimento del linguaggio dei sordi.
Li si è infatti costretti a imitare coi gesti - per quanto possibile - il parlato e la sua costruzione grammaticale e così si è parsa la ricchezza del loro lingauggio, con conseguente impoverimento del pensiero.
Come afferma Sacks, alla base di questo tentativo si può rintracciare ancora una volta la mancata consapevolezza del fatto che le vere lingue dei segni (quelle che i sordi sviluppano autonomamente, nelle loro comunità) sono lingue autosufficienti, con sintassi e semantica complete, aventi semplicemente natura diversa rispetto alle lingue parlate e scritte.
Proprio questa diversità di struttura rende impossibile tradurre parola per parola, o frase per frase, una lingua parlata nei segni.
Le lingue segnate, invece, obbligano i sordi a imparare i segni non per esprimere idee e azioni, ma per indicare suoni fonetici che essi non possono udire: sono - conclude Sacks - un compromesso che non è assolutamente necessario.
E ciò suona come un monito per chiunque operi nel campo della disabilità, con strumenti e metodi di compensazione che dovrebbero essere - sempre e incessantemente - sottoposti a esame critico.
E forse rende anche un po' più chiaro perché sia tanto importante fondare questi strumenti e questi metodi su una riflessione capace di indagare gli assunti teorici e l'esistenza di altre possibilità, per quanto nel fare quotidiano tutto ciò possa (erroneamente) sembrare non così rilevante.
* "Vedere voci.
Un viaggio nel mondo dei sordi"
è un testo di
Oliver Sacks,
edito da Bompiani (1989).
N.B. Il testo contiene
esperimenti
e materiali professionali
che mettono in contatto "diretto" con questo linguaggio.
Per esempio,
la raffigurazione
di alcuni gesti,
e la ricostruzione
al computer delle traiettorie spaziali disegnate da
chi segna.

** Per sordità prelinguistica si intende l'assenza dell'udito dalla nascita o dalla primissima infanzia, prima quindi che si siano acquisiti gli elementi fondamentali del linguaggio.



*** Per esempio,
in psicologia
si afferma la
teoria di campo:
nuovo modo di spiegare i fenomeni, secondo un approccio olistico, per cui il tutto è qualcosa di più, o meglio qualcosa di diverso, dalla somma delle parti.
Tale teoria, elaborata dalla fisica moderna, venne applicata:
-
allo studio della percezione, dalla scuola tedesca della "psicologia della Forma" (o Gestalt),
-
allo studio delle motivazioni individuali e dei processi interpersonali, da Lewin (che alla "psicologia della Forma" si richiama).
La proprietà fondamentale del concetto di campo delle scienze fisiche è che esso permette di ragionare sui fenomeni non più sulla base delle caratteristiche dei corpi (che nel campo si situano) - ad esempio la massa, il volume, ecc. - quanto invece sulla base della configurazione globale del sistema (in cui i corpi sono compresi e che essi stessi contribuiscono a formare, con le loro relazioni reciproche).
