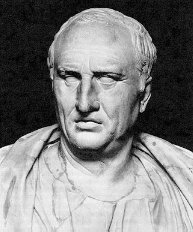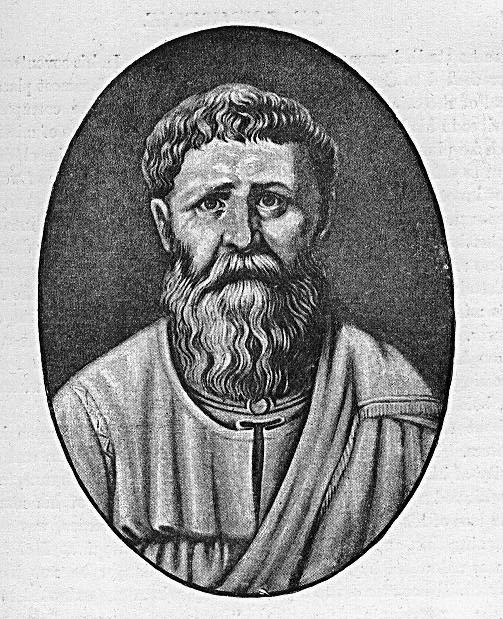Il latino è una lingua appartenente al sottogruppo italico delle gruppo indo-europeo, che comprende le lingue italiche quali l’osco, l’umbro e il venetico, il greco, le lingue indoarie, iraniche, germaniche, baltiche, slave, celtiche, l’albanese, l’ittita e il tocario (gli ultimi due oggi estinti).
Latino arcaico
La fase arcaica è rappresentata dal latino preletterario, fra i cui esempi più importanti sono:
-
la fibbia di Palestrina (fibula Praenestina), databile intorno al VI/VII sec. a C., rinvenuta a Palestrina nel 1871 ed esposta al Museo Preistoico Pigorini di Roma;
il vaso di Dueno, rinvenuto a Roma nel 1880;
la Pietra nera (Lapis niger), scoperta nel 1899 nel foro romano, dov’è tuttora situata, e databile attorno al 500 a.C.;
- il carme dei fratelli Arvali (carmen fratrum Arvalium).
Latino classico
Alta e media repubblica
Con la caduta dell’ultimo mitico re, Tarquinio il Superbo, viene fondata la repubblica (509 a.C). Per la prima attestazione letteraria occorrerà attendere l’anno 240 a.C. (513 dalla fondazione di Roma), quando Livio Andronico (Livius Andronicus), uno schiavo liberato, proveniente dalla città greca di Taranto, fece rappresentare per la prima volta un testo scenico in lingua latina. La lingua latina si è radicata ovunque sia stata portata dai conquistatori romani, soppiantando le parlate locali nella quasi totalità dei casi (unica eccezione il basco, lingua pre-indoeuropea che sopravvive ancora oggi in Francia e in Spagna). Fra gli scrittori che hanno illuminato quest’epoca si ricordano, oltre al già citato Livio Andronico, Ennio (Ennius, nato a Rudiae, presso Lecce), Plauto (Titus Maccius Plautus), Nevio (Gnaeus Nevius), il cartaginese Terenzio (Publius Terentius Afer), il brindisino Pacuvio (Marcus Pacuvius), il campano Lucilio (Gaius Lucilius), Catone (Marcus Porcius Cato), Varrone (Marcus Terentius Varro), Columella (Lucius Iunius Moderatus Columella).
La tarda repubblica e l’età di Augusto
In questo periodo la lingua latina, oltre a continuare la sua inarrestabile diffusione e il suo consolidamento, si rivela un grande strumento per la produzione di alcuni fra i maggiori capolavori letterari dell'umanità.
L’età di Cesare
L’età di Augusto
Il massimo poeta di questo periodo è il mantovano Virgilio (Publius Vergilius Maro), cantore dell’epopea della stirpe giulio-claudia, cui apparteneva l’allora imperatore. Altri sommi poeti che illuminarono quegli anni furono Orazio (Quintus Horatius Flaccus), Tibullo (Albus Tibullus), Properzio (Propertius) e Ovidio (Publius Ovidius Naso). Scrisse in questo periodo il grande storico padovano Tito Livio (Titus Livius).
L’età imperiale
Finiti i fasti dell’età di Augusto, subentra un periodo di decadenza. Ricordiamo l’opera di Claudio Claudiano (Claudius Claudianus).
Latino cristiano
La creolizzazione del latino
Avete mai osservato quanti errori di pronuncia, di grammatica, di ortografia etc. commette uno straniero che parla la vostra lingua? E stranieri rispetto ai Latini erano i numerosi popoli sottomessi al dominio di Roma, dagli Umbri ai Galli agli Etruschi agli Iberi etc. Tutti questi popoli parlavano, o meglio si sforzavano di parlare un latino piuttosto approssimativo, con i loro inevitabili barbarismi (basti qui ricordare che la parola “barbaro”, di orgine greca, significava letteralmente “balbuziente”). Ad esempio, gli iberi non sapevano pronunciare la lettera f, come oggi i baschi; per tale motivo quando si sforzavano di parlare in latino, dicevano *harina, *hilius, *hemina etc. al posto di farina, filius e foemina, e così oggi si dice in spagnolo (harina, hijo, hembra). Attraversando i Pirenei, notiamo che lo stato di estrema semplificazione in cui si è ridotto il latino in Francia (augustum > [ut], aquam > [o], solidum > [su], mensem > [mwa], filius > [fis], maturum > [myR], etc.) rivela il profondo influsso di una o più lingue di sostrato che mal sopportavano il sistema fonetico latino, e che, a causa della forte intensità con cui era pronunciato l’accento, ha portato alla caduta di gran parte delle vocali atone. In gran parte dell’impero tendevano poi ad affermarsi voci diverse da quelle classiche, tipo casa o mansio per domus, caballus per equus e focus per ignis, che ritroviamo in quasi tutte le lingue romanze: italiano casa, cavallo e fuoco, francese maison, cheval e feu, spagnolo casa, caballo e fuego, romeno casă, cal (ma apă < equa) e foc; in sardo invece abbiamo ancora oggi domu, poi caddu (ma ebba < equa), e fogu. La declinazione è sopravvissuta in poche regioni d’Europa. Il romeno conserva tracce della declinazione, ma anche il francese nel medioevo possedeva due casi (sujet e régime). In romeno i nomi femminili (contrariamente al francese medievale, che declinava solo i maschili!) conservano un caso obliquo anche nelle forme indeterminate. Per esempio, soră = soror, surori = sorori, sora = soror illa, surorii = sorori illae. Un impero così vasto era dunque popolato da genti così diverse che, una volta accolto il latino come lingua principale in sostituzione della propria, hanno cominciato a storpiarlo alla loro maniera, dando così origine nel giro di poco tempo alla nascita di idiomi che possono definirsi creoli del latino. Sbagliano quanti affermano che le lingue romanze attuali rappresentano un’evoluzione del latino; in realtà rappresentano una “rivoluzione” del latino: il latino in bocca a popoli stranieri ha comportato una cesura netta con la tradizione linguistica latina. Di evoluzione si può parlare nel caso della lingua greca, non della lingua latina.
Latino medievale
La nascita di creoli a base latina in Italia, Francia, Spagna e Portogallo (ci si accorgerà più tardi della sopravvivenza di parlate a base latina anche nel territorio dell’antica Dacia, l’odierna Romania), non ha impedito che il latino mantenesse una sua vitalità per tutto il medioevo quale lingua scritta in tutta l’Europa (la prima attestazione scritta di un volgare romanzo risale all’842, data di stesura dei Giuramenti di Strasburgo, che sancivano la spartizione dell’impero fra i nipoti di Carlo Magno, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico).
Dopo un periodo di instabilità della lingua (VII - VIII secolo d.C.), Carlo Magno promosse un rinnovamento dell’istruzione e un ritorno allo studio della grammatica latina, convocando a corte l’inglese Alcuino. Fu ideato il carattere di scrittura carolingio, derivante dalla scrittura onciale. Si parlerà per questo di Rinascenza carolingia.
Vediamo quali furono le caratteristiche del latino in questo periodo. Le vocali persero definitivamente la distinzione in base alla quantità; fu ampliato l’uso delle preposizioni; l’ordine delle parole nella frase divenne meno libero; la sintassi si semplificò ulteriormente, con apporti dalle lingue romanze (ad esempio la proposizione relativa introdotta da quod) e il lessico fu continuamente ampliato. Nella grafia i dittonghi si semplificano (ae e oe passano a e), si usano le y a sproposito (sylva, phylosophia) e ch al posto di h (michi = mihi, nichil = nihil, da cui “annichilire”). La grafia classica sarà restaurata soltanto con l’Umanesimo. Fra i più significativi scrittori di questo periodo, Alcuino, Pietro Abelardo, Hrosvita, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio.
Latino rinascimentale
Latino moderno
La lingua latina è stata usata abbondantemente nella scienza e nella filosofia fino agli inizi del XIX secolo da scrittori come Isaac Newton, Benedetto Spinoza e Renato Cartesio, e nella letteratura fino ai giorni nostri da poeti come Arthur Rimbaud (1854-1891), Giovanni Pascoli (1855-1912), Joseph Tusiani (1924) e Michele Sovente (1948).Latino lingua internazionale
a) A chi obietta che il latino abbia una struttura morfologico-sintattica complicata, rispondo che ritengo profondamente sbagliato impostare il problema in termini esclusivamente di praticità, quando sappiamo benissimo che in tutte le questioni della lingua che si rispettino la scelta dell’impiego di un idioma piuttosto che di un altro si effettua essenzialmente in base a criteri culturali (pensiamo soltanto alla rinascita dell’ebraico: perché mai gli ebrei sarebbero stati tanto balordi da prodigare sforzi immani in vista di riportare in vita una lingua “morta” duemila anni prima?). Dire che la scelta debba vertere sulla lingua di minore complessità morfologico-sintattica è semplicemente un’assurdità. Facili o difficili che siano, stiamo pur sempre parlando di linguaggi umani, non di linguaggi extraterrestri: faremmo quindi una grave offesa all’intelligenza umana affermando che le uniche lingue degne di essere imparate siano quelle dalla struttura più semplice. Personalmente ritengo che un linguaggio maggiormente complesso sia sinonimo di superiorità culturale e che addirittura favorisca lo sviluppo dell’intelligenza di chi ne fa uso. Con questo non voglio dire che la lingua d’Europa debba essere necessariamente quella di maggior complessità, sto solo manifestando parere contrario ad una scelta che favorisca esclusivamente le lingue dalla struttura semplice. Ribadisco ancora una volta che a mio avviso la scelta va compiuta in base a criteri culturali: l’Europa possiede già una lingua di cultura, e questa è il latino; non la parla quasi nessuno, eppure già la possiede, in virtù della sua tradizione scritta ininterrotta, dall’antichità ad oggi (non si è mai smesso di scrivere in latino: altro che lingua morta! morto sarà semmai l’etrusco...); questo è già un buon punto di partenza (del resto, al momento dell’unità d’Italia, il 78% della popolazione della nostra penisola non conosceva litaliano...). Il latino una lingua impossibile da parlare? Chi ha partecipato ad uno dei numerosi campi estivi dedicati alla pratica full-immersion di questa lingua vi potrà testimoniare il contrario. Vari sono al giorno d’oggi in Europa i tentativi di recupero del latino a fini pratici, anche a livello ufficiale: 1) La Presidenza Finlandese dell’Unione Europea ha divulgato la propria agenda anche in latino; 2) alcune emittenti radiofoniche, come l’emittente finlandese di Stato (YLE) e la tedesca Radio Brema, trasmettono una volta alla settimana un notiziario in lingua latina: avete capito i nordeuropei? Mentre in Italia, culla della latinità, si dorme... Non mi sembra che in questo caso si possa parlare di patriottismo esagerato o di volontà di richiamarsi alle proprie radici culturali, come qualcuno potrebbe pensare, memore dei tristi fasti del fascismo, che si richiamava ampollosamente alla romanità. Sfido chiunque a trovare una lingua più paneuropea del latino!
b) A chi storce il naso di fronte all’eventualità del recupero di una lingua dell’antichità, non solo nell’errata convinzione che la morte di una lingua sia equiparabile alla morte di un organismo vivente, ma anche in considerazione dell’impossibilità di ricostruirne l’esatta pronuncia, obietto che seguendo tale ragionamento avremmo dovuto lasciare nella tomba anche l’ebraico, lingua tornata alla sua naturale funzione veicolare nella Palestina di fine XIX secolo, privando l’umanità di fior di scrittori quali Amos Oz, Avraham Yehoshua, David Grossmann, Josef Agnon (premio Nobel) e quant’altri... Tale lingua è risorta, incurante del fatto che l’alef e l’‘ayin non sono riusciti a conservare una pronuncia distinta come ai bei vecchi tempi (tranne che per gli ebrei provenienti dai paesi arabi), così come il tav e il tet, il sin e il sade, etc... Non dimentichiamo poi l’esempio dell’India, dove il sanscrito è una delle 18 lingue riconosciute dalla Costituzione della federazione, anche se de facto è l’inglese a fungere da lingua franca del subcontinente. Ricordo a tal proposito (fonte: Central Institute of Indian Languages) che nel censimento del 1991 49.736 indiani hanno dichiarato propria lingua madre il sanscrito. La popolazione nel frattempo è cresciuta vertiginosamente, di conseguenza lo saranno in proporzione anche i sanscritofoni...
Sono d’accordo che nell’immediato la lingua più realisticamente utilizzabile quale veicolo di comunicazione internazionale (ma si badi bene, non solo degli Europei, ma di tutti gli esseri umani) sia l’inglese; altra invece è la questione se UNA lingua debba essere scelta quale lingua UFFICIALE (al momento le lingue ufficiali sono 11, e inevitabilmente aumenteranno con l'ingresso dei paesi dell’Est che già bussano alla porta...) dell’Unione Europea, e quale questa debba essere. Qui esuliamo dall'argomento del mero utilizzo di un idioma a fini pratici (ripeto: d’accordissimo sull’inglese, e aggiungerei lo spagnolo), ed entriamo in una dimensione più vasta, che ha a che fare con le radici comuni della cultura europea. In questo senso allora il latino è anche la lingua in cui scrivevano e si esprimevano i vari Erasmo da Rotterdam, Lorenzo Valla, Guarino Veronese, Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Marc-Antoine Muret, Guillaume Budé, Renato Cartesio, Benedetto Spinoza, etc... Visto che ho accennato ai paesi dell’Est, ricordo che fino alla metà del XIX secolo la lingua ufficiale del Parlamento ungherese era il latino. È un dato di fatto che l’unica lingua di cultura comune a tutta l’Europa sia il latino. Non si può dire che lo sia l’inglese, dato che, ad esempio, nessuno scrittore si è mai espresso in questa lingua al di fuori dei paesi anglosassoni e relative ex colonie (India in primis – ancora l’India! –, che produce una letteratura in questa lingua di primissima qualità)... Né che lo sia il greco, che dalla fine dell’età imperiale non è mai stata lingua impiegata attivamente al di fuori della Grecia e dell’oriente ellenistico. Per voler essere realistici, i nazionalismi in Europa sono ancora troppo forti (in fondo la II Guerra mondiale è terminata poco più di mezzo secolo fa...) perché si possa pensare alla scelta della lingua (ripeto, parliamo di UNA lingua UFFICIALE, non di un linguaggio di comunicazione universalmente riconosciuto) di UN SOLO paese, con esclusione di quelle dei restanti paesi; la lingua latina, proprio perché essa oggi non è propria di nessuno Stato, ha caratteri di internazionalità e di europeità estranei a qualsiasi altra lingua legata ai rispettivi popoli che la usano quotidianamente.
Testi
Dal “vaso di Dueno”:
IOVESAT DEIVOS QVOI MED MITAT NEI TED ENDO COSMIS VIRCO SIED
ASTED NOISI OPE TOITESIAI PACARI VOIS
DUENOS MED FECED EN MANOM EINOM DV(/Z)ENOINE MED MALO STATOD
1 HON(CE) = hun(ce) / 2.SAKROS = sacer (sakros < sakrs < saker) / ESED = erit (esed < ered < erid < erit) / 5.REGEI = regi / 6.PREVAM = privam; (cf subtilis en tela) / 10.IOXMENTA = iumenta
Dalla “Pietra nera”:
1.QUI HUN[C LUCUM VIOLAVIT... 2. ...]SACER ERIT 3.SORD[ES NE QUIS FUNDAT... 4. ...]A.AS 5.REGI IU[S ERIT PIACULUM FACERE... 6. ...MULTATE MULTAM PR]IVAM 7.QUOS RE[X MULTARIT BOVES DANTO... 8. ...REX...]CALATOREM 9.HAB[ETO... 10. ...IUNGEN]TO IUMENTA 11. CAPITA DUO TAU[R(UM)... 12.CIRCUM ITER PE[R... 13. ...EU]M QUI AVILLO 14. NEQU[E....FACIAT... 15. ...]IUS IUSTO 16.LUCO[...
Dal “carme dei fratelli Arvali”:
E NOS LARES IUVATE [E] NOS LARES IUVATE E NOS LARES IUVATE NEVE LU[EM] RUEM MARS SINERIS INCURRERE IN PLURES NEVE LUEM RUEM MARS [SI]NERIS INCURRERE IN PLURES NEVE LUEM RUEM MARS SINERIS INCURRERE IN PLURES SATUR ESTO [F]ERE MARS LIMEN [SAL]I STA ILLICO SATUR ESTO FERE MARS LIMEN SALI STA ILLICO SATUR ESTO FERE MARS LIMEN SA[L]I S[T]A ILLICO (SATIS FUERUNT MARS LIMEN SALI STA ILLICO) [SEM]UNIS ALTERNI VOS ACCIPITE CUNCTOS SEMUNIS ALTERNI VOS ACCIPITE CUNCTOS SEMUNIS ALTERN[I] VOS ACCIPITE [CUNCT]OS ET NOS MARS IUVATO ET NOS MARS IUVATO ET NOS MARS IUVATO TRIUMPE TRIUMPE TRIUMPE TRIUM[PE TR]IUMPE
Collegamenti ad altri siti
Vita Latinitatis, il portale della latinità viva: www.latinitatis.comForum Romanum, portale della Latinità: www.forumromanum.org
Vicipaedia, la prima libera enciclopedia elettronica in latino: la.wikipedia.org
Didattica:
Schola Latina Universalis, una scuola di latino vivo a distanza e alla portata di tutti, nata da un'idea di Avitus: schola_latina.alcuinus.net/Strumenti didattici per l’apprendimento del latino: www.polyglotte.org/latin.html
Materiale on-line, offerto dall’Università di Saint Louis: www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/latin/tchmat/tchmat.html
Il Prof. Terence Tunberg è l’artefice del programma di Latino attivo all’Università del Kentucky: www.uky.edu/AS/Classics/latinitas.html
Cambridge Society for Neo-Latin Studies: www.classics.cam.ac.uk/Faculty/Neo-Latin.html
International Association for Neo-Latin Studies: fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/ianls
Centre for Neo-Latin Studies: www.ucc.ie/acad/classics/CNLS
Academia Vivarium Novum: www.vivariumnovum.it
Cursus vivae latinitatis: www.urich.edu/~wstevens/latviv.htm
Seminaria latinitatis vivae: www.uni-saarland.de/fak5/stockmann/voxlatina/slv.htm
Septimanae Latinae Europaeae: www.maierphil.de/SeptLat
Dialoghi latini, in formato PDF: www.nle.org/scripts.html
Media:
 Nuntii latini, notiziario della Radio Finlandese YLE: www.yleradio1.fi/nuntii
Nuntii latini, notiziario della Radio Finlandese YLE: www.yleradio1.fi/nuntii
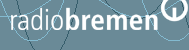 Un altro notiziario, questa volta di Radio Brema: www.radiobremen.de/online/latein
Un altro notiziario, questa volta di Radio Brema: www.radiobremen.de/online/latein
Nuntii latini della Radio Vaticana: http://www.radiovaticana.org/tedesco/nuntii_latini.htm
LATINITAS, rivista in lingua latina publicata nella Città del Vaticano sotto gli auspici del Pontefice: www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_lt.htm
Der Kurier, quotidiano austriaco, pubblica un articolo domenicale in latino sotto la rubrica NUNTII LATINI: www.kurier.at
Ephemeris, settimanale elettronico: www.alcuinus.net/ephemeris
Retiarius, giornale elettronico in lingua latina: www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/retiarius
Vox Latina, un periodico edito dalla Società Latina di Saarbrücken: www.uni-saarland.de/fak5/stockmann/voxlatina
Melissa, rivista della belga Fondazione Melissa: www.melissa.int.ms
La Società ELI di Recanati pubblica due riviste a fumetti, ADULESCENS e IUVENIS: www.elimagazines.com/magazines/latino.htm
Nuntius Leoninus: www.leolatinus.com/Nuntius_lat.html
Lingua:
Grammatica latina: www.biblio-net.com/lett_cla/latina/grammatica.htmUn interessante sito russo sul latino: www.linguaeterna.com
Orbis latinus, un sito sul latino e le lingue romanze: http://www.orbilat.com/
Testi per imparare il latino vivo, pubblicati dall'americana Bolchazy: www.bolchazy.com/index.php?cat=latin&sub=15
Paleografia latina, dal sito della Pontificia Università Gregoriana: www.unigre.it/pubblicazioni/lasala
Impariamo a leggere le iscrizioni: asgle.classics.unc.edu/abbrev/latin/
Ottimo vocabolario latino-tedesco: www.gottwein.de/latine
Letteratura:
Autori antichi: www.thelatinlibrary.comAutori moderni: patriot.net/~lillard/cp/neo
Publio Virgilio Marone: virgil.org (in inglese)
Erasmo da Rotterdam: www.erasmus.org (in olandese)
L'Etica di Spinoza: perso.club-internet.fr/glouise
La Bibbia, in formato PDF: www.latinitas.org/biblia
L’Umanesimo in lingua latina: www.umanesimolatino.net
La raccolta della Bibliotheca Augustana: www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
La Perseus Digital Library contiene una cospicua raccolta di testi classici: http://www.perseus.tufts.edu
Philobyblion: http://philobyblion.com.es/Biblioteca/cat_lat.html
Biblioteca virtuale dell'Università di Birmingham: www.philological.bham.ac.uk/library.html
Altra messe di testi, antichi e moderni, sono contenuti nel sito di Wordtheque: www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=LA&letter=A&source=search&page=1
Poesia latina contemporanea: www.suberic.net/~marc/poesislatina.html
La pagina di Joseph Tusiani, poeta italo-americano quadrilingue (inglese, latino, italiano e pugliese): siba3.unile.it/ctle/tusiani/index.html
Archivio della Latinità Italiana del Medioevo: www.uan.it/alim
Organismi e istituzioni:
L’Academia Latinitati Fovendae ha sede a Roma: academialatina.orgIl sito della Santa Sede non ha una versione latina, contiene comunque numerosi testi in latino (testi sacri, encicliche, etc.): www.vatican.va
Libreria editrice Vaticana: www.libreriaeditricevaticana.com
La Presidenza Finnica dell’Unione Europea pubblica un’agenda in latino: presidency.finland.fi
L’abbazia di Montecassino è anche in versione latina: www.officine.it/montecassino
Associazioni e circoli:
a) virtuali
Grex Latine Loquentium, la mailing-list di chi usa il latino attivamente, fondata nel 1996 da Konrad Kokoszkiewicz, in arte Draco: www.grexlat.com e www.alcuinus.net/GLL/
LatinChat, la comunità virtuale per chattare in latino: groups.yahoo.com/LatinChat-L
Circulus Latinus Portus Alacris: groups.yahoo.com/group/circulus-latinus
Rostra Nova ospita un forum telematico: www.bingo-ev.de/~rw937/rostra
b) reali
Societas Circulorum Latinorum, augustinus.eresmas.net/scl, nata da un'idea di Avitus, come la Schola Latina Universalis: con sede a Londra, si propone di fungere da coordinamento dei vari circoli di latino vivo sparsi per il mondo.
Circulus Latinus Matritensis: augustinus.eresmas.net
Circulus Latinus Barcinonensis: circulus.albinus.org/circulus.htm
Circulus Latinus Gerundensis: girona.latinitatis.com
Circulus Latinus Caesaraugustanus: zaragoza.latinitatis.com
Circulus Latinus Gaditanus: gades.latinitatis.com
Circulus Latinus Safrensis: www.alcuinus.net/zafra
Circulus Latinus Londiniensis: members.lycos.co.uk/avitus2002/CLL.html
Circulus Latinus Lutetiensis: membres.lycos.fr/lutetiensis
Circulus Latinus Perpinianensis: perpignan.latinitatis.com
Sodalitas Latina Mediolanensis: www.filologico.it/sodalitas.htm
Circulus Latinus Bononiensis: www.oocities.org/sodalitaslatina
Circulus Latinus Panormitanus: www.cirlapa.org
Circulus Latinus Bruxellensis, seu Amici Melissae: membres.lycos.fr/melissalatina
Circulus Latinus Vindobonensis: scrivere a joe@grg21.ac.at
Circulus Latinus Zagrabiensis: membres.lycos.fr/latinitas/zagreb/index.htm
Circulus Latinus Varsoviensis: albinus.chez.tiscali.fr/varsovia
Circulus Latinus Seattlensis: ttt.boreoccidentales.org
Circulus Latinus Bogotensis: bogota.latinitatis.com
Circulus Latinus Portus Alacris: www.oocities.org/circuluslatinus
Circulus Latinus Bonaerensis: http://buenos-aires.latinitatis.com/
Sodalitas Ludis Latinis Faciundis: www.klassphil.uni-muenchen.de/%7estroh/sodalitas.html
Societas Latina Lexintoniensis: www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/latcolloq.html
The Later Latin Society of Tasmania: www.informalmusic.com/latinsoc
Il sito del californiano S.A.L.V.I. (Septentrionale Americanum Latinitatis Vivae Institutum): www.latin.org
Il sito della tedesca L.V.P.A.(Latinitatis Vivae Provehendae Associatio): members.surfeu.de/ipg
Progetto Latino Vivo: www.pamparato.com/ima/latino/latino.html
Centrum Latinitatis Europaeum: www.centrumlatinitatis.org
Civiltà romana:
Ius romanum: www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/Pagine personali:
Steinar Midtskogen ha costruito un sito veramente degno di lode: latinitas.orgVittorio Ciarrocchi è senza dubbio il più strenuo difensore della latinità viva; la sua pagina personale: www.pesaro.com/latino, e il suo intervento al X Congresso dell’A.L.F. a Madrid: www.grexlat.com/conventus.rtf
Latinitas Viva, il sito di Stefano Rocca: space.tin.it/scuola/strocc/index.html
Il primo blog in latino: www.livejournal.com/users/beluosus
Novità!
La Passione, il primo film interamente in latino ed aramaico, opera del regista Mel Gibson: www.passion-movie.comContattatemi!
Chi necessitasse di ulteriori informazioni sulla lingua latina, o di traduzioni dal latino in italiano, oppure chi fosse interessato alla conversazione in latino, mi contatti.© Massimiliano Distaso 2002