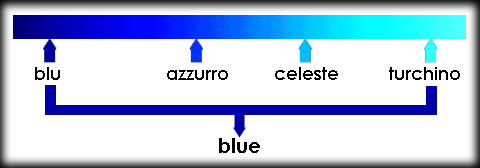Per quanto riguarda il contenuto di questa pagina è d'obbligo una premessa. Essendo l'argomento in questione particolarmente astratto, per non dire
astruso, risulta
inevitabile trattarlo con l'ausilio di esempi. Spetterà poi al
lettore far sue le nozioni teoriche, comunque ben esplicite.
Louis Hjelmslev, come si è detto, puntualizza la "metafora del foglio
di carta" di Saussure (cfr. pagina non
conformità tra espressione e contenuto) e inoltre rompe con l'antica
dicotomia che vedeva la forma contrapposta al contenuto affermando che lo stesso
contenuto ha delle forme proprie. Ogni lingua è fatta dalle forme, presenti sia
nel
piano dell'espressione che nel piano del contenuto. Al di là delle implicazioni
filosofiche che tutte queste affermazioni potrebbero avere, per comprendere
appieno il discorso è indispensabile far proprio il metalinguaggio (la terminologia)
hjelmsleviano accantonando ogni pregiudizio e le eventuali connotazioni
dei termini chiave: materia, sostanza e forma in particolare. Sentirsi dire che ciò che conta è la forma può
facilmente portare ad accuse di formalismo, spesso causa di non pochi conflitti!
E i pionieri della semiotica ne sanno qualcosa.
Innanzi tutto si prenda in esame il piano dell'espressione. Quali sono gli
elementi che fanno sì che una lingua sia differente da un'altra?  La
risposta sta nelle prime pagine di un discreto dizionario
bilingue dove solitamente si trova la presentazione dei simboli in trascrizione fonetica.
Questi, nella maggior parte dei casi, sono suddivisi per vocali, consonanti, semiconsonanti e
dittonghi. La trascrizione fonetica si avvale di un particolare alfabeto che
associa ad ogni suono linguistico un particolare segno (alcuni dei quali
coincidono con l'alfabeto classico). Nella
figura qui a sinistra sono riprodotti i suoni vocalici italiani e francesi
presenti nel Robert
Signorelli. Ora, pur non essendo dei linguisti e non conoscendo quel
particolare alfabeto, si può facilmente rilevare che il francese presenta ben 16
vocali toniche diverse, mentre l'italiano "solo" 7 (anche se la
distinzione tra la O e la E grave e acuta non è molto sentita dai parlanti
del sud). La stessa cosa accade, ovviamente, per le consonanti: la R
"moscia" francese è famosissima, e, parlando di altre lingue, chiunque abbia avuto a che fare con la pronuncia
inglese o spagnola, avrà
certamente riscontrato alcune difficoltà nell'emissione dei cosiddetti suoni "interdentali",
per la cui produzione la lingua viene appunto posta tra gli incisivi (si pensi a
parole come thin, them inglesi). Tali suoni sono totalmente assenti nella lingua
italiana (o comunque non sono significativi anche negli individui che presentano
difetti di pronuncia). I gruppi di suoni propri di una lingua (che troviamo nelle prime
pagine dei dizionari bilingue) rappresentano le forme dell'espressione di quel
linguaggio. Tutti i suoni producibili
dall'apparato fonatorio, invece, fanno parte di quello che Hjelmslev chiama materia
dell'espressione. In altri termini, l'apparato fonatorio della specie umana
è uguale in tutti gli individui, e potenzialmente consente di produrre i suoni
di tutte le lingue del mondo. Da questo ventaglio di possibilità (materia
dell'espressione) ogni lingua ritaglia i suoi suoni significativi (forme
dell'espressione), i quali sono stati codificati dai linguisti e ci vengono
presentati nei dizionari. Come si fa a capire se un suono è significativo?
Attraverso le prove di commutazione: se in una parola, ad esempio /tane/,
si opera una commutazione di un suono nella stessa posizione (fonema), /rane/,
e il significato cambia, allora si dice che
si è dinanzi ad una pertinenza (nel caso specifico il fonema /r/ è distinto da
/t/). Una non pertinenza potrebbe essere data in italiano dalla parola zio
pronunciata con la zeta "dura" o "dolce". I suoni sono
diversi ma il significato non cambia. Il senso, quindi, si dà per differenza: non si
può parlare emettendo sempre lo stesso suono, sono le differenze tra i suoni a
darci i significanti. Ecco perché quando si ascolta una "seconda
lingua" (non madre lingua) si ha spesso necessità di un volume sostenuto e
un ritmo non troppo rapido: in questo modo si riesce meglio a cogliere le
differenze (forme). Ultima considerazione riguarda il numero degli elementi
formali in confronto a quelli sostanziali, che sono praticamente infiniti. I
suoni di una lingua come l'italiano sono circa una trentina... ma quante parole
possiamo dire con quei suoni? Come dire che le note sono sette, ma quante
canzoni possibili esistono? Per inciso, tutte queste osservazioni (differenza
condizione come necessaria per costruire il senso, rapporto pochi elementi
formali/molti elementi sostanziali), come dimostrerà Greimas, valgono non solo
per il lato dell'espressione, ma (sorprendentemente, e qui sta la semiotica)
anche per il piano del contenuto!
La
risposta sta nelle prime pagine di un discreto dizionario
bilingue dove solitamente si trova la presentazione dei simboli in trascrizione fonetica.
Questi, nella maggior parte dei casi, sono suddivisi per vocali, consonanti, semiconsonanti e
dittonghi. La trascrizione fonetica si avvale di un particolare alfabeto che
associa ad ogni suono linguistico un particolare segno (alcuni dei quali
coincidono con l'alfabeto classico). Nella
figura qui a sinistra sono riprodotti i suoni vocalici italiani e francesi
presenti nel Robert
Signorelli. Ora, pur non essendo dei linguisti e non conoscendo quel
particolare alfabeto, si può facilmente rilevare che il francese presenta ben 16
vocali toniche diverse, mentre l'italiano "solo" 7 (anche se la
distinzione tra la O e la E grave e acuta non è molto sentita dai parlanti
del sud). La stessa cosa accade, ovviamente, per le consonanti: la R
"moscia" francese è famosissima, e, parlando di altre lingue, chiunque abbia avuto a che fare con la pronuncia
inglese o spagnola, avrà
certamente riscontrato alcune difficoltà nell'emissione dei cosiddetti suoni "interdentali",
per la cui produzione la lingua viene appunto posta tra gli incisivi (si pensi a
parole come thin, them inglesi). Tali suoni sono totalmente assenti nella lingua
italiana (o comunque non sono significativi anche negli individui che presentano
difetti di pronuncia). I gruppi di suoni propri di una lingua (che troviamo nelle prime
pagine dei dizionari bilingue) rappresentano le forme dell'espressione di quel
linguaggio. Tutti i suoni producibili
dall'apparato fonatorio, invece, fanno parte di quello che Hjelmslev chiama materia
dell'espressione. In altri termini, l'apparato fonatorio della specie umana
è uguale in tutti gli individui, e potenzialmente consente di produrre i suoni
di tutte le lingue del mondo. Da questo ventaglio di possibilità (materia
dell'espressione) ogni lingua ritaglia i suoi suoni significativi (forme
dell'espressione), i quali sono stati codificati dai linguisti e ci vengono
presentati nei dizionari. Come si fa a capire se un suono è significativo?
Attraverso le prove di commutazione: se in una parola, ad esempio /tane/,
si opera una commutazione di un suono nella stessa posizione (fonema), /rane/,
e il significato cambia, allora si dice che
si è dinanzi ad una pertinenza (nel caso specifico il fonema /r/ è distinto da
/t/). Una non pertinenza potrebbe essere data in italiano dalla parola zio
pronunciata con la zeta "dura" o "dolce". I suoni sono
diversi ma il significato non cambia. Il senso, quindi, si dà per differenza: non si
può parlare emettendo sempre lo stesso suono, sono le differenze tra i suoni a
darci i significanti. Ecco perché quando si ascolta una "seconda
lingua" (non madre lingua) si ha spesso necessità di un volume sostenuto e
un ritmo non troppo rapido: in questo modo si riesce meglio a cogliere le
differenze (forme). Ultima considerazione riguarda il numero degli elementi
formali in confronto a quelli sostanziali, che sono praticamente infiniti. I
suoni di una lingua come l'italiano sono circa una trentina... ma quante parole
possiamo dire con quei suoni? Come dire che le note sono sette, ma quante
canzoni possibili esistono? Per inciso, tutte queste osservazioni (differenza
condizione come necessaria per costruire il senso, rapporto pochi elementi
formali/molti elementi sostanziali), come dimostrerà Greimas, valgono non solo
per il lato dell'espressione, ma (sorprendentemente, e qui sta la semiotica)
anche per il piano del contenuto!
Un ulteriore esempio sarà chiarificatore: se qualcuno ci
chiede quali siano le vocali italiane, rispondiamo con sicurezza "a, e, i,
o, u". Ma se si pronunciano questi stessi suoni in un continuum, senza
alcun distacco, è intuitivo capire che, ad esempio, tra la A e la E vi è tutta
una scena intermedia, la quale se non ha significato, o meglio, se non è
pertinente in italiano, potrebbe esserlo in un altra lingua! Stessa cosa se disponiamo le nostre labbra in modo da
pronunciare una A ed emettiamo il suono tipico della O con la lingua in
posizione bassa e centrale. Tutto il continuum che va dalla A alla U rappresenta
la materia dell'espressione, che viene ritagliata dalla lingua italiana in 7
forme distinte, dal francese in 16. Cosa è allora la sostanza? La sostanza può
intendersi come il risultato di quest'opera di ritaglio della materia. Con una metafora, la materia è come la sabbia, che
senza un contenitore non ha alcuna forma. Le due lingue, usano, per creare
determinate sostanze, delle "formine" diverse per fare degli oggetti
con la sabbia a disposizione! Il risultato dell'applicazione
della forma sulla materia dà la sostanza. Un po' come se la forma fosse la
langue dell'espressione (difatti è definita nelle sue caratteristiche come formale), mentre la sostanza
rappresenterebbe la parole (sostanziale, appunto), sempre del piano
dell'espressione. La cosa interessante è che la forma è un'entità ricostruita
ex post dalle sostanze, che sono fisicamente analizzabili! La forma è
totalmente astratta e concettuale, ma tutte le sostanze derivano da essa.
Veniamo adesso al contenuto. L'intuizione geniale di Hjelmslev è che anche il contenuto
possiede una sua forma (e quindi anche una sua materia e sostanza). Tale conclusione è
strettamente legata a quella di valore
linguistico. Si analizzi una traduzione: se si cerca in un dizionario inglese-italiano la parola blue, il primo significato identificherà
tre o quattro colori "italiani": blu, azzurro, turchese e celeste. Ma
i colori non dovrebbero essere uguali per tutti gli uomini del mondo? I nostri
occhi non funzionano forse allo stesso modo in tutti gli individui, a prescindere dalla lingua che
parliamo? Evidentemente il discorso non è così semplice,
tant'è che gli inglesi hanno una sola parola per quattro sfumature di blu
italiane (certo gli inglesi non sono tutti stupidi, e possono avvalersi di
alcuni aggettivi per specificare meglio la tonalità, come deep per scuro
o light per chiaro). Le due lingue, quindi, avendo a disposizione lo stesso spettro di
colori, lo ritagliano in maniera totalmente diversa, graficamente:
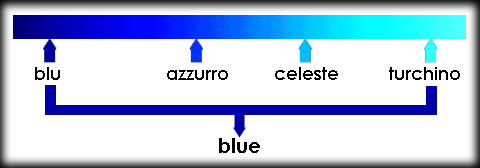
Il continuum che va dal blu al turchino è la materia del contenuto in
comune alle due lingue, che lo ritagliano in maniera diversa.
L'italiano conosce quattro sfumature, l'inglese soltanto una. Inutile dire che
sarebbe stupido pensare che per queste ragioni l'italiano sia una lingua più
bella o più furba dell'inglese.
La cosa, comunque, non si ferma qui! Tutto quanto detto
avviene infatti ad ogni livello della lingua. Pensiamo ai verbi, ad esempio, e
traduciamo la frase italiana "Mi piaci" con "I like you".
Cosa hanno in comune queste frasi? Il significato? Non
esattamente. Il verbo italiano piacere è intransitivo, tant'è che diciamo
"Tu piaci a me". In inglese, lo stesso verbo (la sua traduzione) è
transitiva, infatti l'azione passa da "I" soggetto a "you"
complemento oggetto. Le due frasi hanno in comune il senso, cioè la materia
del contenuto, che viene ritagliata in forme diverse nei due idiomi:
transitivamente dall'inglese e intransitivamente dall'italiano. Questa
operazione di ritaglio dà come risultato due sostanze ben diverse e proprio per
questa ragione non esiste davvero una perfetta traduzione! Le lingue quindi, non
sono arbitrarie solo per quanto riguarda la relazione che lega l'espressione al
contenuto (significanti a significati) ma anche nel rapporto che c'è tra le
forme e le sostanze.
Il risultato di tutto questo ragionamento è che, a fare una lingua, non sono
le sostanze, tanto meno i significati. La lingua è la presupposizione reciproca
tra forma dell'espressione e forma del contenuto. Con il termine lingua qui
s'intende qualsiasi forma espressiva (musica, immagini, balletti).
Graficamente:

La lingua sta tutta nelle forme. La materia fa parte del mondo ed è esterna
alla lingua, mentre le sostanze sono i risultati dell'uso della lingua.
Considerando il piano dell'espressione, le forme sono indagate dalla
fonologia, e sono riconducibili alle immagini acustiche di cui parlava Saussure,
alle quali possiamo risalire attraverso svariate sostanze, una lingua cioè può
essere sia scritta che parlata che gesticolata (cfr pagina sullo strutturalismo).
La fonetica si preoccupa di studiare quella particolare sostanza espressiva che
è il suono (i suoni) di una lingua. Il
contenuto invece riguarda la semantica. Cosa hanno quindi in comune due lingue? La materia,
sia dell'espressione che del contenuto. Ma una lingua può parlare di tantissime
cose, da quella particolare forma espressiva possono derivare tante sostanze del contenuto. In più, una forma del contenuto, ad
esempio il racconto, può essere tradotto in tantissime lingue del mondo o altre
forme dell'espressione:
fumetti, quadri, balletti, fiabe. Tra pochissimo sarà più semplice capire di
cosa si occupa esattamente la semiotica e quale sia la sua scommessa.
Ora è interessante giocare un po' con questa quadripartizione (espressione
vs contenuto; forma vs sostanza). Si consideri una certa notizia di cronaca. Questa può assumere tante forme
e sostanze dell'espressione (televideo, telegiornali, stampa, radio, internet,
notizie ANSA)
raccontando però sempre la stessa storia, che è quindi la materia del
contenuto, più o meno allo stesso modo, cioè nella stessa forma del
contenuto (cronaca giornalistica). La scommessa sta tutta qui: il campo di indagine della
semiotica è la ricerca delle invarianze delle forme del contenuto,
tralasciando la variabilità delle sostanze dell'espressione. In altre
parole, tutte le forme che la notizia può assumere, non sono altro che delle
traduzioni, delle conversioni di forme espressive in altre aventi in comune lo
stesso senso, la cui struttura e la sua articolazione è studiato e focalizzato
dalla semiotica. Le stesse trasposizioni di romanzi
in opere cinematografiche o in opere teatrali possono esser viste come
"traduzioni", alla luce di quanto detto.
Un ultima riflessione riguarda infine alcuni metodi della ricerca sociale
come la content analysis e tutti i suoi derivati. Molto spesso accade che
presunte ricerche qualitative vantino risultati mirati riguardo, ad esempio, i
contenuti trasmessi dai mass-media. In Italia, esiste l'osservatorio di Pavia,
che si preoccupa, tra le altre cose, di monitorare la presenza dei politici in
TV. Ma prende in considerazione esclusivamente le sostanze espressive non
occupandosi del contenuto! Come se non bastasse i due piani presentano forme
diverse. Dire che il politico X è stato tot tempo in onda non dimostra
assolutamente nulla, perché non si sta considerando in che termini se ne parla.
Meno che mai conta, ad esempio, cercare in un giornale, il numero delle volte in
cui un particolare nome affiora negli articoli: si può parlare di qualcuno
senza mai nominarlo, e se ne può parlare sia in termini positivi che negativi.
Senza considerare che in un giornale non si utilizza esclusivamente la forma
espressiva del linguaggio verbale, ma vi sono anche le immagini, e molti effetti
di senso sono realizzati attraverso ciò che non viene esplicitamente detto...
 La
risposta sta nelle prime pagine di un discreto dizionario
bilingue dove solitamente si trova la presentazione dei simboli in trascrizione fonetica.
Questi, nella maggior parte dei casi, sono suddivisi per vocali, consonanti, semiconsonanti e
dittonghi. La trascrizione fonetica si avvale di un particolare alfabeto che
associa ad ogni suono linguistico un particolare segno (alcuni dei quali
coincidono con l'alfabeto classico). Nella
figura qui a sinistra sono riprodotti i suoni vocalici italiani e francesi
presenti nel Robert
Signorelli. Ora, pur non essendo dei linguisti e non conoscendo quel
particolare alfabeto, si può facilmente rilevare che il francese presenta ben 16
vocali toniche diverse, mentre l'italiano "solo" 7 (anche se la
distinzione tra la O e la E grave e acuta non è molto sentita dai parlanti
del sud). La stessa cosa accade, ovviamente, per le consonanti: la R
"moscia" francese è famosissima, e, parlando di altre lingue, chiunque abbia avuto a che fare con la pronuncia
inglese o spagnola, avrà
certamente riscontrato alcune difficoltà nell'emissione dei cosiddetti suoni "interdentali",
per la cui produzione la lingua viene appunto posta tra gli incisivi (si pensi a
parole come thin, them inglesi). Tali suoni sono totalmente assenti nella lingua
italiana (o comunque non sono significativi anche negli individui che presentano
difetti di pronuncia). I gruppi di suoni propri di una lingua (che troviamo nelle prime
pagine dei dizionari bilingue) rappresentano le forme dell'espressione di quel
linguaggio. Tutti i suoni producibili
dall'apparato fonatorio, invece, fanno parte di quello che Hjelmslev chiama materia
dell'espressione. In altri termini, l'apparato fonatorio della specie umana
è uguale in tutti gli individui, e potenzialmente consente di produrre i suoni
di tutte le lingue del mondo. Da questo ventaglio di possibilità (materia
dell'espressione) ogni lingua ritaglia i suoi suoni significativi (forme
dell'espressione), i quali sono stati codificati dai linguisti e ci vengono
presentati nei dizionari. Come si fa a capire se un suono è significativo?
Attraverso le prove di commutazione: se in una parola, ad esempio /tane/,
si opera una commutazione di un suono nella stessa posizione (fonema), /rane/,
e il significato cambia, allora si dice che
si è dinanzi ad una pertinenza (nel caso specifico il fonema /r/ è distinto da
/t/). Una non pertinenza potrebbe essere data in italiano dalla parola zio
pronunciata con la zeta "dura" o "dolce". I suoni sono
diversi ma il significato non cambia. Il senso, quindi, si dà per differenza: non si
può parlare emettendo sempre lo stesso suono, sono le differenze tra i suoni a
darci i significanti. Ecco perché quando si ascolta una "seconda
lingua" (non madre lingua) si ha spesso necessità di un volume sostenuto e
un ritmo non troppo rapido: in questo modo si riesce meglio a cogliere le
differenze (forme). Ultima considerazione riguarda il numero degli elementi
formali in confronto a quelli sostanziali, che sono praticamente infiniti. I
suoni di una lingua come l'italiano sono circa una trentina... ma quante parole
possiamo dire con quei suoni? Come dire che le note sono sette, ma quante
canzoni possibili esistono? Per inciso, tutte queste osservazioni (differenza
condizione come necessaria per costruire il senso, rapporto pochi elementi
formali/molti elementi sostanziali), come dimostrerà Greimas, valgono non solo
per il lato dell'espressione, ma (sorprendentemente, e qui sta la semiotica)
anche per il piano del contenuto!
La
risposta sta nelle prime pagine di un discreto dizionario
bilingue dove solitamente si trova la presentazione dei simboli in trascrizione fonetica.
Questi, nella maggior parte dei casi, sono suddivisi per vocali, consonanti, semiconsonanti e
dittonghi. La trascrizione fonetica si avvale di un particolare alfabeto che
associa ad ogni suono linguistico un particolare segno (alcuni dei quali
coincidono con l'alfabeto classico). Nella
figura qui a sinistra sono riprodotti i suoni vocalici italiani e francesi
presenti nel Robert
Signorelli. Ora, pur non essendo dei linguisti e non conoscendo quel
particolare alfabeto, si può facilmente rilevare che il francese presenta ben 16
vocali toniche diverse, mentre l'italiano "solo" 7 (anche se la
distinzione tra la O e la E grave e acuta non è molto sentita dai parlanti
del sud). La stessa cosa accade, ovviamente, per le consonanti: la R
"moscia" francese è famosissima, e, parlando di altre lingue, chiunque abbia avuto a che fare con la pronuncia
inglese o spagnola, avrà
certamente riscontrato alcune difficoltà nell'emissione dei cosiddetti suoni "interdentali",
per la cui produzione la lingua viene appunto posta tra gli incisivi (si pensi a
parole come thin, them inglesi). Tali suoni sono totalmente assenti nella lingua
italiana (o comunque non sono significativi anche negli individui che presentano
difetti di pronuncia). I gruppi di suoni propri di una lingua (che troviamo nelle prime
pagine dei dizionari bilingue) rappresentano le forme dell'espressione di quel
linguaggio. Tutti i suoni producibili
dall'apparato fonatorio, invece, fanno parte di quello che Hjelmslev chiama materia
dell'espressione. In altri termini, l'apparato fonatorio della specie umana
è uguale in tutti gli individui, e potenzialmente consente di produrre i suoni
di tutte le lingue del mondo. Da questo ventaglio di possibilità (materia
dell'espressione) ogni lingua ritaglia i suoi suoni significativi (forme
dell'espressione), i quali sono stati codificati dai linguisti e ci vengono
presentati nei dizionari. Come si fa a capire se un suono è significativo?
Attraverso le prove di commutazione: se in una parola, ad esempio /tane/,
si opera una commutazione di un suono nella stessa posizione (fonema), /rane/,
e il significato cambia, allora si dice che
si è dinanzi ad una pertinenza (nel caso specifico il fonema /r/ è distinto da
/t/). Una non pertinenza potrebbe essere data in italiano dalla parola zio
pronunciata con la zeta "dura" o "dolce". I suoni sono
diversi ma il significato non cambia. Il senso, quindi, si dà per differenza: non si
può parlare emettendo sempre lo stesso suono, sono le differenze tra i suoni a
darci i significanti. Ecco perché quando si ascolta una "seconda
lingua" (non madre lingua) si ha spesso necessità di un volume sostenuto e
un ritmo non troppo rapido: in questo modo si riesce meglio a cogliere le
differenze (forme). Ultima considerazione riguarda il numero degli elementi
formali in confronto a quelli sostanziali, che sono praticamente infiniti. I
suoni di una lingua come l'italiano sono circa una trentina... ma quante parole
possiamo dire con quei suoni? Come dire che le note sono sette, ma quante
canzoni possibili esistono? Per inciso, tutte queste osservazioni (differenza
condizione come necessaria per costruire il senso, rapporto pochi elementi
formali/molti elementi sostanziali), come dimostrerà Greimas, valgono non solo
per il lato dell'espressione, ma (sorprendentemente, e qui sta la semiotica)
anche per il piano del contenuto!