 Africa:
l’informazione negata
Africa:
l’informazione negataAncora riflessioni sull’Africa, in occasione della festa di S. Massimiliano
Per la ricorrenza di S. Massimiliano, patrono degli
obiettori di coscienza, abbiamo proposto quest’anno una riflessione sull’informazione,
sulle notizie relative al Sud del Mondo e in particolare all’Africa, inserendo
così il nostro appuntamento annuale nelle iniziative che hanno caratterizzato
“Chiama l’Africa” a Fidenza.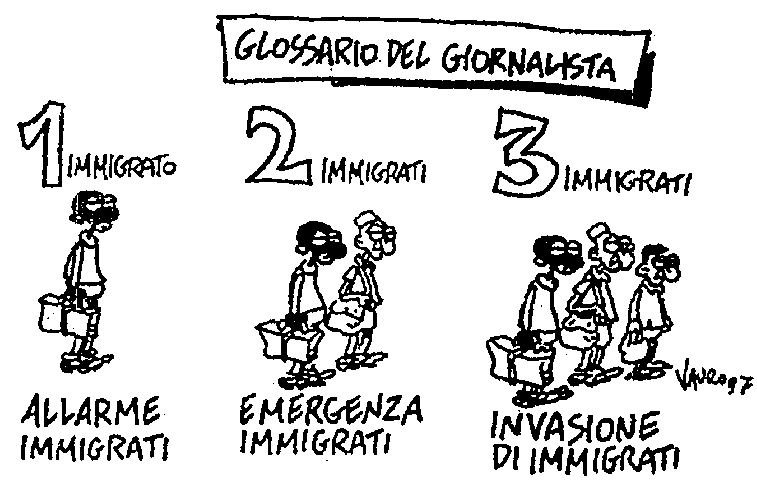
Il 16 marzo presso la parrocchia di S. Giuseppe, Aluisi Tosolini (giornalista
della rivista “Alfazeta”), ha guidato i partecipanti della serata a scoprire
la cosiddetta informazione “negata”, o meglio “annegata”, che caratterizza
il rapporto tra stampa e sud del mondo.
Attraverso eloquenti diapositive, e soprattutto grazie alla esperienza
vissute in prima persona dal relatore, Tosolini ci ha introdotti ad un
argomento difficile ma molto interessante ed affascinante, e cioè
le logiche sottostanti il funzionamento dei media.
Innanzitutto l’informazione ‘annegata’, cioè abbondante, che
stordisce il lettore comune e rimane illeggibile, mescolando notizie importanti
con inutili e fuorvianti “rumori di fondo”.
Poi, due fondamentali filoni di ricerca per capirne di più:
chi sono gli editori, i padroni dell’informazione? Cosa attira di più
l’attenzione del pubblico? (risposta sconsolata: soldi, sesso, sangue,
spettacolarizzazione).
Oggi sappiamo tutto senza conoscere niente. Ritoccare, scontornare,
tagliare, cancellare sono le tecniche usate dai media per ‘ridefinire’
la realtà. Ormai anche il ruolo e il modo di lavorare del giornalista
è mutato col passare del tempo: non deve più cercare le notizie
ma sceglierle fra milioni, renderle accessibili al pubblico, ricostruirle,
fornire una interpretazione.
I MASS MEDIA E “L’ALTRO”:
SETTE TIPI DI DEFORMAZIONE
Da “Missione Oggi” / marzo 95
1 L’uso superficiale o spregiudicato di statistiche solo apparentemente attendibili, in realtà frutto di indagini o di sondaggi molto approssimativi. Il ricorso al linguaggio delle “cifre” aumenta la dose di rigore e di scientificità, ma accade spesso che questi dati statistici sono “costruiti” a tavolino e magari su un campione ridottissimo. Poi si presentano sotto forma di tabelle e diagrammi, dando ad essi un grado di rappresentatività e di generalizzazione che assolutamente non meritano. A quel punto il linguaggio matematico dei numeri diventa la fonte di grave deformazione, perché il lettore inesperto finisce per assumerla come un’informazione scientifica.
2 Un altro errore è il primato assegnato alla tragedia nella selezione delle informazioni. È la ragione per cui si parla di Africa quando il tasso di drammaticità è così elevato da oltrepassare la soglia del silenzio: ecco allora la Somalia, il Rwanda; ecco, per il Medio Oriente, la guerra del Golfo; ecco, per l’America latina, i ragazzi di strada in Brasile o la rivolta degli indios nel Chiapas, perché non dare anche notizie “positive” di avanzamento, di liberazione, di successo?
3 Ancora un errore è la “spettacolariz-zazione” e l’esotismo di tante situazioni dei paesi del Sud (ma non solo). Il dato è così evidente che sembra inutile fare esempi.
4 Inoltre, un errore tra i più diffusi è la tendenza alla “iper-semplificazione” che in parte è tuttavia inevitabile. Mettere tutto il mondo, con tutte le sue sfumature, in due cassetti (Nord e Sud) è nello stesso tempo una verità e una menzogna. Si dovrebbe aver cura a fare distinzioni: il Sud o i Sud del mondo? L’Africa o le Afriche? L’Asia o quel determinato paese e, talvolta, una certa parte di quel paese?
5 Ancora un errore è quello di presentare gli avvenimenti come se fossero “fatti del giorno”, mentre spesso hanno una lunghissima fase di incubazione. Ci vuole, allora, una maggiore cura per la ricostruzione storica e genealogica dei conflitti e delle emergenze mettendo in risalto le cause endogene, le cause esogene e le interdipendenze tra di esse.
6 Infine, un errore è quello di utilizzare come immagini di repertorio (di scenario, di “sfondo” abituale) i più triti stereotipi e luoghi comuni, quelli appunto che nell’immaginario comune evocano un certo paese o continente. Se dell’Africa ci faranno vedere solo foreste, savana e capanne, ogni volta che noi vedremo uno che viene dall’Africa saremo portati a pensare che viene da una civiltà illetterata, rurale, nomade, non tecnologica, ecc. In altri termini, parleremo o discuteremo dell’Africa o dell’Asia secondo gli stereotipi che i media ci hanno fornito. Al massimo, dubiteremo di quello che ci viene riferito se sappiamo che la fonte di informazione non è attendibile.
7 Così pure, nella pubblicità, l’uomo
e la donna “di colore” si trasformano di volta in volta nell’insaziabile
amante africana, nel simpatico buffone di Tartufon, nella seduzione scontata
della Morosita, negli improbabili ridenti raccoglitori di caffè
del Kimbo: tutto viene mistificato in una frivola rappresentazione. Non
c’è, allora, da meravigliarsi se la ragazza Morosita è entrata
nell’immaginario erotico degli italiani, com’è risultato da un’inchiesta.
Esiste una corrispondenza tra le immagini prevalenti nei media e gli stereotipi
alla base della percezione dei paesi in via di sviluppo presso il pubblico,
quasi un incontro tra messaggi trasmessi e aspettative radicate nell’immaginario
di chi li riceve.