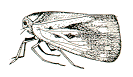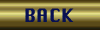La metacalfa - Una farfallina venuta dall'America

Lo spettacolo si replica in Italia ormai da venti anni, ma ora è talmente esteso che anche il passante più distratto deve averlo notato. D'estate la vegetazione urbana e rurale si copre qua e là di una pruina nivea e di fiocchetti altrettanto candidi.
Chi, per capirne di più, va a curiosare tra le fronde ha la sorpresa di vedere i piccoli fiocchi animarsi e saltare come grilli, mentre strani insetti grigiastri, lunghi al massimo otto millimetri, si alzano in brevi voli, impauriti per l'intrusione. Dalle alberature stradali poi piovono goccioline collose, visibili sull'asfalto e sulle automobili in sosta. L'assalto coinvolge un numero illimitato di specie botaniche e di colture; ciò ne ha favorito la diffusione progressiva in quasi tutto il territorio nazionale e nei più diversi tipi di ambienti.
Protagonista di questa storia è Metcalfa pruinosa, un insetto americano somigliante alle cicaline, destinato ad essere fin troppo conosciuto, anche da noi, per il suo pullulare dappertutto e per il fastidio e i guasti che può produrre. La scoperta della sua esistenza nel nostro Paese risale al 1979, quando se ne avvistarono numerosi esemplari in provincia di Treviso.
La notizia ufficiale fu data al mondo scientifico da Sergio Zangheri e Paolo Donadini (Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Padova). Già durante il primo biennio di ricerche l'infestazione interessava nel Trevigiano più di 40 specie vegetali, da quelle erbacce alle arboree, che però non presentano particolari segni di sofferenza.
L'arrivo del nuovo ospite si spiega facilmente: l'aumentata velocità dei mezzi di trasporto e l'incremento degli scambi commerciali tra un continente e l'altro hanno consentito negli ultimi cinquant'anni l'ingresso accidentale in Italia di almeno 120 specie di insetti esotici.
Come le cicale, Metcalfa è un emittero omottero, ma appartiene a una famiglia diversa: quella dei Flatidi. Gli adulti hanno ali a forma di trapezio, disposte a tetto, quasi verticalmente, ai lati del corpo; la livrea immacolata vira presto al grigio con screziature più chiare formate da pruina cerosa. Una cospicua secrezione di cera protegge e maschera le forme giovanili, incapaci di volare, ma atte al salto.
Con l'apparato boccale pungente l'insetto trafigge le parti più tenere delle piante per succhiarne gli umori che contengono acqua e zuccheri in eccesso rispetto alle sue necessità alimentari; così deve eliminare dall'intestino quanto non gli serve, sotto forma di "melata": un liquido appiccicoso e dolciastro, ricco di carboidrati. Ecco l'origine della patina viscosa che sporca le foglie, inglobando particelle di smog, e delle gocce cadute al suolo. Il liquido superfluo emesso dalle metcalfe costituisce per altri insetti una notevole fonte di nutrimento: bombi, vespe, mosche e tanti abituali consumatori di nettare vi si precipitano sopra, ed è allora una grande abbuffata!Se scoprono che possono bottinare con minor fatica, anche le api più laboriose smettono di visitare i fiori e si danno convegno sugli alberi della cuccagna. Il loro miele acquisterà un sapore particolare che sembra avere già i suoi estimatori; ma alcuni esperti giudicano questo un danno, non un vantaggio.
Inoltre la melata, come quella dei vari omotteri (afidi, per esempio) è ottimo terreno di coltura per minuscoli funghi i cui filamenti vegetativi (ife) formano sulle piante una crosta fuligginosa nociva, conosciuta col nome di "fumaggine". Gli amori delle metcalfe sono favoriti dal calar delle tenebre, e anche la funzione materna si svolge di notte. All'inizio dell'autunno, prima che l'unica generazione annuale soccomba per vecchiaia o per mutate condizioni meteorologiche,le femmine fecondate introducono l'ovopositore nelle screpolature delle cortecce e vi nascondono le uova, lunghe meno di un millimetro. Le schiuse saranno scaglionate gradualmente, al ritorno della stagione calda.
La presenza del nuovo emittero non è un flagello biblico, ma la sua abbondante diffusione preoccupa i coltivatori perché in certi casi può provocare deperimento dei germogli, caduta di foglie, perdita di frutti. L'uso di insetticidi drastici è inopportuno, data l'ubiquitarietà del nemico da combattere; e poi ne risulterebbe una strage di api e di altri pronubi, accorsi a raccogliere la melata. Perciò si preferiscono lavaggi con soluzioni di sali di potassio.
Nella patria naturale Metcalfa Pruinosa risulta innocua: infatti il suo incremento demografico è contrastato da antagonisti specifici; tra questi uno dei più attivi è l'imenottero drinide Neodryinus typhlocybae, inesorabile giustiziere di metcalfe che rappresentano il suo cibo quotidiano.
La femmina rassomiglia a una vespa, ma ha il primo paio di zampe armato di grandi pinze che le permettono di afferrare la vittima per divorarla subito o per deporre un uovo sul suo torace; nel secondo caso sarà la larva dell'imenottero a incistarsi nel corpo dell'ospite per svuotarlo dall'interno. Insomma questo nostro alleato ha un duplice importantissimo ruolo: da adulto preda le forme più giovani del flatide, mentre allo stato larvale ne parassitizza gli stadi di sviluppo successivi alla seconda muta.
Nel 1994 Vincenzo Girolami e Paolo Camporese (Università di Padova) sono riusciti a moltiplicare, anche nell'ambiente esterno, il prezioso imenottero, espressamente importato dall'America.
Questo passo fondamentale ha aperto la via a successive sperimentazioni da parte dei ricercatori del "Biolab" di Cesena, il laboratorio pilota, specializzato nell'allevamento di organismi utili, che ha preceduto l'istituzione della prima "fabbrica" italiana di insetti ausiliari.
Così nella primavera 1995 Maria Grazia Tommasini, con un'agguerrita équipe dello stesso laboratorio, ha cominciato a liberare, a scaglioni, alcune centinaia di drinidi in un parco pubblico del comune di Riccione (Rimini), su macchie e siepi di pittospori infestati dagli omotteri.
Ora in quel comprensorio Neodryinus è perfettamente acclimatato, la sua popolazione è in aumento e dimostra la capacità di diffondersi nelle aree circostanti, mantenendo sotto controllo le metcalfe: un esemplare ritorno alla lotta biologica tradizionale.
L'articolo è tratto da "La Stampa" Tuttoscienze e l'autore è Enrico Stella dell'Università di Roma "La Sapienza"

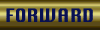
Feste, Appuntamenti
e TradizioniSan Fantino