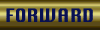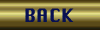Percorso 1
Percorso 2 - Per castelli fino alle ultime balze del Monferrato


Partenza ed arrivo a Portacomaro (circa 90 km, escluse le deviazioni)
Questo giro richiede almeno quattro ore senza fare soste e a velocità ragionevoli.
Anche qui una giornata intera con un paio di soste per un pranzo ed una merenda "sinoria" sono il minimo indispensabile.
Ricordate sempre che ogni paese ha qualcosa da mostrare al viaggiatore consapevole e non frettoloso.
Da Portacomaro andiamo verso Scurzolengo ma dopo meno di 800 metri prendiamo la salita di Mongaribatto sulla sinistra.
Alla chiesetta di San Fantino giriamo a destra e scendiamo alla Bodina.
Al fondovalle giriamo a destra e appena inizia la salita che porta a San Desiderio prendiamo la stradina a sinistra che ci porta alla frazione
Montarsone e attraverso un bellissimo percorso in mezzo a campi e vigne arriviamo sulla strada che porta a Calliano.
Da Calliano ci dirigiamo a Moncalvo, la più piccola città d'Italia, che merita una visita della parte storica.
Da Moncalvo riprendiamo la strada in direzione Casale.
Quasi appena scesi da Moncalvo sulla nostra sinistra c'è la deviazione per il Santuario di Crea con il suo Sacro Monte.
Possiamo deviare il percoroso (Il Santuario di Crea c'è anche nel percorso 4) oppure proseguire per Casale.
Dopo un 3/4 chilomentri vedremo alla nostra destra ergersi sul paese l'imponenete complesso gotico del castello di Cereseto, non fatevi ingannare, è un falso dei primi del '900 ma merita comunque una visita.
Da qui ci dirigiamo verso CellaMonte, un paesino con alcuni scorci di tipo umbro toscano, dal parco del quale si ha una vista molto
particolare e ravvicinate di Rosignano arroccato sulla collina di fronte.
Da Rosignano a Ozzano, e poi a San Giorgio Monferrato.
Qui, attraverso Rollini e Quarti, arriviamo a Pontestura.
Siamo sul Po e da qui saliamo sulle ultima balze del Monferrato che scendono quasi a picco
sulla "bassa" e sul Po. Andiamo prima verso Camino, poi continuiamo per Cantavenna e Gabiano. La strada è molto panoramica con scorci sulla pianura e le risaie, su Trino e sulla pianura che sfuma nella foschia
verso l'orizzonte.
Da Gabiano facendo rotta verso Cerrina Monferrato rientriamo tra i colli del Monferrato. Questa è una zona meno intensamente abitata e più boscosa,
Facciamo un tratto di statale della Val Cerrina e poi saliamo ad Odalengo Grande, riscendiamo sulla statale e risaliamo dall'altro lato a Murisengo.
Un'altra discesa sulla statale, prendiamo verso Casale ma solo per svoltare subito a destra per Villa Adeati,poi Zanco, Cardona e Tonco.
Da Tonco scendiamo nella strada dell'altra valle quasi parallela alla Val Cerrina, la Valle Versa.
Ci dirigiamo a destra verso Montiglio/Cocconato, ma giriamo prima a sinistra, all'altezza delle chiesa romanica di San Nazario per recarci a Montechiaro.
Poi prendiamo per Villa San Secondo, Cossombrato e Callianetto e ritorniamo sulla Statate Asti-Casale.
Svoltiamo a sinistra e prendiamo la via del ritorno a Portacomaro.
Luoghi notevoli e soste consigliate.
Calliano
Il toponimo Calliano è un prediale formato dal suffisso –anus unito al gentilizio latino Callius. La primitiva attestazione di tal denominazione, successivamente mai variata nella sostanza, compare per la prima volta nel 792 d.C.
La collocazione geografica di Calliano, sulla dorsale di un colle che sbarra, verso nord, la valle del torrente Versa, fu, sin dall’età romana, strategica per il controllo di due importanti vie di comunicazione: la strada che parte da Asti e raggiunge Pontestura e la “via Marenca”, che attraverso Grana, Montemagno e Viarigi punta alla piana di Marengo.
Nel 1041, per mezzo di un diploma imperiale, Calliano divenne presidio del confine fra il Marchesato di Monferrato e il nascente libero comune di Asti.
Oggi il paese non offre molto ma merita una sosta la chiesa dedicata al Santissimo Nome di Maria fu costruita dal capomastro Martino Donati ma soltanto fra il 1765 e il 1767 la sua pianta di facciata venne portata a termine grazie alla determinante supervisione dell’architetto casalese Francesco Magnocavalli.
Fermarvisi per una visita è un’esperienza consigliabile: al suo interno essa conserva due pregevoli tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (“Madonna del Rosario” e “Crocifissione”), l’altare maggiore settecentesco di Bernardo Antonio Vittone (1768) e un organo di Liborio Grisanti (1753-54) ornato da una tribuna e una monumentale cassa lignea i cui motivi floreali in stile rocaille sono attribuibili a Francesco Accattino di Vignale e Francesco Maria Bonzanigo di Asti.
Prima di uscire dal paese, non è male ricordarsi di dare un’occhiata alla struttura tardocinquecentesca della chiesa confraternita di San Michele Arcangelo
Moncalvo
Una lapide funebre del I secolo d.C. dedicata a Irria, figlia di Salvio testimonia l'origine romana di Moncalvo.
Nel Medioevo fu possesso della Chiesa d'Asti, poi passò sotto il dominio dei marchesi di Monferrato. Nella fortezza, atterrata alla fine dell'Ottocento, ebbero la loro residenza i Paleologi, che fecero di Moncalvo per qualche tempo la capitale del Marchesato. Alla metà del sec. XVI subentrarono i Gonzaga di Mantova.
Terra di frontiera, Moncalvo fu al centro di lunghe e sofferte guerre a cominciare da
quella per la successione in Monferrato (1627-1630), che portò con sé una violentissima
epidemia di peste. Nel 1691 fu occupata dalle truppe imperiali del principe Eugenio
di Savoia. Nel 1704 perse i territori di Penango, Cioccaro e Patro; l'anno successivo
perse anche il cantone di Castellino. A parziale indennizzo, Ferdinando Carlo di
Gonzaga le concesse il titolo di Città, riconfermato nel 1774 dal re Vittorio Amedeo III di Savoia.
Nel 1783 la Parrocchia fù trasportata nella chiesa di San Francesco retta dai Minori Conventuali.
Questa chiesa è una vera pinacoteca, con molte tele di Guglielmo Caccia, detto "il Moncalvo", delle sue figlie e della sua scuola; vi è anche conservato un affresco del Caccia raffigurante San Rocco, proveniente da una cappella campestre. Nella navata sinistra si conserva un bel confessionale scolpito, opera del moncalvese Gabriele Capello, ebanista intagliatore alla Corte sabauda (regni di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele II).
Nella cappella di Sant'Antonio si trova la tomba di Guglielmo Caccia, morto a Moncalvo nel 1625.
Altre opere d'arte degne di rilievo si trovano nelle chiese di Sant'Antonio e della Madonna delle Grazie, quest'ultima ricostruita a metà Settecento su disegno dell'architetto Francesco Ottavio Magnocavallo.
Sede di un'importante comunità israelitica, Moncalvo possedeva anche una sinagoga, ormai ridotta a uso profano: uniche tracce della presenza ebraica sono il quartiere del ghetto e il cimitero degli ebrei, lungo la strada per Grazzano.
Ricordo che una fama particolare Moncalvo la deve al bollito. Qui si può gustare il "vero bollito" alla piemontese.
Un sontuoso piatto di sette diverse carni bollite (la tradizione qui recita "Scaramella, Testina e Muscolo rigorosamente
di castrato, seguiti da Lingua, Coda, Cotechino, Tasca Ripiena) accompagnato dai tre bagnetti (il verde, il rosso ed il giallo).
Crea
Il Sacro Monte è alto 443 metri.
Nel 1980 con legge regionale è stato istituito il "Parco Naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea" comprendente 47 ettari di terreno, prevalentemente boschivo, dei comuni di Serralunga di Crea e Ponzano.
La legge ha riconosciuto il valore culturale del santuario e mira a conservare integro e valorizzare l’ambiente paesaggistico, la chiesa, il convento, le cappelle e tutte le attrezzature recettive e di servizio.
Ammirate il Santuario con la famosa Madonna Nera (ma quante ce ne sono nel mondo di Madonne Nere? Non sarà che una volta le statue non le pulivano mai?)
Eretto sul luogo dell’oratorio attribuito a S. Eusebio, esisteva già all’epoca delle Crociate, com’è testimoniato da reperti di Arte Romanica venuti alla luce recentemente e posizionati nei primi pilastri della navata.
Fu ampliato da Guglielmo VIII Paleologo alla fine del Quattrocento, poi ancora nel 1600 quando fu costruita la facciata, su cui ora campeggia il bel mosaico che rappresenta l’Assunzione di Maria.
L’interno. di stile gotico, è a tre navate con volte a crociera rialzata e costoloni rotondi, sostenute da pilastri.
Personalmente segnalo il "lardo di colonnata" sapientemente aromatizzato che i frati producono personalmente con l'uso di antichi sarcofaghi romani in marmo secondo la più tradizionale ricetta.
Purtroppo non so indicarvi dove acquistarlo... il ristorante dove lo potete gustare potrebba magari darvi un indizio.
Molto freschi i boschi che ricoprono il colle, un rifugio molto usato dai Monferrini quando la calura opprime la pianura e arrivano torme di "pellegrini" con capienti cesti per la merenda.
Questo spiega il numerosi tavoli da pic nic e le aree di ristoro scaglionate lungo il percorso.
Le cappelle lungo i sentieri che salgono alla cima del colle (che in origine dovevano essere 15), divennero nel progetto 40 e attualmente sono 23, più 5 romitori. Si tratta di un complesso di grande valore artistico e religioso, la cui costruzione ebbe inizio nel 1590.
Statue e pitture sono opera di vari artisti, tra cui si distinguono lo scultore fiammingo Jean de Wespin detto il Tabachetti e il pittore Guglielmo Caccia detto il Moncalvo.
Particolarmente suggestive le cappelle della "salita al Calvario", opera originale e di forte ispirazione dello scultore casalese Leonardo Bistolfi; della Crocefissione, opera del fecondo Antonio Brilla;
dell’Incoronazione di Maria o del Paradiso, edificata sulla vetta del monte,
in splendida posizione panoramica, notevole per il grande gruppo plastico formato da 175 angeli, sospeso al soffitto, e circondato da una corona di 300 beati.
Cereseto
Il paese di Cereseto probabilmente è sorto sul colle attualmente individuabile nella zona di Via San Tommaso e Via San Grato, tra il 500 e il 600 d.C.; in questo punto del paese vi nacque una fornace, o meglio, un grosso forno, dove la terra impastata veniva messa a riposare in cantine sotterranee e poi cotta,
ricavandone mattoni.
Le più antiche carte conservate presso l'Archivio Capitolare
del Duomo di Asti citano che intorno l'anno 957, il Vescovo di Asti,
Bruningo, fece una permuta di alcuni beni immobili situati a Cagliano,
Serralunga e nella Valle Sabadina con Eldeprando di Cortecomaro, ottenendone
in cambio altri beni situati sui territori di Cortecomaro
(...quinto campo est a locus ubi dicitur seralonga lacente latus terra ursoni
est per mensura iusta tabolas; centum nonaganta et duas...).
Cereseto era quindi un piccolo feudo d'origini molto antiche.
Il paese, sui documenti e sulle pergamene scritte a partire dall'anno 990 circa,
è nominato come Cirisidum, Cerisido, Cirisito, Cirisido, Cerexeti, Cireseto
ed infine Cereseto, probabilmente per le innumerevoli piante di ciliegio
che prosperavano su tutte le colline circostanti e tra i vigneti
(termine dialettale ciresa).
il castello di Cereseto è un classico "falso" costruito nel 1912 ad uso di abitazione privata per conto di Riccardo Gualino, famoso collezionista d'arte e ricco industriale, edificato, questo si, senza molto rispetto storico, sui resti di precedenti
più antiche opere architettoniche di cui non resta più traccia.
L'eccentrico personaggio si fece pure disegnare nel 1925 i mobili con cui arredò
il castello nientemeno che da Casorati, famoso pittore, e pare morì
in miseria e senza eredi.
Lo stile Gotico Lombardo del castello ha ben poco e che vedere
con l'architettura militare Monferrina e spicca per estraneità tra
i castelli (veri questi) di Gabiano, di Camino, di San Giorgio,
di Soglio e Castel Alfero.
L'unica cosa notevole è un bassorilievo bronzeo opera di Pietro Canonica sulla facciata.
Vi sono raffigurati alcuni contadini russi accanto ad un aratro che si genuflettono
ed era in origine destinato ad ornare la tomba dello Zar (la rivoluzione russa ha mandato
in fumo la commessa ed il Comune l'ha riciclato come Monumento ai Caduti)
certo che vedere su un muro del Monferrato barbuti Mugik con tanto di stivaloni e berretti tipicamente russi
fa' un po' di effetto.
Rosignano Monferrato
I primi documenti storici di Rossignano sono dell’anno mille, nella sua storia vi compaiono gli Alerami, i Paleologi, i Gonzaga ed infine
i Savoia e i Francesi.
Sede perenne di guarnigioni, più volte assediato, occupato e saccheggiato.
Il 21 aprile del 1640 fu respinto l'assalto delle truppe Spagnole. Questa ricorrenza
è ancora sentita
dalla popolazione che con grande festa civile e religiosa tutti gli anni il
21 aprile commemora portando la statua della
Madonna dell’Assalto in processione per le vie del paese.
Nel territorio Comunale sorgono tre castelli, il primo del XII secolo
è situato nel punto più alto del paese , sempre sede di guarnigioni militari;
(oggi si direbbe "caserma"); un secondo è nella frazione Colma ed un terzo in località
Uviglie.
Il castello di Uviglie Eretto nel 1276 subì numerose trasformazioni. I sotterranei,
adibiti a cantine di invecchiamento vini, sono, con la base della torre, del
XIII Secolo. Nell'ala oggi adibita a ristorante sono stati messi in luce arconi
gotici e capitelli romanici.
Ozzano
Sull'etimo della parola "Ozzano" si possono fare varie ipotesi. La più accreditata è quella secondo la quale il nome "Ozzano" deriverebbe da quello di un antico possidente romano della zona: Aucius. Mutando il dittongo in o, avremmo "occius" da cui,
progressivamente Ozzano che, forse non a caso, in dialetto è "Ausan".
Altre ipotesi, ricavate dai vari modi in cui il paese è nominato nei documenti esistenti (Orianum. Ozanum, Orzanum, Ortianum, Ozano), possono ricondurre ai termini latini orior, sorgo, e otium, riposo.
Le origini - Il primo documento in cui si parla di Ozzano si colloca tra la fine del IX e l'inizio del X secolo. Negli "Atti di sant'Evasio" si racconta che il santo, per sfuggire alle minacce degli ariani, si rifugiò " ... ad locum Orianum antiquitus nominatum in silvam cui vocabulum est Cornea..."
Nell'anno 1027 l'imperatore Corrado II il Salico confermò alla chiesa vercellese la località di Ozzano.
Si presume che il castello sia stato eretto in questi anni ed essendo, con la chiesa e il campanile, un simbolo del paese, gli dedichiamo alcuni cenni. Il maniero, in cima al colle con mura a strapiombo sull'abitato sottostante, ha subito nel corso dei secoli parecchi mutamenti. Elementi degni di nota sono i merli bifidi nella parte più antica, la cappella gentilizia, il giardino pensile, le grandi scuderie e i dipinti di Pier Francesco Guala. Faceva parte in origine delle mura del castello l'attuale campanile, bellissimo nella sua struttura semplice e severa.
Tra il XII e il XIV secolo il borgo sottostante il castello viene cinto da una cerchia di mura della quale un tratto e una torre di cortina sono ancora visibili.
Risale probabilmente a questi anni anche la costruzione della chiesa di San Salvatore nel suo nucleo più antico. Di stile romanico, pur presentando elementi di epoche e stili successivi, la chiesa è costruita interamente di mattoni in cotto, è a pianta longitudinale a tre navate e presenta una facciata a salienti.
I dipinti che ne adornano le pareti interne, purtroppo non tutti ben conservati, risalgono al XV secolo e i più belli, tra cui un'annunciazione,
appartengono alla scuola di Martino Spanzotti.
San Giorgio Monferrato
Il Territorio di San Giorgio fece parte fin dai tempi più remoti del così detto "distretto" di San Evasio. L'omonimo Castello, sotto il profilo documentale, è pure da ritenersi, secondo valenti storici, il più antico fra i castelli del Monferrato.
La prima attestazione riferibile comunque alla presenza di San Giorgio è quella contenuta nel diploma di Ottone III, del 7 maggio 999, che confermava al Vescovo di Vercelli Leone " districtus S. Evasi a Pado usque in Sturam, in Fraxaneto, Paxiliano, Ticinesse, Sarmaza et Sancto Georgio et in Ozano ultra tria miliara".
Federico Barbarossa con diploma del 1152 da Vitzemburg confermava al Vescovo Vercellese Ugozione la proprietà del Castello e del nascente borgo.
Un sinistra fama venne al maniero dal fatto di essere sede del tribunale d'Inquisizione.
Durante l'epidemia di peste del 1530, la città di Casale e il suo circondario vissero per un decennio sotto l'incubo della malattia.
Molte persone vennero denunciate con l'accusa di essere "untori" e processati da un tribunale del marchesato presieduto dall'integerrimo Commissario Necco.
Il tribunale si riunì nel castello di San Giorgio il 17 giugno del 1530 per giudicare una quarantina di persone accusate di aver sparso il contagio. La macchina della tortura riuscì a strappare negli interrogatori confessioni delittuose, complicità e delazioni. Il processo si protrasse per un mese e si chiuse con la condanna a morte di trenta persone colpevoli di aver perpetrato crimini per ben sette anni, dal 1522 al 1529,
un triste primato mai più eguagliato nelle storia delle unzioni in Italia.
Camino
Non esiste un concentrico ma tante piccole frazioni allineate su di una dorsale che domina il lato destro del Po.
I primi abitanti del territorio caminese furono liguri, che oltrepassando gli Appennini giunsero nel Monferrato e si assestarono sulla riva destra del Po;sull'altra sponda si erano attestati i Celti.
Verso la fine del 200 a.c i romani occuparono il Monferrato ed il rinvenimento di monete romane nel territorio di Camino conferma la presenza di piccoli isediamenti.
Nel V secolo dopo Cristo iniziarono le invasioni barbariche dei Goti e poi dei Longobardi che dominarono rudemente imponendo le loro leggi ed i loro balzelli.
Nel IX secolo al seguito di Carlo Magno giunsero i Franchi con nuovi ordinamenti che comportavano uno stato di assoluta parità tra italici e longobardi.
Inizia l'epoca feudale e Camino rientra nel nuovo ordinamento amministrativo in cui era previsto come feudatario un Vescovo.
Il toponico Camino si legge per la prima volta in un documento del 6 gennaio 1151 dove un certo Guglielmo da Camino e sua moglie Agnese fanno una donazione alla chiesa di Pontestura.
Il toponico Camino ha una radice italico/latina a differenza di altri paesi circonvicini di chiara radice
longobarda Storici e studiosi hanno adombrato varie ipotesi sulla sua origine tutte confluenti in un unico rapporto: il fuoco ed il fumo che si perde attraverso i camini e che presume la presenza di un focolare.
Camino è un comune anomalo per il suo territorio geografico ricco di piccole frazioni che formano un anello in cui è incastonata quella perla del castello medioevale , il più antico ed il più suggestivo di tutto il Monferrato.
Nel IX e X secolo il vescovo di Asti fu feudatario del territorio caminese creando un primo insediamento chiamato Cornale dove gia sorgeva la Plebs santi Laurenti da Cornate.
Camino è noto per essere la patria di G B Boetti detto profeta Mansur leggendario frate missionario che nel 1700 trasferendosi nel medio oriente diventò capo di un esercito islamico che osò sfidare la grande Caterina di Russia.
Gabiano
Che la località del capoluogo Gabiano risalga all'epoca romana, ormai sono
concordi tutti gli studiosi. Infatti il toponimo Gabianum fa riferimento ad un
possidente locale Gavius o Gabius, che probabilmente in epoca imperiale installò
qui la sua curtis, specie di grande fattoria agricola.
Ne è conferma il ritrovamento nel secolo XVIII di una colonna miliaria presso
la Chiesa parrocchiale con duplice iscrizione di Diocleziano e Massimiano, oggi
conservata al Museo Leone di Vercelli. Durante i secoli VI e VII questo territorio
per la facilità di guado del fiume Po fu soggetto ad una progressiva penetrazione
di nuclei di stirpe germanica, che si insediarono in questa zona. Loro caratteristica fu quella di stabilirsi in piccoli gruppi famigliari, chiusi e staccati rispetto alla popolazione locale.
Di qui la fondazione dei nuovi cantoni di Mincengo, Zoalengo, Martinengo, Chioalengo, Barbarengo, Varengo, oggi tutte frazioni del Comune.
Fa eccezione Cantavenna, la cui origine risale molto più indietro, ai liguri o ai celti.
Carlo Magno, vincitore dei Longobardi, assegna il territorio di Gabiano come possesso
all'abbazia della Novalesa (Val di Susa) e il monaco cronista dell'epoca la descrive
come una "corte molto grande", comprendente non solo la zona collinare attorno alla
valle Gaminella, ma anche la pianura e i villaggi padani alla sinistra del Po.
Odalengo Grande
Segnaliamo la torre di San Quirico ed il castello, in perenne restauro mai concluso.
Murisengo
Le remote origini del castello non sono note per la perdita di ogni documento dovuta ai numerosi saccheggi ed incendi subiti. Della originaria struttura non rimane che la torre merlata, costruita nel 1510; le costruzioni attuali risalgono al 1600 e a epoche successive.
Il castello doveva già esistere nel 1164, quando Federico Barbarossa concesse il feudo di Murisengo ai marchesi del Monferrato.
VillaAdeati
La parete antica dell’ abitato è arroccata attorno al grandioso castello, ora dei Feltrinelli.
Tra il crollo dell'Impero Romano e gli inizi del Medioevo probabilmente sono da collocare il popolamento stabile di questa fascia di colline comprese fra i torrenti Stura e Versa, ossia fra Asti e Casale-Chivasso.
Nel secolo XII° numerose località monferrine, fra le quali Villadeati e la vicina Durbecco, erano sotto la giurisdizione dei vescovi di Vercelli.
Nel 1299 la chiesa dell'attuale frazione Zanco, dedicata a San Giorgio, era anch'essa elencata (con quella di "Villa") nelle dipendenze della diocesi vercellese (e soltanto nel 1584 sarà elevata a dignità di parrocchia). Le altre parrocchie erano Lussello e Cardona.
Nel secolo XV° Villadeati ebbe uno statuto sulla falsariga di altri dell'epoca in quest'area del marchesato monferrino. Sappiamo per certo che Villadeati (Villadeatorum, e prima anche Corte de Scataldeis) con il nome "Villa di Diati" compare in un elenco di 180 località del Marchesato del Monferrato (datato 1571).
La chiesa dei Santi Nazario e Celso è l'ultima traccia dell' antico insediamento medioevale: il villaggio Mairano
Montechiaro
Dalle piu' antiche fonti documentarie, Monte Chiaro deriverebbe dal latino " mons clarus". E' abbastanza incerto il significato da dare al termine "clarus", per alcuni si deve intendere come "spoglio di alberi" mentre per altri si riferisce alla "bianchezza del terreno".
La nascita di Montechiaro si puo' far risalire al XIII secolo. Antecedentemente, nella zona circostante vi erano tre borgate con le rispettive chiese parrocchiali:
il borgo Mairano con la chiesa dei SS Nazario e Celso distante dal concentrico attuale circa 1800 metri;
il borgo di Maresco, con la chiesa dedicata a S. Vittore che distava dal concentrico altrettanto;
il borgo con la la chiesa di Pisenzana distante a poco meno di un migliaio di metri dal colle dove sorge ora il paese.
L' attuale chiesa di S. Maria di Pisenzana molto probabilmente è solo una parte dell' antica chiesa parrocchiale. Le tre chiese parrocchiali avevano il loro cimitero attiguo, come allora si usava. Le case delle tre borgate erano raccolte attorno alla loro parrocchia; e nelle vicinanze della chiesa di San Nazario vi è una regione che si innalza dal terreno circostante chiamata Castelmairano, forse perchè a quei tempi esisteva un castello.
Villa San Secondo
Sorse come libero Comune all' inizio del Trecento dalla scissione dal vicino borgo feudale di Cossombrato. Era Cossombrato un centro di un migliaio di persone sito a nord di Asti, infeudato dal vescovo astense ad alcuni vassalli: cioè un ramo della casata dei Pelletta e da un altro consortile di altri cinque Domini, che, non avendo altre specificazioni dinastiche, si possono chiamare signori De Cossombrato.
Simpaticamente arredata dalla Chiesa e da case in stile faudale la lunga piazza in curva e a schiena d'asino.
D'effetto la Parrochiale seicentesca con la ripida scalinata in cotto che porta al sagrato

 PERCORSO 1 - Portacomaro e le sue colline
PERCORSO 1 - Portacomaro e le sue colline
 PERCORSO 3 - Crea e il Monte Sacro
PERCORSO 3 - Crea e il Monte Sacro
 PERCORSO 4 - Da Callianetto a Vezzolano
PERCORSO 4 - Da Callianetto a Vezzolano
 PERCORSO 5 - Il Cuore Verde del Monferrato
PERCORSO 5 - Il Cuore Verde del Monferrato


PERCORSO 1 - Portacomaro e le sue colline
PERCORSO 3 - Crea e il Monte Sacro
PERCORSO 4 - Da Callianetto a Vezzolano
PERCORSO 5 - Il Cuore Verde del Monferrato