.
I lombardi alla prima crociata
I lombardi alla prima crociata,
dramma lirico in quattro atti, venne rappresentato al Teatro alla Scala
di Milano l'11 febbraio 1843. Temistocle Solera ne scrisse il libretto
suddividendolo in quattro parti - rispettivamente titolate: La vendetta,
L'uomo
della caverna, La conversione, Il Santo sepolcro: la
vicenda fu tratta dall'omonimo poema del 1826 di Tommaso Grossi.
Nato a Bellano (Como) nel 1790,
Tommaso Grossi fu poeta e romanziere (scrisse anche alcune opere dialettali);
fu amico di Carlo Porta e del Manzoni. Con il suo poema I lombardi alla
prima crociata tentò, pur senza sortire l'effetto sperato, di
effettuare una sorta di "rivisitazione", secondo i propri intendimenti
più scorrevole e aggiornata, della Gerusalemme liberata del Tasso.
Da parte sua, Solera narrò la vicenda componendo versi il cui effetto
risultò, in alcuni passaggi, umoristico anche laddove l'intento
avrebbe dovuto essere drammatico. Un esempio: "... piano entraam conpiè
sicuro / ogni porta ed ogni muro; / fra le grida, fra i lamenti, / imperterriti
tacenti, / d'un sol colpo in paradiso / l'alme altrui godiam mandar: /
col pugnal di sangue intriso / poi sediamo a banchettar...". Primo violino
e capo dell'orchestra di quella prima esecuzione scaligera fu Eugenio Cavallini;
i principali interpreti dell'opera furono: Erminia Frezzolini (soprano),
Giselda; Teresa Ruggeri (soprano), Viclinda; Carlo Guasco (tenore), Oronte;
Napoleone Marconi (tenore), Arvino; Prospero Dérivis (basso), Pagano
e Gaetano Rossi (basso), Pirro.
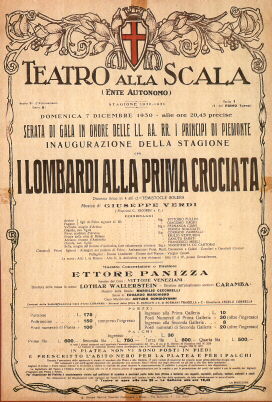 La
vicenda, intricatissima, inizia a Milano nel 1099. Aiutato dallo scudiero
Pirro e da un pugno di sgherri, Pagano, nel tentativo di uccidere per gelosia
il fratello Arvino (il quale poi sposerà Viclinda, che Pagano vuol
conquistare, ma che lo respinge), colpisce invece a morte il padre. Pentitosi,
per riscattare la sua colpa, Pagano parte per la Terrasanta, dove l'azione
si sposta: qui vive da eremita in una grotta. Giunge anche Arvino, alla
testa dei crociati lombardi: sua figlia Giselda viene rapita e imprigionata
dal tiranno di Antiochia, Acciano, del cui figlio, Oronte, la giovane si
innamora. Giselda viene alfine liberata dai crociati, che uccidono Acciano
e Oronte; quest'ultimo muore tra le braccia dell'amata Giselda, dopo che
l'eremita Pagano è riuscito a battez tetto natìo..." - atto
IV, scena III - è il celebre coro con il quale i crociati e il loro
seguito implorano l'aiuto celeste): con loro combatte eroicamente l'eremita.
Ferito, quest'ultimo viene condotto nella tenda di Arvino, si fa riconoscere
e perdonare. Pagano infine muore, dopo avere però potuto contemplare
Gerusalemme, sulla quale sventolano le bandiere dei crociati vittoriosi. La
vicenda, intricatissima, inizia a Milano nel 1099. Aiutato dallo scudiero
Pirro e da un pugno di sgherri, Pagano, nel tentativo di uccidere per gelosia
il fratello Arvino (il quale poi sposerà Viclinda, che Pagano vuol
conquistare, ma che lo respinge), colpisce invece a morte il padre. Pentitosi,
per riscattare la sua colpa, Pagano parte per la Terrasanta, dove l'azione
si sposta: qui vive da eremita in una grotta. Giunge anche Arvino, alla
testa dei crociati lombardi: sua figlia Giselda viene rapita e imprigionata
dal tiranno di Antiochia, Acciano, del cui figlio, Oronte, la giovane si
innamora. Giselda viene alfine liberata dai crociati, che uccidono Acciano
e Oronte; quest'ultimo muore tra le braccia dell'amata Giselda, dopo che
l'eremita Pagano è riuscito a battez tetto natìo..." - atto
IV, scena III - è il celebre coro con il quale i crociati e il loro
seguito implorano l'aiuto celeste): con loro combatte eroicamente l'eremita.
Ferito, quest'ultimo viene condotto nella tenda di Arvino, si fa riconoscere
e perdonare. Pagano infine muore, dopo avere però potuto contemplare
Gerusalemme, sulla quale sventolano le bandiere dei crociati vittoriosi.
|
L'opera ebbe ottima accoglienza alla
sua prima rappresentazione a Milano; dieci mesi dopo segnò invece
un insuccesso, a Venezia dove venne messa in scena. In seguito il lavoro
venne riproposto in parecchi teatri e ottenne sempre un buon successo.
Con il titolo di Jérusalem, personaggi ribattezzati, il testo
di Solera tradotto in francese (a cura di Alphonse Royer e Gustav Vaëz)
e alcuni cambiamenti interni allo spartito, l'opera fu rappresentata con
ottimo esito il 26 novembre 1847 all'Opéra di Parigi. In questa
nuova edizione gli interpreti furono: Julian van Gelder (soprano), Elena;
Muller (soprano), Isaura; Gilbert Louis Duprez (tenore), Gastone; Charles
Portehaut (tenore), Conte di Tolosa; Adolphe Alizard (basso), Ruggero;
Hippolyte Brémont (basso), Ademaro di Monteil. Nuovamente ritradotta
in italiano da Calisto Bassi, la versione parigina fu presentata anche
alla Scala, il 26 dicembre 1850, con il titolo di Gerusalemme.
. |

