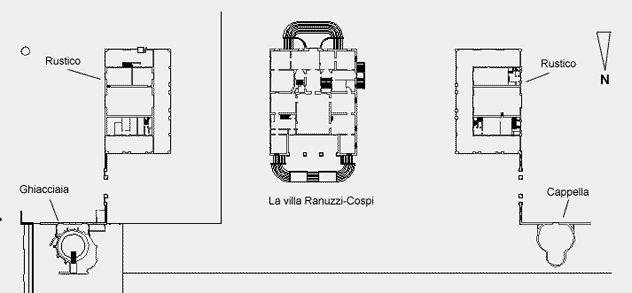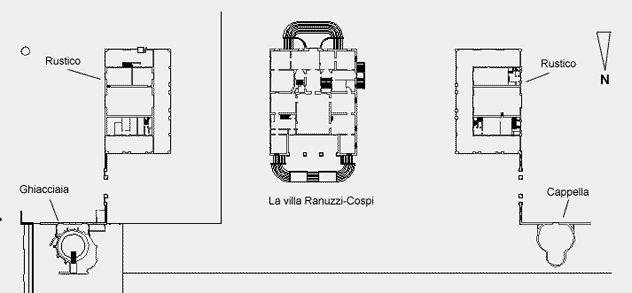BAGNAROLA DI BUDRIO
A circa 15 Km Nord-Est da Bologna, in un territorio ancora scandito dalla centuriazione romana iniziata nel II sec. a.C., si trova Bagnarola, che con le sue ville è la località più celebre del Budriese.
"Luogo ameno, che supera in vaghezza ogni altro" diceva di questo luogo il Golinelli (Golinelli D., Memorie istoriche antiche e moderne di Budrio, terra del contado di Bologna, Bologna, 1720, p. 67); egli poté vederla nel massimo splendore del primo Settecento, corte fastosa dei Malvezzi e dei Ranuzzi Cospi, quando le ville meravigliose accoglievano il fiore della nobiltà bolognese ed europea, e le feste sontuose si susseguivano nelle grandi sale, nei parchi-giardini, sotto gli ampi loggiati e nei teatri, alternandosi con le partite di caccia lungo le sponde dei torrenti nella circostante pianura.
Nella storia di Bagnarola si avvicendano periodi oscuri e periodi fortunati; nei tempi antichissimi fu abitata dagli Etruschi, dai Galli Boi e dai Romani; della loro presenza in questa zona fanno fede i resti archeologici venuti in luce nel 1864, nel 1879, nel 1882 (Cfr. Casini L., Il territorio Bolognese nell'epoca romana, in "Atti e memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provv. di Romagna", vol. III, 1909, p.273; dà notizia di questi reperti anche Rubbiani A., L'agro dei Galli Boii (Ager Bojorum) diviso ed assegnato ai coloni romani (anni 575-571 di Roma), in "Atti e memorie...", vol. I, pp. 93,94.) e, più recentemente negli scavi effettuati tra il 1965 ed il 1970.
Il toponimo Bagnarola, derivato da Balnearola, mostra nel suo chiaro significato (balnearola nel latino postclassico indica luogo o vasca per bagni Bagnarola. Balnearola: la base etimologica è nel latino classico Balneum, che significa "bagno", ma anche "acquitrino", "stagno", con l'aggiunta del doppio suffisso -arius+eolus.) quale fosse l'abbondanza di acque di questo territorio, attraversato da molti torrenti, con alle spalle il Savena e davanti l'Idice; questi scorrevano nei loro alvei non arginati mutando spesso il corso per le piene e gli straripamenti, e creavano così ampi tratti paludosi.
Nel primo secolo dopo il Mille le terre di Bagnarola erano state in parte bonificate. Tale operazione, nella nuova economia agricola, era rivolta prevalentemente a terre incolte, divenute selvagge, e ad altre, paludose, da drenare incanalandone le acque.
La giurisdizione di Bagnarola, nel Medioevo ed anche in epoca posteriore, era molto più ampia ed importante di quella attuale. Sul finire del Duecento, fra i proprietari terrieri, vi appaiono anche i Bentivoglio, che molta importanza avranno in seguito, oltre che nelle vicende bolognesi, anche nello sviluppo di Budrio, potenziandone l'agricoltura e difendendone gli aspetti economici. Ma in questo periodo ha anche inizio un calo demografico che diviene via via più accentuato. Alcuni motivi possono trovarsi probabilmente nell'instabilità del suolo, spesso soggetto, come si è già detto, ad inondazioni che rovinavano le colture provocando quindi carestie ed abbandono dei luoghi. Questa zona era, inoltre, soggetta a frequenti passaggi di truppe e, in seguito, ai gravi disagi della tremenda peste nera (1347-1348) che infierì pure nel Budriese. Contemporaneamente al calo demografico, si manifestava una notevole recessione economica che, soprattutto a causa delle frequenti carestie, accelerava il processo di decadenza della grande comunità.
A metà del Trecento, divenuto signore di Bologna Giovanni Visconti ed istituita una nuova amministrazione del territorio, Bagnarola entra nella giurisdizione del Vicariato civile di Budrio insieme con altri sedici comuni.
Nel Cinquecento, come Budrio, anche Bagnarola si scinde in due comunità, con amministrazioni separate: Bagnarola di Sopra (a sud) e Bagnarola di Sotto, ossia dei Ronchi ( Bagnarola di Sotto, o dei Ronchi, viene chiamata in seguito soltanto "Ronchi di Bagnarola").
I secoli successivi furono i più esaltanti. Infatti a partire dal seicento la cultura bolognese emerge nel panorama artistico nazionale: non per nulla fu detto che "lo scettro dell'arte ... passò da Firenze a Bologna" (Malaguzzi Valeri F., Palazzi e ville bolognesi, in "Cronache d'arte",vol.V, 1928, p. 51). In questo stesso periodo a Bagnarola nasceva, ad opera del conte Prospero Ranuzzi Cospi, l'accademia de "I Notturni", salotto degli intellettuali bolognesi, che vide passare opere pittoriche di maestri quali Guido Reni, Lodi e Bertuzzi. Non mancavano neanche le occasioni per organizzare sfarzose feste, come quelle in onore dell'Assunta ogni 15 d'agosto, che richiamavano "molto concorso di gente, specialmente della nobiltà, dai dintorni di Bologna". Questi intrattenimenti consistevano per lo più in rappresentazioni teatrali, ideate dallo stesso Ranuzzi, e da lui poste in scena nel prato dinanzi alla sua villa. Celeberrima fu quella del 1711, di cui racconta il Frati: "...videsi comparire sul gran prato della villa un gran carro trionfale, su cui era Giove a cavallo d'una grande aquila; aveva ai piedi un globo dorato, simboleggiante il mondo, e più sotto le quattro parti del mondo. Seguivano quattro carrette, montate da Marte, Pallade, Amore e Venere, che fecero un giro attorno al prato, dopo di che incominciò la rappresentazione. Finita la recita della commedia a soggetto mitologico, si corse una giostra da dodici giovani contadine e fra la nobiltà accorsa per assistere a tali divertimenti vi fu anche la principessa Maria Caterina Carignano d'Este che applaudì lo spettacolo, e le villanelle, terminata la giostra, vollero baciarle il lembo della veste. Una merenda allegra, copiosa e squisita, pose termine alla festa campestre di Bagnarola" (tratto da Frati L., Il Settecento a Bologna, Milano, 1923, pp. 206,207).
Dall'antico splendore si arriva fino ai giorni nostri, caratterizzati dallo abbandono di massa degli insediamenti rurali. Le antiche ville, solo in parte restaurate, rimangono come testimonianza storico-artistica di un fecondo periodo che caratterizzò il territorio budriese.
LE VILLE DI BAGNAROLA
Il complesso delle ville di Bagnarola, poste nella pianura vicino a Budrio, costituisce una vera sintesi di tutta la civiltà delle ville del Bolognese attraverso una serie di episodi iniziati nel '500 e terminati nell'800, tra loro connessi in una precisa trama urbanistica.
Si tratta di tre proprietà diverse: un castello a quattro torri costruito dai Bentivoglio nel '500, la Villa Ranuzzi-Cospi del '700, il Casino d'Aurelio, costruito nel '500-'600 e il Floriano, costruito durante il '700 e completato nell'800, queste due ultime facenti parte del "Borgonuovo di Bagnarola" dei Malvezzi-Campeggi (Cuppini G.-Matteucci A.M., Ville del Bolognese, Zanichelli, Bologna, 1969, pp.32-34).
Le vicende subite durante questo secolo hanno sconvolto le connessioni formate dal giardino-campagna in modo da renderle illeggibili; tuttavia è possibile dimostrare che l'aspetto più straordinario consiste nelle connessioni urbanistiche degli edifici, anzi attraverso Bagnarola è possibile individuare il tipo di giardino-campagna che costituisce l'elemento chiave delle ville bolognesi .
La prima costruzione in ordine di tempo fu il castello dei Bentivoglio sorto nel '500 e trasformato nel '700. Nall'anno 1700 venne costruita la Villa Ranuzzi-Cospi in sostituzione di una precedente più modesta costruzione, di cui resta uno schizzo ove appare una ariosa sistemazione del giardino-campagna con uno spazio attorno alla villa delimitato da esedre di pergole e con un piano prospettico definito da filari arborei. Questo schizzo è interessante perché è la prima documentazione sui giardini di Bagnarola, in cui figurano gli elementi che maggiormente li caratterizzarono nel '700: le pergole e i filari.
La nuova villa venne costruita instaurando un preciso rapporto prospettico con il castello di fronte, teso a creare uno spazio urbanistico unitario, sia pure fra due diverse proprietà. Al nucleo centrale, la residenza signorile, vengono affiancati due grandi edifici rustici porticati, poi ancora due edifici con facciata a "pendant" (la cappella e la ghiacciaia) che ampliano le dimensioni del fondale prospettico rappresentato dalla villa rispetto al castello. E' evidente il riferimento alle nuove esperienze della scenografia, che a Bologna divenne la più aderente interprete dell'esigenza barocca per gli spazi infiniti. Sulla strada che divide le due proprietà si affacciano due cancelli identici, costruiti in accordo fra i due proprietari, per mettere in comunicazione i due grandi prati fra le ville in occasione delle prime fiere di Bagnarola. L'ingresso abituale alle ville è invece laterale, per accentuare l'effetto di sorpresa.
Presso il castello, in direzione perpendicolare a quello della Villa Ranuzzi-Cospi, partiva un altro allineamento a viale che conduceva al Casino che Aurelio Malvezzi costruì nel 1623 su un nucleo preesistente già appartenuto ai conti Cospi. Attorno a questo nucleo originario i Malvezzi svilupparono altre costruzioni, tra cui un teatro edificato nel 1710 dai Bibiena (bruciato all'inizio del '900). Nel 1711 ottennero dal Papa il permesso di organizzarvi una fiera annuale di merci e bestiame: a questo scopo fecero costruire, nel 1718, un fabbricato con portico e botteghe più grande della loro stessa dimora, nella continuità della tradizione che fa di queste ville, invece che luoghi chiusi in aristocratico isolamento, veri centri degli interessi e dell'economia delle terre circostanti.
In questa architetture non si può prescindere dall'elemento "verde": alberi, spianate, siepi, sono componenti in-scindibili dell'architettura stessa. Si ha una progressione di verde e di spazi diversi, una complessità di aspetti corrispondenti alla molteplicità delle destinazioni. L'inserirsi del verde fra gli edifici risponde ad esigenze concrete di rapporti diretti con la campagna e la sua struttura: il parco non è rigidamente delimitato, ma si confonde e dissolve nella campagna che penetra nel cuore stesso del Borgo nuovo mediante il prato rasato e piatto.
Un ultimo episodio dà la misura della naturale accettazione di un preciso ordine di tipo urbano, anche nella campagna. Infatti quando, verso la metà del '700, Pietro Antonio Odorici acquistò il Castello Bentivoglio, vi fece costruire un edificio a ferro di cavallo con portico e botteghe che scavalcava con un arco la strada di accesso al Borgo nuovo. Tutto ciò per accogliere una fiera-mercato in concorrenza con quella dei Malvezzi: l'arcone aveva il compito di intercettare il percorso che mercanti e contadini facevano per recarsi al Borgo nuovo, ma il risultato formale corrisponde alla creazione di un ulteriore, più stretto legame fra i due complessi.
Villa Ranuzzi-Cospi
Nel XVI secolo, come si può vedere da un disegno del 1578, esisteva già la villa, di proprietà dei Cospi, ereditata poi dai Ranuzzi. Nel 1700 il conte Vincenzo Ferdinando Ranuzzi Cospi fece trasformare completamente l'edificio, demolendolo in parte, affidando il progetto all'architetto Sebastiano Bertelli, "perito agrimensore". Nella sua documentazione figurano anche uno schizzo del portale di Palazzo Ratta e il rilievo di una pianta della villa La Paleotta, che servì da riferimento per il disegno della villa a Bagnarola. I disegni di alcuni particolari costruttivi e delle specchiature delle porte, ci dimostrano la cura con cui fu progettato l'edificio.
|