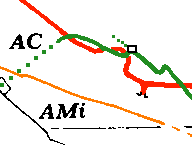 clicca sull'immagine per aprire la tavola in un'altra finestra |
nota: su questo sito presentiamo solamente la tavola d'insieme
Acquedotti romani, cisterne, cavità artificiali e naturali nella rupe di S. Cosimato a Vicovaro
estratto da "Atti e Memorie" della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, Volume LXXI - 1998, pagine 65-85
scritto da
Giulio Cappa e Alberta Felici
1. Premessa
Nel corso del 1997 i Frati Francescani del convento di S. Cosimato a Vicovaro hanno dato vita ad una complessa serie di interventi di manutenzione e restauro sia delle opere architettoniche che dell’ambiente naturale rientrante nel perimetro delle pertinenze del convento. A queste ultime in particolare è stato fornito un importante contributo dagli speleologi di alcuni Gruppi del Nord-Italia i quali, con l’occasione, hanno pure iniziato una ricognizione generale di tutte le cavità sotterranee presenti nell’area. Ad essi si sono, fin quasi dall’inizio, associati gli scriventi ed alcuni altri speleologi del Lazio, provenienti dai Gruppi ASR’86 di Roma e Shaka Zulu di Subiaco: si è colta l’occasione per compiere uno studio sistematico dei due acquedotti romani antichi che attraversano la rupe di S. Cosimato ed un rilevamento topografico completo degli stessi, nonchè di tutte le altre cavità reperite; è interessante notare che, oltre alle numerose grotticelle, in buona parte già note (ma non rilevate), ed alle cavità adibite a culto (antichi rifugi di monaci eremiti o cappelle), pure ben conosciute e già prese in esame dagli scriventi nel 1990, grazie soprattutto all’opera infaticabile di alcuni speleologi di Saronno e Como, sono state rinvenute una interessante galleria di probabile epoca romana e numerose piccolissime cavità contenenti evidenti tracce di una frequentazione eremitica medioevale, che si aprono sulle pareti che incombono sul fiume Aniene, oggi raggiungibili solo con tecniche di scalata artificiale, ma in antico collegate da sentierini e scalette incisi nella roccia. È stata inoltre "riscoperta" una cisterna, di epoca verosimilmente romana, nel piazzale antistante la chiesa, e ricognita pure la cisterna sottostante il pozzo rinascimentale, posto davanti all’ingresso del convento.
Nella presente relazione si forniscono i rilievi topografici e le descrizioni particolareggiate di tutte le opere ipogee artificiali prese in esame.
2. Gli acquedotti romani
La rupe di S. Cosimato fu superata dagli acquedotti Aqua Marcia (AM) e Aqua Claudia (AC) per mezzo di una serie di gallerie scavate nella viva roccia che, localmente, è costituita, per uno spessore di ben 50-60 metri di altezza, da un travertino alquanto impuro e spugnoso, formatosi durante il Pleistocene alla confluenza del torrente Licenza nel fiume Aniene.
Tali acquedotti sono stati ampiamente studiati, nella loro totalità, da illustri archeologi (tra i quali eccelle l’opera di T. Ashby, 1935), per cui nella trattazione che segue ci si limita a riferire sulle osservazioni direttamente compiute dagli scriventi, inerenti sia aspetti non ancora sufficientemente approfonditi in letteratura che specifici particolari costruttivi accertati durante i rilevamenti topografici, eseguiti nella scala originaria 1:200 tracciando la pianta, il profilo longitudinale e numerose sezioni trasversali di tutti i condotti.
Gli antichi Romani non tracciarono gallerie dritte attraverso il cuore della rupe, come per altro la tecnologia in loro possesso fin dal VII-VI sec. a. C. poteva consentire (attestata dalla realizzazione degli emissari dei laghi Albano e Nemi, per lunghezze due-tre volte superiori a quella della rupe in questione), ma preferirono scavarle pochi metri all’interno della parete che strapiomba sul fiume Aniene: tecnica che, consentendo di operare attraverso numerose bocche d’accesso, permette sia di ridurre i costi che di accelerare notevolmente i tempi di realizzazione dell’opera. Probabilmente essi però non si resero conto che, sia a causa della scarsa resistenza di quella roccia, sia perché la formazione travertinosa poggia su un discreto spessore di ciottoli fluviali più antichi (evidenziati dagli scavi posti in opera per la costruzione della moderna diga idroelettrica), la parete della rupe sarebbe stata soggetta ad una continua serie di cedimenti e distacchi superficiali, ai quali si accompagnano numerose fratture interne che si allargano progressivamente rendendo impossibile conservare la tenuta idraulica dei condotti per tempi superiori ad alcuni decenni. Già in occasione dei primitivi tracciamenti vennero incontrate zone di roccia cataclasata o fratturata che imposero opere di consolidamento o aggiramento degli ostacoli; ma in seguito, nell’arco dei pochi secoli dagli imperatori Augusto ad Adriano, molti tratti dovettero essere rifatti più all’interno, anche due o tre volte successive, e si ha l’impressione, come sarà spiegato più avanti, che l’intero percorso primitivo dell’Aqua Marcia sia stato completamente sostituito in epoca imperiale.
Nel complesso oggi ci troviamo di fronte a un dedalo di gallerie, in alcuni tratti zigzaganti in modo apparentemente inspiegabile (ma che invece diventa chiaro se si tiene conto della fratturazione della roccia; a tal proposito si deve notare come la giustificazione che le curve fossero state tracciate per frenare la velocità dell’acqua - espressa da precedenti Autori - non regge ed è incompatibile con i principi dell’idraulica: essa, infatti, ci insegna come tali curve non rallentino apprezzabilmente il deflusso, ma provochino altri inconvenienti di erosione o deposizione di crostoni calcarei sulle pareti, come comprovato dall’ampia documentazione fotografica eseguita dagli scriventi); la visita delle gallerie è per lo più agevole e resa interessante per la possibilità che offrono di comprendere la complessità e difficoltà delle opere, di ammirare attraverso le numerose finestre aperte in parete la bellezza della sottostante gola del fiume, di leggere sulle pareti decine di firme di antichi visitatori con date che risalgono fino alla metà del 1400.
Il rilevamento topografico dei due acquedotti è ora presentato in tre tavole, disegnate originariamente in scala 1:200 e quindi riprodotte in scala ridotta per ovvie necessità tipografiche; le precede una tavola d’insieme, solo planimetrica, tracciata nella scala originaria di 1:1’000, che permette di posizionare gli acquedotti rispetto all’ambiente circostante e, in particolare, alle altre opere più avanti descritte che vi sono indicate con le sigle messe tra parentesi quadre nel testo che segue.
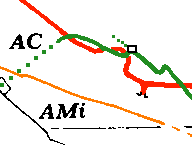
clicca sull'immagine per aprire la tavola in un'altra finestra
nota: su questo sito presentiamo solamente la tavola d'insieme
3. L’AQUA MARCIA a valle della diga idroelettrica (Tav. 1)
L’ingresso di più facile accesso si trova all’interno di un orto recintato (caposaldo 0). Sulla sinistra si nota un breve diverticolo, probabilmente scavato in tempi recenti; superato un mucchio di materiali depositativi dal proprietario, fino al caposaldo 3 il suolo appare coperto da un modesto strato di detriti, quindi la galleria prosegue praticamente pulita.
Le pareti si presentano all’inizio con tracce di muratura mista di frammenti di roccia e calce, poi la roccia è direttamente rivestita dall’intonaco impermeabilizzante, in ottimo stato, fino ad un’altezza di m 2 ca.; la volta è per lo più di nuda roccia, tranne alcuni brevi tratti, presso i caposaldi 2-4-6, dove ab origine fu rivestita con malta gettata su tavole di legno disposte secondo un profilo trapezoidale.
L’altezza della galleria si mantiene sui m 2,5, la larghezza è di poco superiore al metro. Il condotto procede quasi rettilineo fino al caposaldo 10, incontrando qualche piccola concamerazione naturale (v. ad es. presso il caposaldo 9) lasciata intatta dato che non poteva interferire col deflusso idrico, per uno sviluppo di m 175. Quindi comincia a presentare una serie di ampie curve, mentre sul pavimento inizia un accumulo di detriti fini di altezza crescente.
Al caposaldo 14 occorre strisciare: sulla volta si apre una specie di botola che permette di uscire e scorgere, a meno di m 20, i ruderi della mola [M] posta sulla sponda del fiume presso il moderno ponte in cemento. Si può continuare nel condotto strisciando per breve tratto, poi la sezione torna ad altezza d’uomo e sbocca all’aperto dopo una trentina di metri; per i successivi m 240 il condotto è stato tranciato a metà dal crollo della parete esterna, ma si transita agevolmente. Seguono m 20 di galleria rettilinea pulita: essa termina bruscamente nel vuoto, dove, senza alcun riguardo per l’opera antica (che poteva benissimo essere rispettata), la roccia è stata sottoescavata profondamente in occasione della costruzione della diga.
Il tratto di condotto 0-14 è caratterizzato dalla presenza di numerose scritte sulle pareti: a carboncino, creta rossa o matita. Predominano immagini sessuali oscene, infatti nei secoli passati era noto che esso fosse utilizzato a mo’ di postribolo. Ormai si tratta di opere vecchie di qualche secolo e quindi, nonostante la scabrosità dei soggetti, degne di conservazione; alcuni disegni sono di pregevole fattura.
4. L’AQUA MARCIA inferior (Tavola d’insieme e Tav. 1)
Sotto allo sbocco 25 si nota l’apertura di un’altra galleria analoga: essa è stata raggiunta arrampicando dal basso (dalla cosiddetta "scala pesci") constatando che si tratta di un condotto quasi parallelo, un po’ più stretto e basso, con rivestimento impermeabilizzante molto malandato, che termina dopo meno di m 20 in frana; sul suo prolungamento ideale a valle si incontra, sul bordo della strada asfaltata che conduce alla diga, un foro (recentemente di nuovo occluso), da cui è stato possibile accedere ad un condotto piuttosto stretto (cm 50 ca.) e basso (raramente ad altezza d’uomo) che procede verso monte proprio in direzione dell’altro tratto e alla stessa quota, terminando in frana a poche decine di metri di distanza; a valle esso si interrompe perchè riempito di detriti in occasione della costruzione della strada moderna.
L’intonaco parietale è molto rovinato e scomparso a tratti, la volta è per lo più a cappuccina perché la superficie esterna risulta vicinissima: infatti, davanti al citato sbocco dell’Aqua Marcia al caposaldo 14, dal prato emerge una struttura muraria longitudinale che è chiaramente il rivestimento esterno del condotto sottostante (tra i caposaldi 10 e 11).
Ricordando che l’Ashby (1935) aveva individuato presso il cosiddetto "pozzo quadrato", di collegamento tra l’Aqua Claudia e la sottostante Aqua Marcia, l’inizio di un condotto inferiore, sembra legittimo correlare quanto trovato alle indicazioni dell’Ashby: ovviamente si può ritenere che il tratto intermedio, trovandosi al di sotto del livello del lago prodotto dalla diga, sia completamente sommerso e verosimilmente riempito di limo. Solo con uno scavo potrebbe essere riportato alla luce.
Si tratta di un condotto estremamente interessante, cui gli scriventi hanno assegnato il nome di Aqua Marcia inferior (sigla AMi): infatti, approfittando di uno svuotamento della diga per manutenzione, nell’estate 1997 è stato possibile trovare sulla sponda del fiume le tracce verso monte di tale condotto (costituite da una parte inferiore di condotto, con imposte laterali di paratie, e due tratti di galleria, completamente intasati di fango - a conferma di quanto detto per il tratto tra il "pozzo quadrato" e la diga - indicati con la sigla AMi nella planimetria generale) fino ad una distanza di quasi m 300 dal citato "pozzo quadrato", sempre ad una quota di m 2,5 ca. inferiore a quella dei già noti condotti della AM.
Se si considera che questi ultimi sembrano tracciati, nei loro vari rifacimenti, con una tecnica analoga a quella della soprastante AC e possono a buon diritto essere ritenuti di epoca imperiale, si potrebbe essere portati a ritenere che il tracciato così identificato appartenesse al condotto originario dell’Aqua Marcia costruito nel 144 a. C., cioè uno o due secoli prima, e non fosse una semplice derivazione dall’acquedotto principale come in alternativa si poteva supporre se non ne fosse stata trovata traccia anche a monte del "pozzo quadrato".
Anche l’ipotesi che sia un resto di un percorso più a monte dell’incile dell’Anio Vetus, posto tradizionalmente sotto a Vicovaro, non regge perché ci si trova sulla sponda opposta ed è poco probabile:
1) che avessero sentito la necessità di attraversare il fiume con un ponte (di cui non v’è traccia), necessità invece inevitabile per AM e AC, in quanto esse captano sorgenti poste sul lato destro orografico dell’Aniene;
2) che i condotti dell’AM fossero stati costruiti in assoluta vicinanza del precedente acquedotto Anio Vetus, con la cui acqua, proveniente dal fiume e non da sorgenti assai più pure, non v’era convenienza a effettuare mescolanze.
5. L’AQUA MARCIA a monte della diga (Tavv. 2-3)
Si ritrova il condotto immediatamente al di là della spalla in rilievo della diga, di fianco al cancello della sua recinzione (si veda al margine sinistro della Tav. 2 il caposaldo 30). In realtà il condotto verso valle si prolunga per tutto lo spessore della diga, viva dimostrazione del fatto che con un minimo di attenzione la sua integrità avrebbe potuto essere preservata. La sezione è del tutto analoga a quella del tratto a valle; l’altezza, ridotta per qualche metro dai detriti, torna presto intorno ai m 2.
Dopo m 53 il condotto sbocca all’aperto (33) a causa di un arretramento della parete esterna, che perdura fino al caposaldo 36; riprende il percorso sotterraneo, ma assai prossimo all’esterno; dopo una doppia curva a S in 39 si incontra una prima biforcazione. Andando avanti dritto si sbocca subito all’aperto e nel tratto 39’-145 non v’è più traccia del condotto primitivo.
All’interno prosegue il condotto più recente, con una serie di curve, volute forse per aggirare fratture che già allora si stavano evidenziando; in 42 una finestra laterale, in 44 una nuova biforcazione: a destra si raggiunge in 145 il condotto originario con una "bretella" che risale evidentemente al primo rifacimento; a sinistra prosegue invece un condotto che, dunque, costituisce un ulteriore rifacimento. Molto interessante in 44 è la presenza di un cordolo verticale di sigillatura e rinforzo tra il rivestimento impermeabilizzante del condotto più vecchio e quello del condotto più recente, tecnica ben nota posta in atto agli angoli delle pareti delle cisterne romane.
Da 145 a 149 il vecchio condotto procede praticamente rettilineo, molto alto (fino a m 3), sovrastato in 146 da un puteus circolare alto una decina di metri, che termina ostruito al di sopra del livello dei condotti dell’Aqua Claudia, i quali gli passano vicinissimi ma senza intercettarlo. Presso 145 si può leggere sulla parete Nord, incisa nel rivestimento parietale, la data 1445, priva di firme. Seguono due "bretelle" di collegamento al condotto interno più recente, quindi un brusco abbassamento del livello del pavimento (nel punto in cui Ashby aveva individuato l’esistenza di un condotto inferiore, oggi non più reperito forse a causa dell’intasamento di detriti).
In 149 si trova il "pozzo quadrato", destinato a consentire di far defluire l’AC nell’AM in occasione di manutenzioni al condotto superiore, rivestito con mattoni di epoca adrianea (ASHBY 1935). Dalla base del "pozzo quadrato" si può attualmente uscire attraverso un’apertura realizzata in epoca sub-recente nella muratura romana; a monte l’acquedotto biforca: avanti dritto, un breve tratto molto interrato riconduce al condotto interno palesemente più recente (ma, forse, comunque anteriore alla realizzazione del "pozzo quadrato"), a destra si trova un breve tratto, assai ribassato e subito interrato.
Uscendo all’aperto, percorsi pochi metri costeggiando il lago, si giunge ad un’evidente apertura che riconduce in 153 al condotto primitivo che può essere percorso sia a monte che a valle per breve tratto (156-161) a causa di franamenti. Proseguendo lungo il lago si incontra in 164 un altro imbocco che risultava occluso da radici e terriccio; una volta aperto, si è incontrato un piccolo ambiente con biforcazione del condotto che, in tal punto risulta stranamente intonacato anche sulla volta. Per meglio comprenderne la funzione, sarebbe necessario intraprendere un’opera di scavo e completa ripulitura.
Il condotto più recente dopo 44 risale zigzagando fino in 50, dove una corta bretella lo ricongiunge al "pozzo quadrato"; più verso Est (Tav. 3) procede con lunghi tratti rettilinei intervallati da curve; è prevalentemente pulito, l’altezza aumenta per un abbassamento del pavimento dovuto probabilmente ad un’asportazione dei crostoni alabastrini di deposito calcareo dell’acqua.
Si incontrano una grotticella ed un foro circolare, rettilineo - traccia di un antico tronco rimasto intrappolato nel deposito travertinoso - e si giunge ad una prima frana, proveniente da un soprastante puteus; sulle pareti si notano numerose scritte e firme risalenti al 1500-1800 e primi decenni del 1900 (tra le quali quella dell’Ashby e di Ducci - ottobre 1920). Superata la frana, il condotto prosegue con tratti rettilinei fino a concludersi, poco dopo 58, con una nuova frana. Scavando è stato possibile sbucare all’aperto, nel bosco, subito sopra una paretina che sovrasta un tratto pianeggiante che costeggia il fiume; non è invece stato possibile ritrovare subito dopo la prosecuzione del condotto.
Procedendo all’aperto a mezza costa, in 64 si incontra un puteus circolare che riconduce nel condotto che si prolunga in entrambe le direzioni (63-66), terminando contro un secondo puteus circolare intasato da detriti. Ancora più ad Est non sono state più rinvenute possibilità di accesso all’acquedotto.
La diramazione più antica invece, a monte di 164, non è stata identificata: non è da escludersi che sia stata cancellata da cedimenti della roccia o di un condotto realizzato in calcestruzzo nel detrito di falda.
È interessante notare che nei condotti dell’AM, specie a valle del "pozzo quadrato", l’altezza dello speco è notevole e che il rivestimento impermeabile arriva generalmente ad una quota di ben m 2: caratteristiche apparentemente eccessive, se si confrontano con le tracce lasciate sulle pareti dal deflusso idrico.
Però esisterebbe una spiegazione che è proprio connessa con la presenza del "pozzo quadrato": questa sovrabbondanza sarebbe stata creata ad arte per consentire nello stesso speco anche il deflusso dell’AC, quando, per ragioni manutentive, si metteva in funzione la deviazione.
Questa considerazione permette però di dire anche che tali condotti dovettero essere costruiti in epoca imperiale e spiegare pertanto perché essi avessero rimpiazzato lo speco originario dell’AM (da noi ipotizzato nel tracciato di AMi) ma costruiti ad una quota appena un po’ superiore, per permettere la loro realizzazione senza interrompere il funzionamento dell’acquedotto originario.
6. L’AQUA CLAUDIA a valle della diga (Tav. 1)
Come descrive chiaramente l’Ashby, l’AC scorreva parallela e soprastante di alcuni metri all’AM. Al caposaldo 515 biforcava: il condotto originario proseguiva diritto in direzione di Vicovaro, ma oggi non è più transitabile perché intasato da cemento liquido proveniente dai rinforzi resisi necessari per la costruzione del ponte autostradale
Il rifacimento adrianeo invece piegava a sinistra per scavalcare il fiume sul ponte, i cui resti sono visibili a fianco del moderno ponticello stradale: dopo il crollo del ponte il condotto risultò troncato ed ora sbocca all’aperto sopra alla strada per la diga.
Questo accesso, raggiungibile risalendo la ripida scarpata, è ora (caposaldo 518) parzialmente intasato da detriti; più facile è entrare da una finestra laterale crollata (caposaldi 511-512) posta qualche decina di metri più a destra e nascosta da una fitta vegetazione arbustiva. Il tratto tra questi due accessi è basso, perché colmato per alcuni decimetri da detriti e colata cementizia.
Il condotto che risale a monte è per lo più sgombro e può essere facilmente percorso; tuttavia la sua altezza, di soli m 1,6-1,8, rende consigliabile l’uso di un casco. Appena entrati si notano sulla sinistra due allargamenti sub-recenti, tagliati netti nella roccia travertinosa, di cui quindi è possibile ammirare la complessa struttura interna; poi la galleria prosegue serpeggiando.
Ai caposaldi 505 e 502 due finestre antiche permettono di ammirare il panorama della gola. Segue un tratto in cui durante la costruzione della diga la parete esterna è stata profondamente sottoescavata: il condotto passa a pochissimi decimetri dal vuoto, presenta qualche brutta frattura ed è perciò pericoloso percorrerlo.
Al caposaldo 500 sbocca su una grande frana sovrastante la spalla della diga, con un pertugio molto piccolo a causa dei detriti. Per chi ha familiarità con la montagna, non sarebbe difficile traversare la frana ma, proprio per evitare il tratto pericolante, è più prudente accedere al resto dell’acquedotto scendendo dal convento di S. Cosimato.
7. L’AQUA CLAUDIA a monte della diga (Tavv. 2-3)
Nella Tav. 2 la pianta dell’AC è rappresentata spostata di m 20 verso Nord e m 20 verso Est per facilitarne la comprensione: in realtà i suoi condotti si sovrappongono quasi sempre a quelli dell’AM, come si vede dal tracciato di una linea a tratto e punto che rappresenta la mezzeria di quelli dell’AC.
Non è praticamente possibile raggiungere l’AC scendendo dal sentiero che conduce alle cappelle sottostanti alla chiesa del convento di S. Cosimato (cappella di S. Michele Arcangelo: [SM]), perché il tratto inferiore della frana è troppo ripido; occorre traversare tutto l’orto restrostante il convento e scendere la scala antica, abbarbicata ad una parete in qualche punto strapiombante, che conduce alla cappella del Beato Bonaventura [BB] e, più sotto, alla cappella di S. Benedetto [SB]. Pochi metri sotto ancora l’AC presenta due aperture di facile accesso. Il condotto che proviene da monte sbocca sulla frana con un’apertura svasata, parzialmente ingombra di detriti (caposaldo 38).
Al di là della frana, risalendo verso monte, si incontra subito un tratto molto tortuoso, con due brevi diramazioni sulla sinistra, di cui non è stato possibile accertare né l’epoca di scavo né la funzione: la mancanza di tracce di muro di contenimento, almeno fino all’altezza normale dell’intonaco, induce a ritenerle posteriori alla cessazione del funzionamento dell’acquedotto.
Nelle successive curve le pareti tornano ad essere rivestite dall’intonaco che impedisce di osservare la natura della roccia e quindi di capire se esistessero motivi strutturali per un tracciato che torna addirittura un po’ indietro (caposaldo 34). Il condotto, la cui sezione si mantiene regolare (larga poco oltre il metro, alta m 1,6-1,7) con pavimento quasi privo di detriti e pareti ben intonacate fin quasi alla volta, si riavvicina quindi alla parete esterna presentando quattro finestre di forma e dimensioni varie.
Al di sotto il condotto dell’AM risulta crollato, segno evidente di un netto arretramento della parete esterna; le finestre non sono dovute a crolli successivi, ma realizzate come vie d’accesso per gli scavi originari (infatti al di sotto di esse si conserva l’intonaco), anche se ormai non sono più raggiungibili dall’esterno.
Dalla quarta (caposaldo 19) un sentierino con scalini ben incisi nella roccia consente di salire in pochi metri alla soprastante cappella di S. Benedetto.
Al successivo caposaldo 17 si ha la prima biforcazione: a destra il condotto più antico, che sbocca all’aperto poco oltre, a sinistra il suo rifacimento, che, dopo una secca curva ad angolo retto, giunge in 14 ad un portale d’accesso a tutta altezza dal quale è pure possibile, anzi più agevole, raggiungere la soprastante cappella.
All’esterno si vedono chiaramente le tracce del vecchio condotto, che invece più ad Est scompaiono del tutto, per arretramento della parete, per i successivi m 40. Questo accesso, nella forma attuale certo posteriore all’abbandono dell’acquedotto, si trova in corrispondenza di un gruppo di piccole cavità naturali, ben concrezionate, ma che non sembrano aver posto problemi ai costruttori dell’acquedotto (non si notano opere murarie).
La galleria interna prosegue regolare, ondeggiando, per m 30 ca.; superata una finestra, arriva ad un crollo che la ha completamente interrotta per qualche metro (caposaldi 9-8), quindi riprende rettilinea per m 10; al caposaldo 7 sulla destra si apre, semiocclusa da un muro costruito in occasione del rifacimento più tardo dell’acquedotto, una bretella di collegamento al condotto originario che in 7’ riprende parallelo.
Segue un tratto in cui il soffitto è costituito da una struttura a cappuccina, formata da blocchi di travertino squadrati, di quasi m 1 di lato e spessi cm 20 ca.; poiché prima e dopo l’attraversamento di grotticelle naturali il soffitto fu lasciato allo stato naturale, evidentemente in questo punto la roccia doveva presentare una franosità molto marcata, in compenso l’opera fu così perfetta da essere rimasta tuttora intatta.
In 6 nuova bretella sulla destra di collegamento al condotto primitivo; poi la galleria prosegue, fa una curva e in 2 sbocca all’aperto in prossimità del "pozzo quadrato": qui si ricongiunge al condotto primitivo che, con qualche semplice disostruzione, è stato possibile seguire in tutto il tratto 2-7’, tranne una breve interruzione per frana in assoluta vicinanza della parete esterna.
A differenza del condotto più recente, quello originario presenta molti distacchi di intonaco; per alcuni metri, all’attraversamento di una grotta naturale molto concrezionata, presenta pareti laterali costruite con piccoli frammenti di roccia e calce, facilmente visibili per la caduta dell’intonaco.
Del collegamento con il "pozzo quadrato" ha già parlato esaurientemente l’Ashby; esso si trova m 3 ca. più all’esterno del condotto originario. Di fianco ad esso è possibile scendere, in facile arrampicata, alla sottostante AM.
A monte di 2 il condotto torna unico, in asse col tracciato più antico; serpeggia leggermente; dopo una ventina di metri sulla destra si nota una finestra, accuratamente chiusa da blocchi squadrati e calce, che può essere riconosciuta anche sulla scarpata esterna.
Pochi metri ancora, abbastanza ingombri di detriti, poi un masso squadrato blocca il transito. Aggirando dall’esterno la parete, scendendo al lago e poi inerpicandosi per una ripida scarpata, è stato dagli scriventi trovato un avvallamento, che, dopo una rapida disostruzione, ha permesso di ritornare nel condotto: verso valle si è arrivati ad un puteus franato, nel quale una grossa pietra della chiusura superiore, crollando, ha costituito l’ostacolo che sbarra il transito. Un piccolo foro laterale ha permesso un preciso collegamento topografico tra i caposaldi 0 e 300.
Si passa quindi alla Tav. 3. La galleria procede con ampi serpeggiamenti; tra 303 e 100 occorre strisciare, poi la galleria torna normalmente percorribile; al di sopra la rupe verticale si trasforma progressivamente in un pendio via via meno ripido.
In 103 si incontra sulla destra un’altra finestra murata, poi, in 105, 106 e 110, tre putei alti pochi metri, i primi due ancora chiusi con le pietre originarie, il terzo aperto. La roccia qui non è più compatta come più a valle: in due tratti i costruttori dovettero rinforzare la volta con pietroni posti a cappuccina, in parte ora crollati; in un altro tratto il soffitto è parzialmente caduto in epoca successiva all’abbandono.
Infine in 111 il condotto sbocca all’aperto; per i successivi m 40 ca. la struttura è franata, si riconoscono qua e là tracce delle pareti. In 205, di fianco all’ingresso di una grotta naturale, strisciando si rientra nel condotto; dopo poco si passa alla base di un corto puteus che sbocca all’aperto, quindi il condotto curva a sinistra e continua praticamente diritto per m 100.
Si incontrano due putei, il primo semifranato e semiaperto, il secondo ostruito; infine si sbocca sulla massicciata ferroviaria. Per alcuni metri il soffitto è costituito dai soliti blocchi posti a cappuccina; nell’ultima ventina di metri le pareti sono rinforzate da muratura, dato che la roccia è molto spugnosa e friabile.
In tutto il tratto dal caposaldo 300 al 200 è stato possibile procedere dopo aver eseguito alcune semplici disostruzioni: v’è pertanto motivo di credere che questi condotti non fossero conosciuti precedentemente, tranne lo sbocco finale, citato e quotato dall’Ashby.
Al di là della linea ferroviaria il condotto prosegue, ma appare interessato da crolli vistosi (la superficie esterna è vicinissima) che ne hanno sconsigliato l’esplorazione.
Per quanto concerne il tracciamento generale, è interessante notare che, finché il condotto risulta scavato a partire da "finestre" laterali, esso presenta ondulazioni planimetriche, che diventano più accentuate là dove la rupe soprastante si fa più alta e precipite, mentre è quasi perfettamente rettilineo dove gli accessi sono costituiti da corti pozzi verticali.
Nel disegno del profilo longitudinale, in mancanza di strumenti di livellazione molto precisi, che sarebbero stati di difficile impiego lungo i frequenti tratti intasati da detriti, si è rivelata preziosa la livellazione esterna fatta eseguire a suo tempo dall’Ashby, grazie alla quale è stato possibile tracciare le gallerie con una precisione adeguata alla scala del disegno.
8. Le cisterne
All’interno del convento di S. Cosimato sono note da tempo due cisterne romane: sotto il pozzo al centro del chiostro e nella cantina. Durante i lavori di sistemazione del viale d’accesso alla chiesa, lo scavo per la fondazione di un lampione ha sfondato la volta di un ambiente ipogeo. Il Padre Guardiano ha provveduto a far recintare l’apertura, scendendo dalla quale è stato possibile accedere ad un ambiente di pianta rettangolare (m 7,6x4,2), alto m 1,9 ca., interamente scavato nella roccia solo qualche decimetro sotto alla sua attuale superficie esterna, con la volta sorretta in centro da tre pilastri quadrati di roccia in situ. Le pareti risultano rivestite di intonaco impermeabile; infatti, il locale è riempito per metà altezza di acqua. All’estremità opposta allo sfondamento si nota sulla volta la presenza di un puteus quadrato e chiuso da lastre di pietra; di fianco all’accesso invece esiste un grande conoide detritico che occupa quasi metà della pianta e sale in un punto fino alla volta.
La forma e la tipologia dello scavo sono tipiche delle cisterne romane; non è stato rinvenuto alcun canale adduttore, ma è da considerarsi che buona parte dell’ambiente è mascherato dal conoide detritico; in un punto dalla volta pende un paletto di ferro, la cui funzione non è stata compresa.
La cisterna [C1] risulterebbe essere stata rinvenuta già agli inizi del secolo (GIULIANI 1966), ma non fu studiata: il conoide detritico corrisponde probabilmente al punto allora sfondato e subito richiuso senza preoccuparsi di esaminare l’interno. Attualmente ci si è limitati ad un rilevamento topografico sommario in scala 1:100 (v. fig. 1, particolare 1) e qualche fotografia, perché per un esame più approfondito sarebbe necessario procedere alla rimozione dei detriti che ingombrano la cisterna. Alla conclusione dei lavori di ripristino del viale d’accesso e del piazzale l’apertura attuale sarà protetta con un tombino che ne consenta in seguito l’accesso.
In prossimità della porta d’ingresso al convento e a poca distanza dal portico della chiesa si trova un puteale ottagonale, in pietra, ritenuto sostanzialmente coevo delle arcate rinascimentali del portico (CRIELESI 1995, p. 87). In occasione dei suddetti lavori, rimossa la rete che chiudeva al fondo la vera del pozzo, è stato possibile accedere alla sottostante cisterna [C2], risultata di forma circolare (diam. m 3,2, alt. m 2,5 ca.), con volta ribassatissima a segmento sferico.
Il pozzo è posto in posizione completamente eccentrica; un’enorme quantità di detriti gettativi dentro ha creato un conoide che occupa pressoché tutta la pianta ed arriva quasi ad occludere l’accesso. Lo spazio restante risultava, al momento della prospezione, allagato per oltre un metro, ma l’acqua proveniva per infiltrazione dai lavori in corso sulla facciata della chiesa e non dalla fistula di coccio, presente sulla parete quasi all’altezza dell’imposta della volta; la sua posizione denota una probabile antica alimentazione proveniente dai tetti del convento o della chiesa, andata fuori uso già da molto tempo.
Anche di questa cisterna è stato eseguito il rilievo, in scala originaria 1:50, ridotto poi ed unito a quello della cisterna romana (fig. 1, particolare 2), ma anche in questo caso uno svuotamento sarebbe necessario per procedere ad un esame più completo del manufatto che, come tipologia, si accosta al periodo storico a cui risale il puteale esterno.
9. La condotta presso il convento
Durante i lavori di disgaggio e di potatura della vegetazione cresciuta in modo eccessivo sulle scarpate sottostanti il convento, gli speleologi del Gruppo Grotte Saronno del C.A.I. hanno scoperto lo sbocco in parete di un cunicolo [C] che è stato da loro esplorato e topografato in scala originaria 1:100 (v. fig. 2). Il cunicolo termina in frana in assoluta prossimità del muro posteriore del convento, là dove le sue fondazioni presentano una struttura con evidenti tracce di riutilizzo delle sostruzioni di un’antica villa romana (CRIELESI 1995, p. 116).
Il cunicolo risulta:
- scavato nella roccia ma a minima profondità (m 2-3 ca.);
- fortemente interrato, pertanto non è stato possibile stabilirne l’altezza originaria;
- la larghezza è compresa tra cm 50 e 80;
- la volta è sostenuta da pietre squadrate poste a cappuccina, in modo analogo (anche se ben più grezzo) a quanto si osserva nei sottostanti acquedotti;
- le pareti non risultano intonacate;
- la pendenza, misurata alla volta (dato che il pavimento originario non è visibile), risulta del 6% circa.
Trattasi dunque verosimilmente di un condotto di scarico che dalla villa romana portava le acque a gettarsi nella rupe.
Il sistema fognario, funzionante nel convento fino a poco tempo fa, è distinto da questo cunicolo, anche se si diparte a pochi metri di distanza, ma non è stato possibile eseguirne una ricognizione interna, perché risulta tuttora allagato da acque putride stagnanti.
10. Le cappelle rupestri
Nella parete della rupe sottostante il convento sono scavati due gruppi di cavità, impostate su grotte naturali in parte ampliate e squadrate artificialmente, già note da tempo immemorabile, e topografate una prima volta da noi nel lontano 1990 e descritte, per quanto concerne gli aspetti storici ed artistici, in Crielesi (1995, pp. 121-129).
In verticale sotto la parete esterna della chiesa si trova il primo gruppo (v. fig. 3), che comprende, scendendo dall’ingresso che è posto di fianco alla facciata della chiesa: un’ampia cavità naturale ([83 La] Grotta dei Saraceni), la cui parte più interna, intatta, permette di ammirare l’intricata struttura dell’ammasso travertinoso costituito dalla saldatura di migliaia di stalattiti e stalagmiti calcaree.
La parte anteriore presenta in alto un pozzo-camino, chiuso superiormente da lastre di pietra e posto nel piazzale antistante la chiesa in prossimità della cisterna romana, dal quale in passato furono gettate migliaia di ossa umane che la tradizione attribuisce ai caduti di un’importante battaglia tra Cristiani e Saraceni combattuta nei pressi nel 916, ma, più probabilmente, provenienti dalle sepolture dei morti durante le pestilenze del 1500-1700. Un pertugio consente di scendere per qualche metro tra le ossa: probabilmente esisteva anche un ambiente inferiore tuttora totalmente intasato.
Proseguendo in discesa lungo il sentiero, si incontrano altri piccoli ambienti modificati dall’uomo e quindi una cappella [SM], chiusa da muratura con porta e finestra soprastante, intitolata a S. Michele Arcangelo (fig. 3, sezione 11-12), abbellita da interessanti affreschi; la sua forma indica però una probabile origine di epoca romana.
Davanti ad essa sprofonda nel suolo una galleria fortemente inclinata [D], con gradini scavati nella roccia (sezione 9-10), che termina intasata da detrito, la cui funzione rimane per ora sconosciuta.
Più in basso scendeva una lunga scalinata incisa nella roccia; purtroppo, durante i lavori dell’impianto idroelettrico sottostante, la continuità della discesa è stata interrotta facendo crollare buona parte della parete. Si vedono ora alcuni gradini sospesi nel vuoto e, più in basso, l’imbocco di un condotto che costituiva la parte terminale della discenderia: è la cosiddetta "Scala dei Frati" [sf] topografata in tav. 2, che consentiva ai monaci eremitici e poi ai frati del convento di andare ad attingere acqua o lavare i panni al fiume.
Trattasi di un’opera abbastanza impegnativa che nel tratto terminale porta le tracce di un condotto originario troncato dall’arretramento della parete con un suo rifacimento collaterale: dunque di probabile origine romana quale via d’accesso, per la manutenzione, ai sottostanti acquedotti. La sua recente distruzione, come l’interruzione degli acquedotti, è stata un’azione inutile, evitabile e deprecabile, perché ha mutilato l’antica struttura di elementi che sarebbero stati preziosi per la sua comprensione.
Il secondo gruppo di cavità viene raggiunto invece da una scala che inizia in fondo al giardino del convento con una galleria artificiale in ripida discesa; in antico si accedeva invece da una scala incisa nella roccia qualche metro più a Sud-Est, ancora riconoscibile ma non più utilizzabile. Anche queste cavità furono da noi topografate nel 1990 (v. fig. 4).
Appena terminata la discesa moderna, si incontra un sistema di piccole cavità naturali [BB] nelle quali si riconoscono un altare, alcune vaschette e nicchie e il luogo di ritiro del Beato Bonaventura (altare, giaciglio). Scendendo il ripidissimo e vertiginoso sentiero, si raggiunge quindi un complesso di edifici realizzati in modo da incorporare altre piccole cavità, che comprende la cappella di S. Benedetto [SB], con interessanti affreschi, ed alcuni ambienti accessori, più piccoli.
Lungo il percorso si notano alcune concamerazioni che, pur essendo d’origine naturale, portano inequivocabili tracce di un’utilizzazione umana.
La tradizione vuole che già prima della venuta di S. Benedetto (poco dopo il 500 d. C.) vi fosse a S. Cosimato un insediamento monastico-eremitico; tale consuetudine si è protratta per molti secoli e certamente varie grotticelle in parete sono anche servite da rifugio ai monaci durante le invasioni saracene e le numerose sanguinose guerre dei secoli successivi.
Infatti gli amici lombardi, procedendo nelle operazioni di disgaggio della scarpata, hanno trovato numerose grotticelle portanti chiari segni di un’utilizzazione passata; in fig. 5 (metà inferiore) è presentato il rilievo di una coppia di cavità [GS], a cui (con prudenza!) si può ancora accedere scendendo una scaletta incisa nella roccia (e, per l’occasione, ripulita dai detriti che la mascheravano): un lungo sedile e varie nicchie parietali testimoniano di un passato insediamento. Varie altre grotticelle sono state raggiunte e visitate, ma non ancora topografate; qualcun’altra è stata vista calandosi dall’alto con la corda, ma non è stata raggiunta perché si apre in punti in cui la parete è aggettante per vari metri e oggi, quindi, vi si potrà arrivare solo con complesse manovre di chiodatura della roccia.
Spostandosi più a Est, dove la parete da verticale comincia a trasformarsi in una scarpata prima ripida, poi più dolce, oltre ad altre grotticelle è stato rinvenuto un cunicolo di captazione [S1] di una sorgentella, oggi prosciugatasi, sintomo che, cessato il funzionamento delle cisterne per il crollo degli antichi edifici, gli eremiti necessitavano di un approvvigionamento idrico alternativo.
Un altro cunicolo analogo [S2] si trova sotto la cappella di S. Michele Arcangelo e il suo rilievo appare nella tav. 1: un antico sentiero, ora percorribile solo con molta prudenza, permetteva di raggiungerlo partendo di fronte all’ingresso della cappella.
Un’ultima grotta con tracce di insediamento religioso [GP] è stata infine reperita molto più ad Est, nel bosco, al di sopra di una vasta spianata creata in epoca antica (forse per cavare il travertino necessario alle varie costruzioni e opere idrauliche) tagliando verticalmente la parete di roccia: anch’essa è stata topografata (fig. 5, metà superiore).
11. Conclusioni
Le indagini qui descritte hanno portato:
- a conoscere meglio il sistema di acquedotti romani nella rupe di S. Cosimato e, in particolare, del numero e successione dei loro rifacimenti resi necessari dai dissesti della parete esterna;
- ad identificare chiaramente l’esistenza di un terzo condotto, di pochissimo più basso dell’Aqua Marcia e ad essa praticamente parallelo, che proviene da più a monte e non ne costituisce pertanto un diverticolo;
- ad ipotizzare, allo stato attuale delle conoscenze, che si tratti del condotto originario dell’Aqua Marcia (144 a.C.), sostituito in epoca imperiale dalle gallerie che oggi, normalmente, si visitano.
- ad incrementare le conoscenze dei sistemi idraulici connessi all’antica villa romana, ricca di cisterne, dato che, per la sua posizione, difficilmente poteva essere alimentata da acqua fluente;
- al ritrovamento di un sistema di drenaggio.
In questi ultimi due punti le ricerche ed esplorazioni sono però ancora lontane dalla conclusione, che, tuttavia, richiederebbe impegnative opere di asportazione di ostruzioni detritiche.
Il sistema dei romitori rupestri tardo-romani e alto-medioevali comincia a riemergere da un oblio, conseguenza della mancanza di documentazioni scritte coeve, e si mostra in tutta la sua complessità e vastità: anche questo studio deve però essere considerato solo ai suoi inizi.
12. Ringraziamenti
Il presente lavoro è stato incoraggiato dall’aperta e fattiva accoglienza da parte dei Frati Francescani del convento di S. Cosimato (olim SS. Cosma e Damiano); la nostra gratitudine va particolarmente ai Padri Carlo e Claudio; ma è stato reso possibile solo dalla collaborazione nelle operazioni di esplorazione, disostruzione e documentazione topografico-fotografica degli amici di Saronno (Angelo Zardoni, Mauro Breme, Giovanni Cattaneo, A. Gigliuto, R. Basilico), di Milano (Silvio Gori, Daniela Cavalli-Gori), di Roma (Tullio Dobosz, Fernanda Vittori e nostro figlio Emanuele) e di Subiaco (Angelo Procaccianti, Elia Mariano, Luigi Pomponi). Gli autori ringraziano anche i professori C. F. Giuliani e Z. Mari per la revisione critica del presente manoscritto.
13. Bibliografia
FRONTINUS, De aquaeductu urbis Romae, edizione integrale e critica di F. Krohn O.S.B., Lipsia 1922.
T. ASHBY, The Aqueducts of Ancient Rome, ed. postuma a cura di I. A. Richmond, Oxford 1935, (edizione italiana: Gli Acquedotti dell’antica Roma, Roma 1991).
C. F. GIULIANI, Tibur, pars altera, "Forma Italiae" I, 3, Roma 1966.
C. RONCAIOLI LAMBERTI, La Marcia e la Claudia nella gola di S. Cosimato, in Il trionfo dell’acqua, Roma 1986.
Z. MARI, La valle del Licenza in età romana, Atti del convegno di Licenza, Venosa 1994.
A. CRIELESI, Il Complesso Conventuale di San Cosimato, Roma 1995.
© 1997 by Alberta Felici e Giulio Cappa