
Maestri greci del pensiero
I
presocratici
All'inizio, molto tempo prima che si
distinguessero branche specifiche di pensiero, veniva compreso nella filosofia
anche lo studio della natura e dei fenomeni fisici, e in un certo senso anche
quello della medicina.
Sono conosciuti con il nome di
presocratici i filosofi che vissero e operarono prima di Socrate, tra il VI e il
V secolo a.C. Spesso l'unica cosa che li accomuna è l'aggettivo con il quale
vengono definiti, poiché ognuno di essi sviluppò un pensiero originale.
I due centri principali di sviluppo
del pensiero filosofico sono le colonie della
Magna Grecia
e quelle della Ionia.
La Magna Grecia: Parmenide ed Empedocle
La colonizzazione greca
A Elea, in Lucania, nacque, verso la
fine del VI secolo a.C.,
Parmenide, che secondo alcune fonti potrebbe essere
stato allievo di
Senofane
di Colofone. Egli, nel poema La Natura (allora
si scriveva ancora in versi, ma già gli allievi di Parmenide iniziarono a
scrivere di filosofia in prosa), s'impegna a spiegare l'esistenza di un Essere
unico e immutabile. Nella stessa opera egli si adopera per negare che esistano
tutte le numerose cose che ci circondano. Queste, secondo la sua
interpretazione, sono frutto dell'inganno dei sensi, dell'apparenza, mentre
l'Essere unico, il Lògos, è l'espressione della verità.
I suoi discepoli,
Zenone
di Elea e
Melisso
di Samo, aggiungeranno che il Lògos è anche eterno e infinito.
Empedocle
di Agrigento (495-435
a.C.) fu, oltre che filosofo, uomo politico, medico, matematico, fisico,
ingegnere, biologo e taumaturgo. La sua personalità era, come quella di
Pitagora, avvolta da un alone di magia e di mistero. Di lui ci restano alcuni
frammenti di due poemi: le Purificazioni e il Poema fisico.
Le Purificazioni riprendono e
sviluppano la dottrina pitagorica della metempsicosi (il viaggio dell'anima da
un corpo a un altro dopo la morte), mentre il Poema fisico spiega come
tutte le cose derivino da quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Il
movimento e gli scambi tra i quattro elementi fondamentali sono causati da due
forze uguali e contrapposte: l'amore e l'odio.
Quando domina l'amore gli elementi
sono perfettamente fusi in un essere unico, lo Sfero, mentre quando domina
l'odio essi sono totalmente separati.
La prevalenza dell'uno o dell'altro
è ciclica e solo nel periodo di passaggio tra l'uno e l'altro può svilupparsi
la vita come noi la conosciamo.
I grandi filosofi ionici furono
Eraclito,
Anassagora,
Leucippo
e
Democrito.
Eraclito
nacque a Efeso nel
535 a.C. A causa delle difficoltà di comprensione che offrivano le sue brevi
frasi e per il suo insistito pessimismo gli antichi lo chiamarono "il
Tenebroso".
Per Eraclito l'universo è un tutto
unico e senza fine. La legge che governa questo tutto è il divenire, il
mutamento, la continua guerra delle cose che passano da uno stato al suo
contrario. Il fuoco è la sostanza da cui si originano tutte le altre. Secondo
il pensiero eracliteo, "tutto scorre; niente sta fermo": tanto che
nessuno può bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché, nel momento in cui
entriamo nell'acqua, quell'acqua è già cambiata, è già stata sostituita da
un'altra, per la legge dell'eterno cambiamento. L'anima è qualcosa di grande e
di insondabile, senza confini, anche se non sopravvive al corpo.
Eraclito fu un grandissimo
pensatore. Scrisse in prosa il suo libro La Natura, ma in lui c'è molta
più arte che nei poemi degli altri filosofi.
Anassagora
nacque a Clazomene
circa nel 500 a.C. e si stabilì ad Atene nel 460 a.C., diventando amico di
Pericle. Si dice che fosse stato il maestro di
Euripide
e dello storico
Tucidide.
Fu accusato di empietà per le sue teorie astronomiche, poiché, cercando una
spiegazione scientifica per ciascun fenomeno, andava contro la religione
tradizionale che spiegava ogni cosa con i miti e con l'intervento degli dèi. In
effetti il filosofo fu accusato dai nemici di Pericle, che attraverso di lui
volevano colpire lo statista ateniese. Anassagora fuggì da Atene e visse i suoi
ultimi anni a Lampsaco, in Asia Minore, dove morì circa nel 428 a.C. Anassagora
fu filosofo, astronomo e matematico. La sua opera, intitolata La Natura,
era scritta in prosa. La sua teoria più importante, in seguito ripresa da
Leucippo e Democrito, spiega come niente nasca e niente muoia: le cose possono
tutt'al più cambiare per la continua mescolanza degli elementi costitutivi, le omeomerie
(particelle simili). Ciò che ha permesso la nascita del mondo e che
costituisce la causa di ogni cambiamento è la "Mente" (Noùs,
che si legge nùs), che non è astratta, ma materiale. È materia pensante.

Democrito
di Abdera (nato
circa nel 470-460 a.C. e morto a novanta o cento anni) fu il più grande teorico
dell'atomismo, anche se la teoria da lui seguita era stata ideata da Leucippo di
Mileto, del quale però non si sa nulla.
Secondo il pensiero di Democrito,
tutte le cose sono formate da particelle impossibili da dividere, dette atomi
(letteralmente "non separabile"). Gli atomi sono eterni e infiniti, si
muovono continuamente; dagli urti, dalle separazioni e dalle unioni degli atomi
si originano i mondi e gli universi. Democrito si occupò di storia naturale,
medicina, astronomia, geografia, grammatica, storia della letteratura. Per la
sua straordinaria cultura e i suoi molteplici interessi può essere considerato
il grande precursore di
Aristotele. Le teorie di Democrito, riprese in seguito
da
Epicuro
e dal poeta latino
Lucrezio, influenzeranno il pensiero greco sino
alla fine dell'Ellenismo e saranno presenti anche nella cultura di Roma antica.
Al servizio della medicina 
Ippocrate, nato a Cos nel 460 a.C. e
morto a Larissa nel 377 a.C., fu il più grande medico dell'antichità. Liberò
la medicina dalle credenze magiche e pose le basi della medicina moderna,
fondata sull'osservazione del caso clinico e del paziente. Di lui resta una
raccolta di scritti di medicina, densa di osservazioni spesso geniali, alcune
delle quali ritenute ancora valide dalla medicina moderna. Ippocrate insegna a
osservare il malato continuamente e con pazienza al fine di scoprire l'origine e
il decorso della malattia. Ippocrate scrisse gli Aforismi e l'operetta L'aria,
le acque e i luoghi, in cui studia il legame tra clima e salute e
per la prima volta afferma la teoria secondo la quale il clima ha influenzato le
caratteristiche dei vari popoli. Il suo codice di comportamento medico è il
fondamento del giuramento, detto appunto giuramento di Ippocrate, che
ancora oggi i medici prestano quando iniziano la loro attività.
I sofisti concentrarono il loro
interesse non più sul mondo e la sua origine, ma sull'uomo. Introdussero il
dubbio e la discussione in una cultura che non poteva più restare ancorata a
grandi e false certezze. Tutti i sofisti insegnavano a pagamento le loro
dottrine in appositi corsi. Su di loro pesò il pessimo giudizio di
Platone
e di
Aristotele, che definirono la sapienza dei sofisti apparente e non reale. Oggi,
in gran parte delle lingue moderne, il termine sofista è sinonimo di persona
che inganna con i discorsi, di manipolatore della verità.
I sofisti, anche se non si
presentavano come difensori della morale e non dimostravano una grande
aspirazione al bene, esercitarono un'enorme influenza sul pensiero greco e su
quello successivo, anche perché loro caratteristica primaria era il fatto di
impegnarsi in dispute su qualsiasi argomento, senza eccezioni. Furono grandi
maestri di eloquenza e di dialettica, diedero avvio alla critica letteraria e
allo studio della grammatica. Attraverso di loro i greci impararono a esprimersi
con sottigliezza, ad affrontare idee controverse, a convivere con i dubbi.
I sofisti di maggior successo furono
Protagora, Gorgia,
Prodico, e inoltre
Trasimaco,
Ippia e
Antifonte.
Di certo esemplari del pensiero
sofistico sono due teorie, rispettivamente di Protagora e di Gorgia. Il primo
sosteneva che "l'uomo è misura di tutte le cose": con questa frase
restituiva importanza all'essere umano, allontanando le dispute sulle "cose
divine".
L'altro, estremizzando il dubbio e
la convinzione sofista che non esiste una verità e che in ogni caso è inutile
cercarla, affermava che "niente esiste; anche se esistesse non si potrebbe
conoscere; se anche si potesse conoscere, non si potrebbe comunicare".
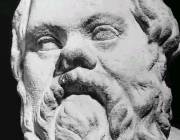
Socrate, vissuto ad Atene tra il 470
e il 399 a.C., non ci ha lasciato neppure una riga del suo pensiero. Tutto ciò
che sappiamo delle sue teorie filosofiche ci arriva da
Platone, il suo grande
allievo: eppure egli ha a tal punto influenzato il pensiero umano che ancora
oggi rimane sicuramente uno dei filosofi più noti, forse il più famoso in
assoluto.
Socrate fu erroneamente annoverato
fra i sofisti, ma non fu mai tale. Egli non si reputava, come i sofisti, un vero
sapiente; anzi sosteneva di non sapere nulla. Inoltre non accettava compensi in
denaro per i suoi insegnamenti.
Come i sofisti però accettava ciò
che appariva evidente alla ragione.
Socrate non si interessò d'altro
che dell'uomo e di ciò che è bene per lui. Per questo discuteva con tutti
applicando i metodi di sua madre, che era levatrice (in greco quest'arte era
detta maieutica): Socrate aiutava le menti a partorire pensiero. Socrate
usava sempre l'ironia, perché l'uomo deve sorridere dei suoi limiti e anche dei
suoi drammi.
Egli diceva di avere un demone che
lo ispirava e lo seguiva: un essere poco simile alla coscienza e molto simile a
Dio come noi lo intendiamo.
Come raccontano Platone e
Senofonte,
nel 399 a.C. Socrate, che ormai aveva un largo seguito ad Atene, fu accusato di
corrompere i giovani, di non venerare gli dèi della sua città e di introdurre
ad Atene il culto di nuove divinità.
Subì un processo e fu condannato a
morte. Socrate, che rispettava le leggi e i tribunali della sua città, anche se
in quel caso erano stati manifestamente ingiusti, non fuggì dal carcere quando
gli offrirono la possibilità di salvarsi e bevve la cicuta (un'erba velenosa
che si dava ai condannati). La morte sopraggiunse mentre conversava
tranquillamente con i suoi amici.

Platone
(Atene, 427-347 a.C.), il più
grande discepolo di Socrate, partecipò attivamente alla vita politica del tempo
e viaggiò molto, soprattutto in Magna Grecia. Nel tempo in cui viveva, agitato
da guerra e tirannia, egli sviluppò l'ideale politico di una repubblica
governata dai sapienti, fondata sul sapere e sulla giustizia. Platone fondò ad
Atene una scuola filosofica, l'Accademia, che era il prototipo delle odierne
università.
Gli scritti platonici giunti fino a
noi comprendono l'Apologia di Socrate, una raccolta di 13 Lettere
e 34 Dialoghi. Ogni dialogo è dedicato a un argomento diverso e,
attraverso una conversazione tra due o più persone, viene spiegato un aspetto
delle sue teorie filosofiche.
I dialoghi sono divisi in tre grandi
gruppi: dialoghi giovanili o socratici, che comprendono Apologia di Socrate,
Critone, Protagora, Alcibiade I, Ipparco, Ippia
Minore, Liside, Carmide, Lachete, Eutifrone e Ippia
Maggiore; dialoghi della maturità o costruttivi, che comprendono Gorgia,
Menone, Eutidemo, Cratilo, Ione, Menesseno, Repubblica,
Fedone, Convito, Fedro; dialoghi della vecchiaia o
dialettici, che comprendono Teeteto, Parmenide, Sofista, Politico,
Filebo, Timeo, Crizia, Leggi, Lettere.
Platone sosteneva l'esistenza di un mondo abitato da entità non materiali e
perfette, le Idee, contrapposto al mondo in cui viviamo. Gli esseri umani,
materiali e imperfetti, possono comunque aspirare alla conoscenza delle idee e
della verità in esse racchiusa. Platone, per spiegare le sue teorie, usava
spesso dei miti. La nostra capacità di conoscere le idee, dice Platone, è
simile a quella di un prigioniero legato in fondo a una caverna, con il viso
rivolto verso la parete. Egli vede solo le ombre del mondo esterno. Se si libera
ed esce, prima non riuscirà a distinguere le cose vere per la grande luce, ma
infine vedrà chiaramente le cose e il sole della verità che le illumina. Per
questo Platone condannò l'arte: le opere d'arte rappresentano una visione falsa
delle cose materiali, che sono già di per se stesse prive di verità. L'anima,
secondo il filosofo, è immortale. È come una biga guidata da due cavalli, uno
bianco, docile, e uno nero, selvaggio. Quando il cavallo nero si imbizzarrisce,
trascina giù con sé anche il bianco, e l'anima si incarna e scende verso il
basso, sulla Terra.
Quando l'uomo, nella vita, ricerca
la verità e la conoscenza, la sua anima riprende a salire e, dopo la morte del
corpo, può sperare di ritornare nel mondo delle idee. Altrimenti, deve
ritornare sulla terra a perfezionarsi.
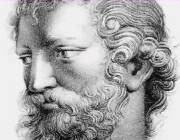
Aristotele
(Stagira, 384 a.C. -
Calcide, 322 a.C.) fu il più grande allievo dell'Accademia. Tale era la sua
fama di sapiente che
Filippo II
re di Macedonia lo chiamò come precettore del
figlio Alessandro, il futuro
Alessandro
Magno, sul quale Aristotele esercitò
una grande influenza. Tornato ad Atene, Aristotele vi fondò la sua scuola, il Liceo
(chiamata così perché sorgeva vicino al tempio di Apollo Liceo), detta in
seguito peripatetica a causa dei vialetti (in greco perìpatoi) in cui si
svolgevano le lezioni. Aristotele vi teneva due tipi di corsi: la mattina
quelli più difficili per gli studenti di filosofia, il pomeriggio quelli più
facili per un pubblico meno preparato. Anche gli scritti di Aristotele erano di
due tipi: quelli più complessi, esoterici, destinati solo alla scuola, e
quelli più semplici, exoterici, destinati alla divulgazione. Noi
conosciamo solamente gli scritti esoterici, ovvero quelli che contengono
le più complesse ed evolute teorie del maestro.
Delle opere pubblicate ci restano
solamente i titoli e alcuni frammenti, da cui tuttavia si intuiscono la
ricchezza e la varietà degli interessi del grande filosofo. L'unica opera
destinata alla pubblicazione che ci sia giunta quasi integra è la Costituzione
degli ateniesi, che descrive la storia e le istituzioni della città di
Atene, ma la cui autenticità è messa in discussione.
Le opere esoteriche a noi giunte si
possono dividere in cinque gruppi: opere di Logica; opere di Scienze
Naturali, tra le quali spicca la Fisica; la Metafisica, in cui
si descrive il Motore Immobile, ossia l'entità che muove, senza alcuna
fatica, tutto l'universo; opere di Etica e di Politica, nelle
quali Aristotele sostiene che l'uomo è un animale politico, nato cioè per
vivere nella società; Retorica e Poetica. Aristotele, nella Poetica,
spiega come l'arte stia non nella perfetta imitazione (in greco mìmesis)
della realtà, ma nella rappresentazione verosimile di come le cose potrebbero
essere. Il poeta e lo storico non sono diversi perché uno scrive in versi e
l'altro in prosa, ma in quanto il primo parla di come le cose potrebbero essere
e il secondo di come si sono realmente verificate.
La poesia è un qualcosa di più
universale della storia giacché si basa su concetti validi per tutti. La forma
d'arte più interessante è, secondo Aristotele, la tragedia, per merito della
quale, attraverso la visione di cose orrende e indicibili, l'anima giunge alla purificazione
(in greco catàrsi). In Aristotele c'è, in embrione, il concetto moderno
dell'arte che libera lo spirito.
La filosofia aristotelica ebbe
un'immensa fortuna nei secoli, soprattutto nel Medioevo per opera di Tommaso d'Aquino,
che la utilizzò come fondamento della teologia cattolica. Dopo Aristotele, la
guida del Liceo fu presa da Teofrasto (323-287 a.C.), autore dei Caratteri,
un'opera che contiene la descrizione, spesso acuta e divertente, di 30 diverse
personalità (l'avaro, il vanitoso, lo spaccone...).