|
|
|
La terza parte del nostro viaggio nel mondo della ‘Great Black Music’ si conclude con una discografia consigliata, compilata da Etero Genio e pubblicata sul n. 31 (Dic. 2000) del mensile Blow Up — Rock e altre contaminazioni.
La discografia è divisa in due parti: una rosa di dieci dischi 'fondamentali', più un'altra trentina di titoli, fondamentali per orientarsi in una produzione 'febbrile' come quella dei musicisti trattati nei precedenti capitoli.
Non tutti sono dischi facilissimi da reperire, quindi se non trovate 'tutto subito', abbiate pazienza (e soprattutto attendete le ristampe, oggi uno dei settori più prolifici del business musicale….). Ma soprattutto, cercate e ascoltate. Vi garantiamo che ne vale veramente la pena.
|
 |
 |
ROSCOE MITCHELL SEXTET
Sound (Delmark, 1966)
La prima assoluta su vinile di un gruppo espresso dall'AACM fa atto di devozione al free jazz - Ornette è il titolo del primo brano - e prende contemporaneamente le distanze da esso.Accostamenti timbrici azzardati, con utilizzo di strumenti alieni alla tradizione jazzistica come l'armonica, e un'attenzione tutta nuova per i particolari sono gli elementi principali che differenziano "Sound" dalla corrente al tempo imperante nel pianeta della musica afroamericana improvvisata. L'alternanza di atmosfere grottesche, The Little Suite, e drammatiche, Sound, prefigura già quella che sarà l'Art Ensemble Of Chicago, d'altronde il sestetto comprende il trombettista Lester Bowie e il contrabbassista Malachi Favors, insieme a Mitchell colonne portanti del collettivo prossimo a venire; soprattutto la lunga title-track, definita nelle note di copertina come una preghiera funebre, contiene al suo intemo tutta la malinconia di un 'popolo afflitto', malinconia che l'Art Ensemble saprà in futuro cantare così lucidamente in più di un'occasione (People in Sorrow, Unanka...). Ma oltre all'uomo dedito al gioco di squadra, "Sound" contiene in nuce anche il grande musicista, l'improvvisatore fantasioso e avventuroso che nell'agosto del 1976 fiaccherà il pubblico di Willisau con un'estenuante escursione nei parametri della ripetitività (Nonaah) e il raffinato compositore che solo due anni dopo saprà concepire una pagina di ineguagliabile bellezza come The Maze, evoluto esempio di scrittura per sole percussioni. Volendo citare gli altri componenti il sestetto dovremo iniziare dal sassofonista tenore Maurice McIntyre (lo stesso Kalaparusha che incontreremo più avanti in queste stesse schede), per proseguire con il trombonista / violoncellista Lester Lashley, strepitoso strumentista troppo presto scomparso dalle scene, e terminare con il percussionista Alvin Fielder (elemento proveniente dall'entourage di Sun Ra). Anche se all'epoca della sua uscita il disco passò inosservato, la presentazione pubblica dell'AACM non poteva essere migliore.
|
|
ANTHONY BRAXTON
For Alto (Delmark, 1968)
Disco ampiamente sottovalutato che raccoglie una manciata di registrazioni casalinghe effettuate da Braxton sul solo sassofono e apre una pagina nuova e fondamentale nella storia della musica improvvisata, quella dell'introspezione solitaria.Sette tracce dedicate ad altrettanti strumentisti, compositori e/o amici dell'autore, il quale, rendendo omaggio nel secondo brano del disco - una delle rare concessioni all'estetica rabbiosa del free - al Compositore John Cage, dimostra maggiore duttilità di molti suoi estimatori. Tale contingenza, unita alle influenze — da Karlheinz Stockhausen fino a James Brown - dichiarate da Braxton nella copertina del precedente "3 Compositions Of New Jazz", ci permette una breve digressione; la domanda che sorge spontanea è infatti quanto 'soul' contenga la sua musica e quanto invece la sua anima sia andata persa nell'ammirazione per i due musicisti dell'area contemporanea 'colta'. La nostra risposta è che il potenziale soul di questa musica è pari a quello rinvenibile nella musica di Brown, sta all'ascoltatore saperlo cogliere; d'altronde il concetto stesso di 'anima' è molto relativo: i cattolici ritengono che sia prerogativa degli esseri umani, per gli indiani d'America alitava in tutti gli esseri viventi (compresi alberi, fili d'erba e la stessa Terra), gli 'atei più incalliti' non danno invece alcun credito a tale concetto. Ma torniamo a "For Alto", un disco che come dicevamo apre nuovi orizzonti alla musica improvvisata; va da se che tali orizzonti si portano appresso oro e scorie, fra queste ultime il deplorevole costume, adottato da tanti strumentisti privi oltretutto della stazza necessaria, ad affrontare l'esibizione solitaria solo perché più vantaggiosa economicamente.
Ma le scorie, come l'anima, appartengono a qualsiasi tipo di cibo, indipendentemente dalla sua prelibatezza, non facciamocene quindi cruccio e concentriamoci sugli aliti poetici di To My Friend Kenny McKenny, To Multi-Instrumentalist Leroy Jenkins, To Artist Murray De Pillars e Dedicated To Ann And Peter Allen, quest'ultima con il battito delle dita sui tasti a creare un contraltare ritmico all'incorporea essenza della melodia, autentiche panacee contro tutti i mali. Uno dei dischi più importanti di tutto il '900.
|
 |
 |
KALAPARUSHA (MAURICE McINTYRE)
Forces And Feelings (Delmark, 1972)
Kalaparusha Ahra Difda è un personaggio enigmatico, forse più dello stesso Sun Ra; nato nel 1936 nell'Arkansas giunge solamente nel 1969 all'esordio discografico con "Humility In The Light Of The Creator", ciò dopo aver preso contatto ed esser divenuto membro effettivo dell'AACM. Piccolo gioiello all'interno di una produzione quantomai scarna, questo suo secondo disco solista è il più rappresentativo di una concezione musicale estatica, sospesa fra cielo e terra, che supera per forza contemplativa lo stesso Coltrane, nei confronti del quale è possibile stendere più di un parallelo; nello stesso tempo il suono del sassofono di McIntyre possiede però una forza grezza e selvaggia paragonabile a quella di Albert Ayler. Al fianco del leader si distingue la cantante Rita Omolokun, che tesse i suoi vocalizzi eterei sopra la giungla ritmica creata da Wesley Tyus e dallo stesso Kalaparusha, una cometa presto scomparsa nel nullacosì come il chitarrista Samie Garrett, perfetta spola fra Charlie Christian e Jimi Hendrix. Chi ritroveremo a illuminare decine di altre situazioni è invece il contrabbassista Fred Hopkins, rigoroso contraltare all'interno dell'AACM di quella figura dal volto dipinto e dal suono classicamente 'nero' che è Malachi Favors (a differenza di quest'ultimo, Hopkins ha compiuto studi classici). Una musica ad alto tasso psichedelico, quella di "Forces And Feelings", orfana dell'estate californiana: questo soprattutto nelle incantevoli melodie di Fifteen Or Sixteen e Manda, mentre Sun Spots dispiega un'energia più tipicamente free e, nel secondo lato, Twenty One Lines e Behold! God's Sunshine! riassumono a meraviglia le due tendenze con i loro improvvisi rovesciamenti di fronte. Certo, orfana dell'estate californiana e corrispettivo afroamericano di quell'altro splendido sogno mistico-ancestrale che fu la Third Ear Band.
|
|
LEROY JENKINS/THE JAZZ COMPOSER'S ORCHESTRA
For Players Only (JCOA Records, 1975)
"For Players Only" rappresenta, insieme a "Creative Orchestra Music 1976" di Anthony Braxton, l'espressione più compiuta della ricerca orchestrale effettuata da musicisti appartenenti all’AACM. Commissionata nel 1974 dalla prestigiosa Jazz Composer's Orchestra, viene concretizzata dal violinista Leroy Jenkins come blocco unico orientato all'esplorazione del parametro spaziale, laddove Braxton preferirà orientare la sua ricerca in un ampio ventaglio di ipotesi stilistico-temporali. Jenkins divide l'orchestra in quattro sezioni distinte e paritetiche, ance <–> ottoni <–> percussioni & contrabbasso ritmico <–> strumenti a corda, ognuna di esse è dislocata su un angolo diverso di uno spazio-quadrato, mentre al centro prendono posto l'autore stesso, che dirige e suona il violino, e il sintetizzatore di Romulus Franceschini; purtroppo la riproduzione in vinile, registrata dal vivo al Wollman Auditorium della Columbia University di New York, fotte completamente tali presupposti di 'spazialità' del suono, presupposti chiaramente basati su una diffusione quadrofonica. Ma veniamo all'estetica della musica, in certo qual modo drammatica, e alla sua struttura che contempla sia chorus melodici sia veementi intrecci free, fino ad aprirsi su spazi sconfinati di pura malinconia. La sezione finale è poi dedicata a una serie di concise autopresentazioni soliste dei 18 musicisti, iniziando con Leo Smith e terminando con lo stesso Jenkins. "For Players Oniy" rimane una pagina fondamentale nell'evoluzione della musica afroamericana, in quanto esemplare nell'unire scrittura e improvvisazione, strumenti elettrici, acustici ed elettronici, oltreché nel contributo, forse sterile ma pur sempre vivo, dato al rinnovamento del concetto di orchestra. Da rilevare la completa assenza dei musicisti solitamente legati alla JCOA mentre largo spazio è concesso alla rappresentanza dell'AACM stessa , uno spirito di corpo (unito all'apertura e alla disponibilità a lavorare con chiunque) che lascia intuire il perché della capillare penetrazione dell'organizzazione nel tessuto sonoro dei '70.
|

Leroy Jenkins
|
 |
‘MUHAL' RICHARD ABRAMS
Sightsong (Black Saint, 1976)
Soprannominato dai colleghi 'MuhaI', cioè 'il primo', Abrams, oltre ad essere una grande mente organizzativa, vanta pure un'attività di altissimo livello come musicista, in particolare per quanto riguarda il suo lavoro di pianista. Paragonato, per quanto riguarda il lirismo cristallino della sua musica, a Debussy e, per quanto riguarda invece il suo carattere enciclopedico, all'illustre concittadino Sun Ra, egli sa esprimere il meglio di sé nelle lunghe e magnetiche improvvisazioni solitarie in cui la sperimentazione viene a intrecciarsi con una continua trama di riferimenti e citazioni. In tal senso la sua discografia dei '70 è costellata di piccole grandi perle, iniziando da Wise In Time e proseguendo con "Afrisong"; ciò che ci ha spinto in direzione di queste 'canzoni immediate' è una formula, quella del duo, che in tempi diversi ha coinvolto più o meno tutti i musicisti dell'associazione, oltre al fatto che il suo pard in questa avventura è uno dei nomi che avevano dato avvio al tutto: il pianismo frizzante del titolare è infatti sorretto dallo stile contrabbassistico fantasioso e corposo di quel Malachi Favors già incontrato in "Sound" e punto fermo dell'Art Ensemble Of Chicago. A Favors, come era già avvenuto in "Congliptious" di Roscoe Mitchell (dove compariva la prima versione del suo mitico Tutankhamen), viene concesso anche un brano (Way Way Way Down Yonder) onde dare sfogo al suo talento sciamanico; più prammatico Abrams, i cui sei titoli possono essere divisi in due gruppi, da una parte quelli con un tema o una linea melodica immediatamente riconoscibili: W.W. (Dedicated To Wilbur Ware), J.G. (Dedicateci To Johnny Griffin), Two Over One e Sightsong, e dall'altra quelli in forma più libera: Panorama e Unity. La concezione atemporale del pianista emerge con tutto il suo potere destabilizzante, come può esserlo solo una musica che nel giro di poche battute ti trascina in un notturno chopiniano, in pieno stile 'stride', in un gioco di chiaroscuri tipicamente monkiano o in una nenia rubata alla propria memoria africana. Magistrale.
|
|
GEORGE LEWIS
The George Lewis Solo Trombone Record
(Sackville, 1977)
George Lewis è sicuramente il musicista più importante fra quelli formatesi all'interno dell'AACM, all'epoca incui usci questo suo disco d'esordio egli era già conosciuto presso il pubblico dell'improvvisata per aver fattoparte dei gruppi guidati da Roscoe Mitchell e Anthony Braxton, oltreché dell'orchestra di Count Basie. Ma c'è anche un altro motivo di interesse in "Solo Trombone Records": essendo il primo disco firmato da un musicista nato nell'associazione può ben essere considerato come l'esordio discografico dell'associazione stessa. Sin da queste prime battute Lewis mostra quella spregiudicatezza che gli consentirà di muoversi dal jazz più classico verso avventurose soluzioni elettroniche, possiamo quindi dire che ha pienamente recepito lo spirito che sta alla base del consorzio chicagoano. Il lato più avventuroso di Lewis emerge in Piece For Three Trombones Simultaneously, un tour de force che occupa l'intera prima facciata del disco: trattasi di uno scoppiettante gioco di prestigio, con Lewis nei panni del mago teso a cavare dal suo cappello magico ogni sorta di sorpresa, la più brillante delle quali è quella dei tre tromboni simultanei: naturalmente c'è di mezzo il trucco della sovraincisione, ma il brano appare importante non tanto per l'uso di tale tecnica, all'epoca già ampiamente sfruttata, quanto perché Lewis non guarda ad essa come motivo di abbellimento o come trucco scenico, bensì come motivo portante attorno al quale far ruotare l'intero brano (alla maniera del Bill Evans di "Conversation With Myself”).Venti minuti di triplo dialogo con se stesso che permettono una esplorazione ad ampio raggio delle possibilità timbriche offerte dallo strumento e delle tecniche ad esso applicabili. Nel secondo lato la boppistica (fin dal titolo) Phenomenology offre con il suo fraseggio veloce la possibilità di riesumare il mood di J.J. Johnson, tanto caro al giovane chicagoano, mood che viene però arricchito dall'inserzione di grottesche timbriche arcaiche. In chiusura, dopo una 'sequenza di sogno senza titolo', viene frugato nel repertorio di Ellington per estrarne la classica Lush Life, ballata immortale che lascia fluire la fantasia senza limiti del giovane rampollo.
|

George Lewis
|
 |
ANTHONY BRAXTON
For Trio (Arista, 1977)
Gli improvvisatori della 'windy city', come sottolineato nel numero scorso (della rivista cartacea, NdR), non pongono limiti alle loro possibilità espressive, tanto da recuperare anche una forma che le sommosse free avevano messo al bando: l'improvvisazione da camera. Se negli anni '50 erano stati essenzialmente i musicisti di pelle bianca - eccezione di rito con il Modern Jazz Quartet e Miles Davis - a occupare quella nicchia definita 'cool', con l'avvento della 'Great Black Music' prende avvio la sfida dei musicisti neri a cimentarsi in un terreno cosi scivoloso; ciò può apparire a prima vista una contraddizione, ma in realtà non lo è: la musica nera, proprio perché grande, può misurarsi con qualsiasi formula e/o stile. Campione di questa sfida è senz'altro Anthony Braxton, musicista simbolo della poliedricità caratteristica dell'AACM come di tutta l'improvvisata dei '70. "For Trio" è un disco di musica contemporanea tout court, la sua miscela di improvvisazione e scrittura è figlia degli stessi stimoli che avevano già dato vita a pietre miliari come "Three Compositions Of New Jazz", "B-X° N0147" e "Silence"; di tale concezione "For Trio" rappresenta addirittura il vertice e Braxton dà dimostrazione concreta di conoscere alla perfezione Ives, Partch, Cage e Cardew, almeno tali sono i paragoni che sorgono più immediati. B-06 (figura geometrica,) NW 5-94-M (For Trio), che oggi definiremmo come una scultura o un'architettura sonora, è un brano basato su formule matematiche che lasciano spazioall'interpretazione dei singoli musicisti e che può essere eseguito da tre sassofonisti / multistrumentisti, con l'alea che da vita a una serie infinita di possibili combinazioni timbriche e sequenziali. Le due esecuzioni dimostrative che vengono proposte differiscono quindi nettamente l'una dall'altra, nella prima di esse Braxton è affiancato da Henry Threadgill e Douglas Ewart mentre nella seconda, secondo noi superiore, sono di scena Joseph Jarman e Roscoe Mitchell. Altra particolarità del brano è la sua adattabilità allo strumentario dei singoli musicisti coinvolti, strumentario che comprende in linea di massima flauti e ance in varie tonalità, percussioni varie e piccoli strumenti autocostruiti.
|
|
JOSEPH JARMAN / DON MOYE
Egwu-Anwu (India Navigation, 1978)
La tendenza alla scomposizione di formule e strutture, tipica caratteristica dei chicagoani, ha logicamentecolpito anche quella che di tale scena fu la massima istituzione collettiva, cioè l'Art Ensemble Of Chicago:
"Egwu-Anwu" (Sun Song) vede infatti schierata solo la parte più afro-teatrale del gruppo. Registrato dal vivo (la situazione che meglio si aggrada ai due sciamani che salgono sul palco con cavigliere e braccialetti di sonagli, i volti dipinti e i corpi insaccati in costumi africani), il doppio vinile è praticamente diviso in due lunghe suite, una per disco, intitolate Enu Igwe Na Nke Ala (The Heavens And The Earth) e Nke Ala Na Enu Igwe (The Earth And The Heavens); due lunghe suite che, travalicando l'Ellington 'jungle style' come tutto il free jazz, ripercorrono la storia del popolo nero-americano in un viaggio a ritroso su 'ferrovie sotterranee' e 'navi negriere' fino a raggiungere le radici primigenie del nero americano. Tale viaggio porta al recupero di tutto ciò, legni metalli e conchiglie, che aveva sonorizzato la marcia evolutiva (a tratti forzata) dei propri antenati: dalla scoperta della riproducibilità del suono fino all'odierna consapevolezza del suo potere comunicativo; un mondo sonoro fatto di riferimenti e citazioni, quello dei due, che rappresenta un intenso 'messaggio alla propria gente', e poco importa se la loro gente sta guardando altrove. Scendendo nel dettaglio troviamo un primo e un terzo lato più esotici, con abbondante uso di conchiglie percussioni e flautini di legno, contrapposti a quella che è invece la 'contemporaneità colta' dell'afroamericano: in quest'ultimo contesto spicca una versione di Ohnedaruth, brano originariamente composto da Jarman per l'Art Ensemble - se ne ricordano due ottime esecuzioni, quella in "Phase One" e quella dal vivo in "Bap-Tizum" - e qui ricondotto dall'autore alla sua più autentica intenzione.
|

Joseph Jarman
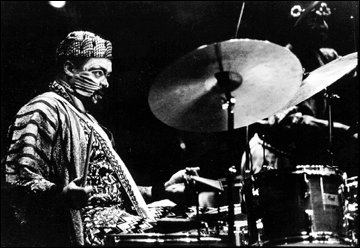
Famoudou Don Moye
|

Henry Threadgill, Fred Hopkins
e Stevie McCall
|
AIR
Air Lore (Arista Novus, 1979)
Gruppo storico nato all'interno dell'associazione ai suoi albori - il batterista Steve McCall è uno dei firmatari del primo statuto - ma giunto alla prova discografica solo nella seconda metà dei '70 grazie alla giapponese Trio Records, Air è, insieme all'Art Ensemble Of Chicago, anche una delle formazioni più longeve fra quelle legate all'AACM. "Air Lore", che arriva dopo altri quattro dischi in studio e un live registrato al festival jazz di Montreux, rappresenta uno dei bagni rigenerativi più entusiasmanti che siano stati mai effettuati nelle sorgenti della tradizione, sentito omaggio che dribbla agilmente le secche della rievocazione creata ad hoc per il divertimento dei turisti. Henry Threadgill, Fred Hopkins e McCall ridiscendono il Mississippi, dove incontrano le figure di Scott Joplin (The Ragtime Dance / Weeping Willow Rag) e Jelly Roll Morton (Buddy Bolden's Blues / King Porter Stomp), giù fino agli albori del jazz; qui giunti riposano a Paille Street, delicato omaggio flautistico di Threadgill a una nota strada di New Orleans. Bordelli e saloon, odore di polvere e di polvere da sparo, il ritmo delle pale dei riverboats; tutto un mondo scomparso è rintracciabile in queste rivisitazioni che, classiche e semplici, possiedono tuttavia un afflato modernissimo dovuto all'immortalità delle musiche proposte come a un'esecuzione misurata che, pur senza falsificazioni storiche, riesce a trarre dalle quattro composizioni tutte le loro caratteristiche d'attualità, Abbiamo già detto del contrabbassista a proposito di "Forces And Feelings", diremo ora del lirismo di Threadgill, splendido reinventore di un secolo di storia, e dell'approccio asciutto e melodico di McCall: pochi pezzi a formare il kit di uno fra i batteristi più significativi di tutta la storia del jazz, purtroppo ampiamente sottovalutato. Interessante il lavoro di riscrittura per i tre strumenti che viene effettuato nelle composizioni di Joplin, originariamente incise su rulli di pianola.
|
|
LEO SMITH / PETER KOWALD / GÙNTER SOMMER
Touch The Earth (FMP, 1980)
Una frase come 'Improvvisazione significa che la musica è creata nel momento stesso in cui è eseguita, siache sviluppi un tema dato, sia che si tratti di un'improvvisazione su un dato ritmo o suono (struttura), o nella forma più pura quando l'improvvisatore crea senza alcuna di queste condizioni, ma crea sul momento attraverso la sua conoscenza e immaginazione una combinazione di silenzio suono e ritmo che non è mai stata ascoltata prima e non sarà più ascoltata dopo' dà un'idea abbastanza precisa del musicista Leo Smith: incrocio nero, e quindi imbastardito dal concetto di ritmo e da un lirismo trombettistico tutto davisiano, fra Derek Bailey e John Cage, fautore dell'improvvisazione totale come di quella strutturata, oltreché genuino indagatore del rapporto esistente fra suono e silenzio. Smith è altresì un uomo aperto a qualsiasi esperienza e a qualsiasi tipo di collaborazione, quindi è il prototipo perfetto del 'soggetto AACM'. Ne sono testimonianza queste registrazioni dal vivo in compagnia del tedesco occidentale Peter Kowaid (contrabbasso) e del tedesco orientale Gunter Sommer (percussioni): tre musicisti partiti da una zona spazio-culturale diversa e che si muovono verso un medesimo centro gravitazionale. "Touch The Earth", registrato a Berlino nel 1979, prefigura con largo anticipo sia il crollo del muro, vista la presenza dei rappresentanti di tre fra le nazioni coinvolte in quell'assurdità che per anni ha diviso una città in due, che la tendenza alla contaminazione interraziale e intercontinentale. Per quanto riguarda la musica, a un primo lato leggermente più acerbo e dissociato fa seguito la sequenza di sogno In Light (Leo Smith) / Ein Stuck Uber Den Boden (Peter Kowaid) / Radepur In Februar (Gunter Sommer), espressione concreta e concretizzazione espressiva del concetto 'Noi siamo come la particella intrecciata, l'isola solitària del tutto'. Ragazzi, credetemi, i tre toccano la terracon i piedi ma toccano il cielo con le dita.
|

Leo Smith
|
|
Articolo scritto da Etero Genio
© 2000 Tuttle Edizioni
|
|
|
Discografia consigliata
|
|
ROSCOE MITCHELL Sound (Delmark, 1966)
JOSEPH JARMAN Song For (Delmark, 1967)
ANTHONY BRAXTON Three Compositions Of New Jazz (Delmark, 1968)
THE ROSCOE MITCHELL ART ENSEMBLE Congliptious (Nessa, 1968)
ANTHONY BRAXTON For Alto (Delmark, 1968)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO A Jackson In Your House (Byg Actuel, 1969)
ANTHONY BRAXTON B-X° N0147 (Byg Actuel, 1969)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO People In Sorrow (Pathé, 1969)
ANTHONY BRAXTON Silence (Freedom, 1969)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO Message To Our Folks (Byg Actuel, 1969)
CREATIVE CONSTRUCTION COMPANY MuhaI / No More With Gloves (Muse, 1970)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO Phase One (America, 1970)
"MUHAL" RICHARD ABRAMS Young At Heart, Wise In Time (Delmark, 1970)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO With Fontella Bass (America, 1970)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO Les Stances A Sophie (Pathé, 1970)
CIRCLE Paris Concert (ECM, 1971)
JOSEPH JARMAN / ANTHONY BRAXTON Together Alone (Delmark, 1971)
LEO SMITH Creative Music -1 (Kabell, 1972)
ANTHONY BRAXTON Saxophone Improvisations Series F. (America, 1972)
REVOLUTIONARY ENSEMBLE Vietnam (ESP, 1972)
KALAPARUSHA (MAURICE McINTYRE) Forces And Feelings (Delmark, 1972)
DAVID HOLLAND Conference Of The Birds (ECM, 1972)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO Bap-Tizum (Atlantic, 1973)
ROSCOE MITCHELL The Roscoe Mitchell Solo Saxophone Concerts (Sackville, 1974)
ART ENSEMBLE OF CHICAGO Fanfare For Thè Warriors (Atlantic, 1974)
LESTER BOWIE Fast Last! (Muse, 1974)
ANTHONY BRAXTON New York, Fall 1974 (Arista, 1975)
RASHIED ALI / LEROY JENKINS Swift Are The Winds Of Life (Survival, 1975)
NEW DALTA AHKRI Reflectativity (Kabell, 1975)
"MUHAL" RICHARD ABRAMS Afrisongs (Whynot, 1975)
ANTHONY BRAXTON Five Pieces 1975 (Arista, 1975)
LEROY JENKINS / JAZZ COMPOSER'S ORCHESTRA For Players Only (JCOA Records, 1975)
ANTHONY BRAXTON Duets 1976 with "Muhal" Richard Abrams (Arista, 1976)
AIR Air Song (Whynot, 1976)
ANTHONY BRAXTON Creative Orchestra Music 1976 (Arista, 1976)
"MUHAL" RICHARD ABRAMS Sightsong (Black Sanit, 1976)
RICHARD TEITELBAUM Time Zones (Arista, 1976)
DAVID MURRAY Low Class Conspiracy (Adelphi, 1976)
ANTHONY BRAXTON / GEORGE LEWIS DUO Elements of Surprise (Moers Music, 1976)
AIR Air Raid (Whynot, 1977)
NEW DALTA AHKRY Song Of Humanity (Kabell, 1977)
BROTHER MALACHI FAVORS MAGOUSTOUS Natural And The Spiritual (AECO, 1977)
ROSCOE MITCHELL Nonaah (Nessa, 1977)
GEORGE LEWIS The George Lewis Solo Trombone Record (Sackville 1977)
COMPANY 5 / 6 / 7 (Incus, 1977)
ROSCOE MITCHELL Nonaah (Nessa, 1977)
ROSCOE MITCHELL Duets With Anthony Braxton (Sackville, 1977)
LEROY JENKINS Solo Concert (India Navigation, 1977)
BARRY ALTSCHUL You Can't Name Your Own Tune (Muse 1977)
ANTHONY BRAXTON For Trio (Arista, 1977)
AIR Air Time (Nessa, 1978)
JOSEPH JARMAN / DON MOYE Egwu-Anwu (India Navigation, 1978)
ROSCOE MITCHELL L-R-G / The Maze / S II Examples (Nessa, 1978)
"MUHAL" RICHARD ABRAMS Spiral (Arista Novus, 1978)
LEROY JENKINS The Legend Of Al Glatson (Black Saint, 1978)
LESTER BOWIE / PHILLIP WILSON Duet (Improvising Artists, Inc. 1978)
LEO SMITH Spirit Catcher (Nessa, 1978)
LEROY JENKINS Space Minds, New Worlds, Survival of America (Tomato, 1979)
AIR Air Lore (Arista Novus, 1979)
COMPANY Fables (Incus, 1980)
LEO SMITH / PETER KOWALD /GUNTER SOMMER Touch The Earth (FMP, 1980)
|