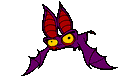FESTE SACRE E PROFANE
Processione di San Gennaro
prima domenica di maggio - E' una antica tradizione che ricorda il primo trasferimento
delle reliquie del santo dall'agro Marciano alla catacomba di Napoli. Questa
processione, chiamata anche "processione delle statue", è insieme uno spettacolo
di fede e di folclore. Questo evento si colloca tre le altre due date fisse
del ricorrente prodigio: il 16 dicembre, anniversario dell'eruzione vesuviana
del 1631, e il 19 settembre, data del martirio.
Festa della Madonna del Carmine
16 luglio - La festa si svolge in uno dei luoghi più significativi della città,
Piazza Mercato. Si festeggia la bruna vergine del Carmelo. Anticamente era
la festa dei pescivendoli di Porta Capuana, di Forcella, della Marina e di
Sant'Egidio. In memoria della battaglia della Goletta contro i Turchi, veniva
costruito un castelletto e poi incendiato. All'usanza del castelletto con
il tempo si è andata sostituendo, anche se con le stesse modalità, l'incendio
del campanile, oggi caratteristica principale della festa.
Festa di Piedigrotta settembre
- Festa dedicata al culto della Madonna, fino a qualche anno fa era rimasta
solo un ricordo. Era infatti dal 1966 che i festeggiamenti non avevano più
luogo.
Festa di San Gennaro 19 settembre
- E' questo il giorno in cui ricorre il martirio del santo e in cui la città
attende il miracolo. La suggestiva cerimonia ha luogo nel Duomo dove, tra
invocazioni e preghiere in dialetto, si attende la liquefazione del sangue,
custodito in due piccoli balsamari vitrei di foggia diversa databili ai primi
decenni del IV secolo.
Festa di Sant'Antuono 17 gennaio
- Festa in onore di Sant'Antonio Abate durante la quale nei rioni popolari
vengono preparati i tradizionali cippi, i falò. Sin dalla mattina nelle strade
si ammucchiano pezzi di legno e roba vecchia, che a volte raggiungono dimensioni
elevate, fino a quando non viene acceso il fuoco.
Festa di San Giuseppe 19 marzo
- Per le strade si vendono le tradizionali zeppole.
AFRAGOLA - 13 giugno
- Festa di Sant'Antonio di Padova.
GIUGLIANO - Festa della Madonna
della Pace - Si celebra dalla vigilia di Pentecoste fino alla domenica della
Santissima Trinità. La statua della Vergine con il Cristo morto tra le braccia,
posta su un carro trainato da buoi, percorre le strade della cittadina. Suggestivo
il volo dell'angelo, sia all'uscita che all'ingresso della statua dalla Chiesa.
Una bambina vestita di bianco, con due ali sulle spalle e in mano un giglio,
tenuta da una fune viene fatta "volare" all'altezza di venti metri e cosparge
la statua della Vergine con incenso e coriandoli.
OTTAVIANO - Festa di San Michele
Arcangelo - 8 maggio. In un clima suggestivo si svolge la processione, durante
la quale una coppia di ragazzi, un maschietto ed una femminuccia, compiono
un volo, sospesi ad una fune, in onore del Santo. Gli angeli scendono per
tre volte, in tre piazze diverse del paese, al passaggio della statua del
Santo con la spada sguainata. La Processione si conclude nella Chiesa di San
Michele Arcangelo. Corsa dei Ciucci - 10 maggio. Tradizionale parata di asini
e cavalieri in costume medievale e carri folkloristici che appartenenti a
sei contrade differenti si scontrano in un emozionante palio.
BOSCOTRECASE - Festa di Sant'ANNA
- 31 luglio. La statua della santa, conservata nell'omonima chiesa, viene
portata in processione per le strade del paese. I festeggiamenti si concludono
con una grande tombolata nella piazza centrale.
TORRE DEL GRECO - Festa della
Madonna dei 4 Altari - 24 maggio. Durante i festeggiamenti quattro altari
vengono sistemati nei punti cardinali della città. Ogni anno gli Altari hanno
fattezze diverse e competono in altezza e in bellezza. La costruzione e le
decorazioni vengono realizzate da anziani maestri locali. Si tratta della
più importante festa di Torre del Greco istituita dagli Spagnoli nel '500.
FESTA DELL'IMMACOLATA - 8 dicembre.
Il corteo in onore dell'Immacolata esce dalla Basilica di S. Croce. La statua
della Madonna è posizionata su un carro di imponenti dimensioni, lungo 10
metri, largo 2,80 metri e alto 6 metri. E' infatti sostenuto da circa 150
uomini in camice bianco che lo fanno sfilare per le strade cittadine tra gli
applausi dei numerosi fedeli e il volo dei colombi lanciati dal carro. Seguono,
oltre alla banda, ai sacerdoti e alle autorità, una serie di piccoli carri,
costruiti dai fedeli che li portano sulle loro spalle. La processione attraversa
la città tra lanci di coriandoli e petali di fiori, e i balconi rivestiti
di coperte di damasco, seta e merletti. Terminata la processione il carro
viene riportato in Chiesa e vi resta per 8 giorni. Durante i dodici sabati
che precedono il solenne giorno si svolgono novene e funzioni religiose, e
la domenica precedente alla festa i fedeli offrono dei fiori alla Madonna.
CASOLA DI NAPOLI -
Festa patronale Seconda domenica di luglio.
SANT'ANASTASIA MADONNA DELL'ARCO
- Lunedi in Albis. I festeggiamenti in onore della Madonna dell'Arco risalgono
al 1450 e il pellegrinaggio dai vicoli di Napoli al Santuario ripete un rituale
di gesti e di comportamenti che è del tutto simile a quello di quattro secoli
fa. Alle processioni partecipano numerosi gruppi di "battenti" o "fujenti"
che, vestiti di bianco con fasce rosse alla vita e azzurre a tracolla, portano
per molte ore di cammino stendardi e immagini della Madonna dell'Arco fino
al Santuario. Qui si assiste alla tradizionale "caduta" ai piedi della Madonna.
Dopo il fischio del capo paranza, i fedeli si lanciano con il viso a terra
e vi rimangono a lungo fino a quando non ricevono l'ordine di alzarsi.
ARZANO -
Festa del Sacro Cuore di Gesù 6 giugno.
NOLA -
Festa dei Gigli - Domenica successiva al 22 giugno. Questa festa vanta
una tradizione lunga circa quindici secoli. I festeggiamenti, in onore di
San Paolino, sono caratterizzati dalla processione di mastodontiche torri
realizzate in legno e cartapesta che le varie corporazioni trasportano sulle
spalle.
BARRA -
Festa dei Gigli - ultima domenica del mese di settembre. La festa dei
Gigli trae origine da antichissimi rituali agricoli pagàni propiziatori per
la fecondità della terra. Le pesanti e alte strutture del Giglio vengono trasportate
lungo le strade del paese da un gruppo di 128 uomini definito "paranza". Un
certo numero si dispone sui lati e sulle cime delle 8 varre mentre tre alzatori
sono disposti su ogni singolo varretiello. Le paranze,in numero di cinque
5, hanno ognuna un nome: Paranza Amici Miei, La Formidabile, L’Insuperabile,
La Mondiale e Paranza Ultras. Nei giorni che precedono la Festa i vari Comitati,
organizzano nei rioni di appartenenza, una serie di manifestazioni collaterali.
SAN GIORGIO A CREMANO -
Festa di San Giorgio, patrono 24 aprile.
POZZUOLI -
Festa di Sant'Antonio di Padova - 13 giugno. Il Santo viene festeggiato
con una solenne processione.
durante la quale la statua in legno del santo viene trasportata dall'omonima
chiesa al borgo del Serapeo. Festa della Madonna dell'Assunta - 15 agosto.
In questa festa si fonde il rituale sacro della processione, con quello profano
della conquista del pennone, una sorta di albero della cuccagna insaponato
che sporge sul mare. Festa di San Gennaro - 19 settembre. Secondo la leggenda
le tracce di sangue presenti sull'altare paleocristiano apparterrebbero al
santo. Infatti queste si liquefanno contemporaneamente al sangue contenuto
nell'ampolla del Duomo di Napoli. Festa di San Procolo - 16 novembre. Festeggiamenti
in onore del patrono della città Processione dei martiri San Procolo, San
Gennaro e San Gelso - Prima domenica di maggio. Vengono portati in processione
per le strade principali della città il busto di San Procolo, le reliquie
e i busti di San Gennaro e San Gelso.
QUARTO -
Festa di Santa Maria - 12 settembre. Festeggiamenti in onore della
Patrona della città. La statua della Santa viene portata in processione per
tutto il paese che per l'occasione viene illuminato da luminarie e pieno di
bancarelle.
MONTE DI PROCIDA -
Festa della Madonna dell'Assunta - 15 agosto. Festa in onore della
Santa Patrona con processione religiosa e fuochi pirotecnici a mare.
MITI E LEGGENDE PARTENOPE
I narratori antichi riportano l'origine delle Sirene in
differenti modi. Qualcuno le vuole nate da tre gocce di sangue del corpo del
fiume Acheloo quando questi ingaggiò una lotta con Eracle per la bella Deiamira.
Sicuramente si tratta di figure mitologiche assai ambigue, come l'acqua cui
sono legate, e a cui viene riconosciuto un ruolo di "attrarre e portare sventura".
Il nome deriverebbe da una radice sanscrita (SUAR=CIELO) o, secondo altri,
dalla base semitica "SJR" che vuol dire cantare. In una lettura più approfondita
del mito le Sirene sono accostate ad una rappresentazione donna-uccello e
non busto di donna con un corpo di pesce. Al canto ammaliatore delle sirene
avrebbe resistito prima Orfeo e poi Ulisse. Per la delusione si sarebbero
uccise gettandosi nelle acque del mare trasformandosi in scogli. Il corpo
di Parthenope, una delle tre Sirene, spinto dalla corrente del mare sarebbe
giunto fino alle sponde dell'isolotto di Megaride, dove oggi si erge maestoso
il Castel dell'Ovo. Qui gli abitanti l'avrebbero seppellita ed edificato sul
suo sepolcro la città che da lei prende l'antico nome.
I FANTASMI DI PIAZZA SAN DOMENICO
MAGGIORE - Nella centralissima Piazza
San Domenico, in cui sorge il celebre palazzo di Sangro dei Principi di Sansevero,
si sente ancora l'eco di fantasmi leggendari. Sono i fantasmi appartenuti
a Maria d'Avalos e al principe Raimondo di Sangro. Questi fu uno dei personaggi
più discussi e controversi della storia napoletana del XVIII secolo. Intorno
alla sua figura sono nati miti e leggende, che evocano misteri e segreti legati
alla sua attività di scienziato, chimico e alchimista. Il principe di Sansevero
era noto in modo particolare per l'invenzione delle macchine belliche e delle
macabre macchine anatomiche. Venne accusato di stregoneria e necromanzia per
i suoi lavori esoterici e simbolici incentrati sull’ermetismo, sulla cabala,
sull’alchimia e sulle conoscenze templari. La leggenda narra che poco prima
di morire si sia fatto tagliare a pezzi da uno schiavo e poi fatto "ricostruire"
all'interno di una cassa. Dopo qualche tempo sarebbe ne sarebbe riuscito vivo
e con il corpo intero. Ma purtroppo la famiglia, ignara di tutto, interruppe
il decorso prestabilito e aprì la cassa. Da qui saltò fuori il corpo risvegliato
del principe che subito ricadde riverso. Al fantasma di Maria d'Avalos è legata
una triste leggenda che narra della sua uccisione e di quella dell'amante
don Fabrizio Carafa da parte di alcuni sicari ingaggiati dal vendicativo e
geloso marito Carlo Gesualdo. Questi, ritiratosi nel suo castello di Venosa,
pazzo di gelosia avrebbe ucciso anche il figlio. E' così che oggi il fantasma
di Maria d'Avalos vagherebbe tra l'obelisco della Piazza e il portale di Palazzo
Sansevero in cerca del suo amato e di suo figlio.
O MUNACIELLO -
Una delle figure più temute e amate della Napoli esoterica è quella
del "Munaciello". Un imprevedibile spiritello che si mostra sotto forma di
vecchio-bambino vestito col saio dei trovatelli accolti nei conventi. Secondo
una radicata tradizione "'o Munaciello" era il soprannome dato a un trovatello
vissuto in un imprecisato periodo tra il primo e il secondo Rinascimento,
nato da un infelice amore e morto in giovane età in circostanze misteriose.
Da allora il suo fantasma si aggira per le strade lasciando delle monete sul
luogo della sua apparizione come se volesse ripagare le persone dello spavento
provocato o per riprendersi la "scazzettella" rubatagli per difendersi da
qualche malcapitato.
VIRGILIO MAGO -
Nella tarda antichità la figura di Virgilio si arricchisce di connotazioni
esoteriche e magiche, anche in seguito ad una interpretazione profetica della
IV egloga delle Bucolicae, in cui si nasconderebbe una dottrina molto profonda
che andrebbe addirittura oltre la predizione dell'avvento di Cristo. Con lo
scorrere dei secoli non scompare l'eco leggendaria di Virgilio mago e protettore
di Napoli che lo vuole fautore di magici eventi quale la creazione della grotta
di Piedigrotta, della Crypta Neapolitana, in cui fu edificato un tempio al
Dio Mithra, divinità indo-persiana. Sempre a Virgilio Mago sono legate le
leggende della Gaiola, anticamente chiamata Euplea per la presenza di un tempio
dedicato a Venere A questo significativo personaggio è anche legata la leggenda
dell'uovo di Castel dell'Ovo. Molte cronache medioevali napoletane narrano
che Virgilio avesse fatto murare nelle fondamenta del Castello di Megaride
un uovo rinchiuso in una gabbietta che nel caso in cui si fosse rotto tutta
la città sarebbe crollata. Altre versioni parlano di un uovo sigillato in
una "caraffa" di cristallo sempre murata in un luogo segreto del castello
con la stessa raccomandazione. Così nasce il nome di "Castel dell'Ovo" che
da allora si conserva, e lo si evince sia dagli scritti antichi che da una
consolidata tradizione orale.
LA SIBILLA -
Sulle sponde del Lago d'Averno, dove risuonano i responsi sibillini
per Enea, sorge l'antro della Sibilla, una lunga galleria che termina con
una stanza oracolare dove la profetessa dava i suoi vaticini. Le Sibille erano
sacerdotesse vergini che agivano in stato di trance invasate dal dio Apollo
e spesso legate al culto oracolare di un santuario. La storia della Sibilla
Cumana, nel cui culto si sovrappongono diversi miti e credenze, è molto suggestiva
e affascinante. Figlia di Glauco, pescatore della Beozia, era una donna dall'aspetto
bellissimo tanto che Apollo se ne innamorò. Invano il dio tentò di conquistarla
e all'offerta del dono della profezia la Sibilla chiese in cambio la vita
eterna, dimenticandosi di chiedere l'eterna giovinazza. Il dio accontentò
la sua richiesta con la condizione che lasciasse la città di Eritre. Giunta
a Cuma profetizzò per molti secoli continuando ad invecchiare senza poter
morire. Solo una lettera giuntale da Eritre e sigillata con la creta di quelle
terre riuscì a infrangere il divieto permettendone finalmente la morte. Il
vaticinio della Sibilla avveniva sia attraverso una divinazione in stato di
trance psicotico che attraverso trascrizione sulle foglie. Ed è proprio su
delle foglie che i celebri libri sibillini, che la leggenda vuole siano stati
venduti dalla Sibilla a Tarquinio il Superbo, erano scritti.
MISENO -
Secondo la profezia della Sibilla Enea sarebbe potuto scendere negli
inferi solo dopo aver trovato un ramoscello d'oro da portare in dono a Proserpina
e sepolto uno dei suoi compagni. Del triste vaticinio Enea ha conferma quando
trova il corpo del trombettiere Miseno. Secondo la leggenda Miseno fu gettato
in mare da un tritone, invidioso della sua bravura nel suonare la tromba.
Enea costruisce così per il suo compagno morto un sepolcro alle falde del
monte Aerio che da quel momento verrà chiamato Miseno.
IL MITO DELL'OLTRETOMBA DEL LAGO D'AVERNO
- Il lago d'Averno, nato da un antico cratere vulcanico, era il luogo delle
profezie della Sibilla, il paese dei Cimmeri, l'ingresso all'Ade, dove Enea
era sceso per incontrare il padre Anchise. La zona aveva un aspetto cupo e
misterioso a causa della fitta boscaglia circostante e delle esalazioni malsane
che non favorivano il passaggio degli uccelli sul lago (Avernus = àornos,
senza uccelli). Inoltre la presenza di un oracolo dei morti, che veniva consultato
dopo offerte sacrificali e suppliche agli dei degli inferi, rendeva ancora
più inquietante questo luogo. In seguito alla costruzione del Portus Iulius,
voluta da Agrippa, le acque del lago e la zona circostante divennero un enorme
cantiere sfatando così i miti infernali del lago.
IL LAGO LUCRINO -
Il Lucrino, come molti altri luoghi dell'area flegrea, è stato legato,
fin dall'antichità, alla mitologia e all'esoterismo. Qui la leggenda vuole
che sia stato Eracle, in cammino verso la Grecia con i buoi rubati al terrificante
Gerione, a collegare tramite un istmo il lago al mare, sul quale poi fu edificata
la Via Heraclea o Herculea, che porta questo nome in onore dell'eroe. Inoltre
la vicinanza con il lago d'Averno, mitica sede degli Inferi, ha portato all'identificazione
del Lucrino con uno dei corsi d'acqua infernali il Cocito o il Piriflegetonte.
Ma quando nel I secolo a.C. Sergio Orata vi impiantò un allevamento di pesci
e frutti di mare, il lago divenne famoso per le sue prelibatezze gastronomiche.
Nella poesia latina, infatti, il Lucrino, difficilmente connotato con tratti
infernali o misteriosi, è celebrato da Orazio, Properzio, Marziale e Plinio
il Vecchio per le bontà offerte dalle sue acque, la dolcezza del paesaggio
e per le sue fonti termali, come luogo di svaghi e di mondanità, al pari della
vicina Baia.