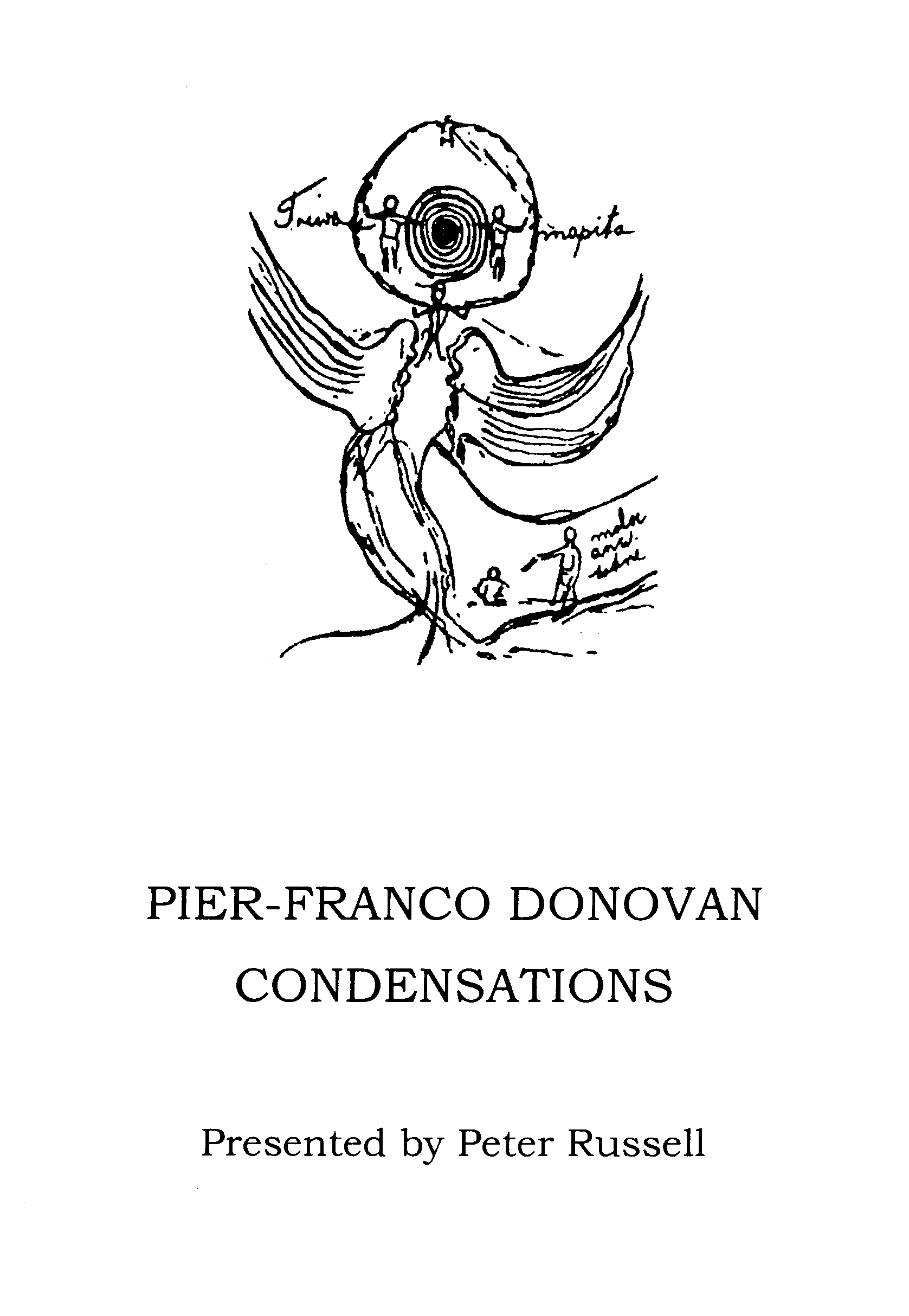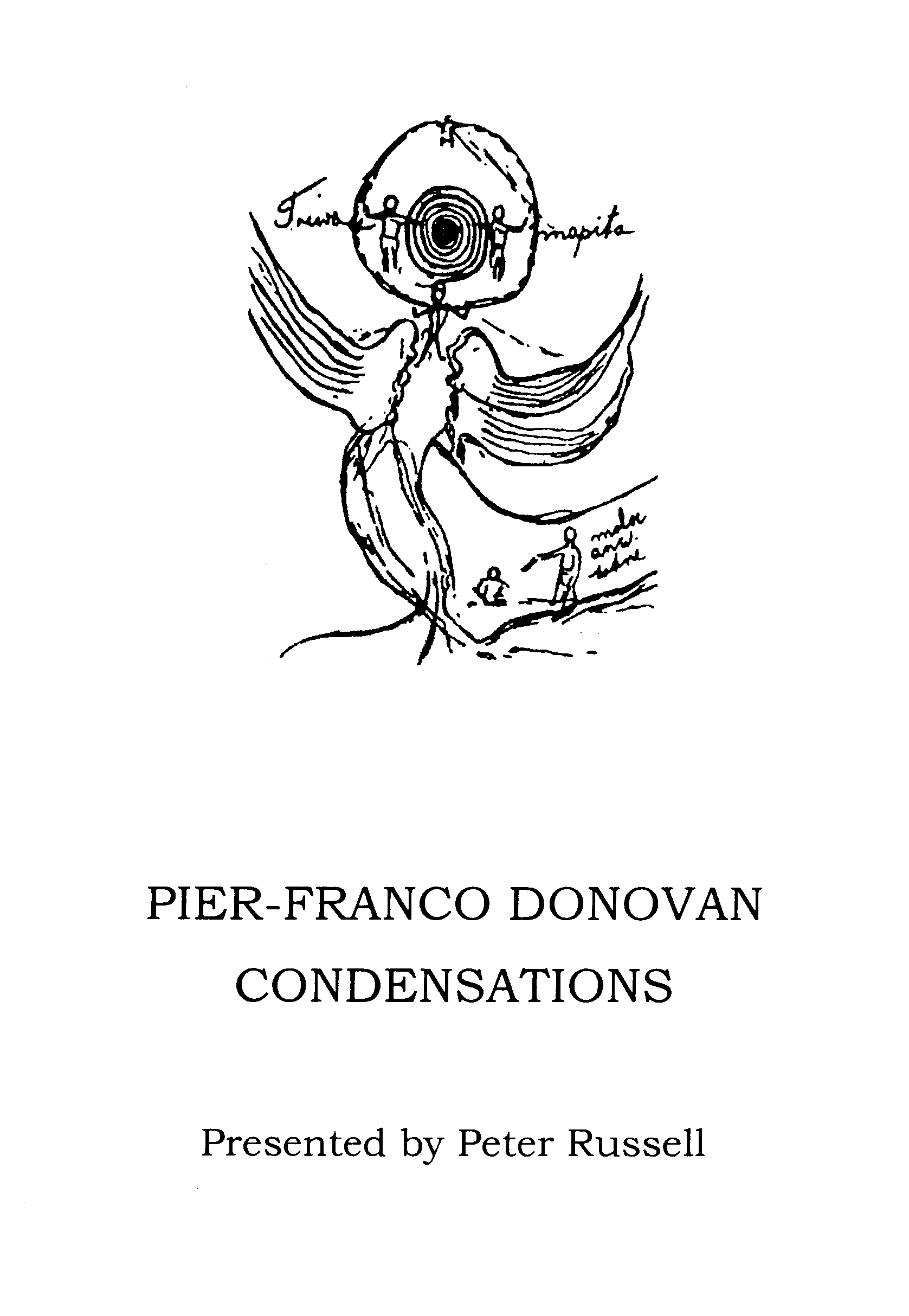di
Peter Russell
È una consuetudine dire che il mondo è progredito
materialmente durante gli ultimi due secoli e quindi negare che la mente dell’europeo
occidentale si sia evoluta. Nell’insieme siamo andati da dalle autocrazie
reali a delle democrazie costituzionali nelle quali gli elementi democratici sono stati
ottenuti attraverso un secolo di dura lotta e concessi dai governi col contagocce, solo a
malincuore – (ahimè, solo per essere sfruttati da politici pseudo-democratici privi
di scrupoli per il proprio tornaconto personale). Nell’arco della mia vita abbiamo
avuto dittature demagogiche Fasciste, Naziste e Marxiste prive di principi che sfruttavano
il nazionalismo e che si gloriavano dei loro principi democratici. Queste ora sono
crollate ma gli stessi poteri invisibili controllano in realtà ogni aspetto delle nostre
vite, e, quel che è peggio, continuano a usare come propri mezzi la stessa irragionevole
e spietata burocrazia che disumanizza ogni aspetto della nostra vita, le Arti incluse.
Come individui che crescono nelle proprie famiglie e
circoli familiari, le persone che vivono oggigiorno sono state brutalmente svezzate degli
alti ideali morali del XIX secolo (per quanto ipocriti), e progressivamente indottrinate
col concetto del lavoro solo per il duplice scopo di uno stupido consumismo e di un ancor
più stupido agio ed intrattenimento. È una grande macchina sociale che funziona soltanto
per portare più denaro nelle casse dello Stato (dove viene appropriato per la maggior
parte per il beneficio della burocrazia) e nelle sempre crescenti proprietà delle banche,
delle multinazionali, delle compagnie di assicurazione, dei trafficanti d’armi e del
crimine organizzato internazionale.
Se la vita per la gente comune, fino alla fine del XIX
secolo, era una questione di sopravvivenza, adesso è quasi esclusivamente un esercizio
economico. L’imperialismo ed il progresso tecnologico e le industrie manifatturiere
si sono fuse con le filosofie materialiste risultanti da Darwin e Freud, hanno spazzato
via come una ragnatela quel che rimaneva della cultura, dei valori e della sensibilità
aristocratiche, dell’idealismo nel campo religioso, e dell’intelletto nel senso
filosofico più alto – cioè, quello che si chiamava "lo spirito".
Certamente presento un quadro parziale, anche orrendamente
pessimistico, delle nostre condizioni di vita. Ci sono degli elementi positivi in questo
progresso materiale – mai prima d’oggi una grande comunità è stata tanto
unita, mai prima d’oggi c’è stata una vita media così lunga e una così bassa
mortalità infantile, mai prima d’oggi l’uomo ha vissuto in tale stato di
agiatezza fisica. Ma per quanto il mio quadro sia crudo, pochi saranno in disaccordo con
me se dico che in compenso, negativamente, mai prima d’oggi la società ha avvertito
l’assenza di uno scopo nella vita (a parte la ricchezza e il piacere) così
profondamente. Viviamo
Distratti dalla distrazione dalla
distrazione
e questo è certamente uno stato molto insoddisfacente.
Il mio scopo qui non è di fare una predica sui mali del
mondo ma semplicemente di delineare, anche in modo crudo lo sfondo contro il quale ho
incontrato Pier-Franco Donovan nel maggio 1990, – non solo è lo sfondo alla vita del
Sig. Donovan, lo è anche della mia.
Penso che valga la pena di raccontare la storia del nostro
incontro perché potrebbe essere argomento di meditazione. Nel maggio 1990, all’età
di quasi settant’anni, vivevo come oggi, in una casa isolata in una valle isolata tra
le colline toscane, dedicandomi quasi esclusivamente alla poesia. Un mio vicino dalla
valle accanto aveva da poco aperto una galleria d’arte a Firenze, a quaranta
chilometri di distanza. Mi invitò a vedere la prima mostra di pittura e allettò il suo
invito dicendomi che avrei conosciuto un giovane poeta americano che voleva incontrarmi.
Andai a Firenze e debitamente incontrai il giovane che era
simpatico, modesto, estremamente attento e serio e in nessun modo pomposo, anche se
apparentemente privo di qualsiasi conoscenza della poesia sia inglese che italiana.
Il "giovane americano" non era né propriamente
americano o italiano, e certamente non era un tipico italoamericano. Nato in Italia da
madre italiana e padre americano-irlandese, Donovan ha fatto gli studi elementari e medi
in Italia, quelli liceali in parte negli U.S.A. e in parte in Italia. Ha poi cominciato
studi di Fisica e Informatica all’Università di Roma, e all’età di venticinque
anni ha conseguito un B.A. in Letteratura Comparata presso la University of Michigan.
Quando lo incontrai era appena tornato dagli U.S.A. ed era incerto su quale carriera
perseguire. La tradizione di famiglia (proprietari terrieri, uomini d’affari e
avvocati) lo voleva iscritto ad una Business School, ma il giovane Pier-Franco –
lungi dall’essere uno spirito ribelle – voleva scrivere poesie ed aveva molti
dubbi circa gli studi di Economia e Commercio. Quel che mi sorprese, e dapprima mi lasciò
perplesso, era che Pier-Franco, che a venticinque anni non aveva scritto niente se non una
modesta tesi (su un soggetto folcloristico locale che riguardava un piccolo paese nel sud
della Toscana), volesse innanzi tutto scrivere poesie. A quel tempo aveva scritto solo una
piccola poesiola. Non ci sembrava essere modo per questo giovane con niente se non un B.A.
americano, di proporsi come scrittore. Ritenevo che per un aspirante alla professione
letteraria non ci fosse modo di cominciare se non attraverso una carriera come giornalista
(cosa assolutamente ripugnante per il mio nuovo amico) o attraverso un incarico accademico
(che non penso gli abbia mai sfiorato la mente).
Francamente vedevo poca speranza di una carriera
letteraria per questo giovane, ma vedevo pure che una carriera nel mondo degli affari
sarebbe stata per lui un disastro e una rovina. Se non mi fosse piaciuto tanto sul livello
personale – è una persona che non pretende niente da nessuno e il cui ego è tenuto
sotto un decoroso controllo – lo avrei mollato immediatamente. Ma nonostante la mia
minima reputazione letteraria, specialmente in Italia, egli si attaccò a me con molta
serietà e determinazione coma una specie di apprendista, e intraprese per me anche i
servizi più umili come mezzo pratico per imparare il mestiere. Ha elaborato con il
computer molte delle mie opere – un semplice lavoro di battitura, di grande aiuto per
me. Ma fece anche qualche ricerca sul mercato italiano e, attraverso delle lettere molto
equilibrate ai "prìncipi" della pubblicità, è riuscito a farmi apparire in
televisione e a partecipare ad altre attività pubbliche. Questo ha portato a una
accettazione su vasta scala delle mie opere in Italiano – dopo alcuni mesi di
amicizia è diventato un infaticabile traduttore dei miei lavori ed un attento ed
efficiente correttore dei miei scritti in italiano. Per dirla senza mezzi termini egli
divenne molto utile per me – più che utile, infinitamente utile in un senso molto
pratico. Per me lui era straordinariamente generoso e paziente nei confronti delle mie
poco pratiche stravaganze. Razionalmente, o in nessuna forma ragionata, non ho dato niente
in cambio. Pier-Franco non è il tipo di persona che vuole una lezione schematica di
Scrittura Creativa: immagino che fosse lo spirito delle mie spesso patetiche, o per lo
meno farneticanti, critiche in generale su quello che richiede ed è lo scrivere
seriamente, piuttosto che non delle prescrizioni specifiche, che gli furono d’aiuto.
Arrivammo presto ad uno stato di produzione in simbiosi. Ma più importante della mutua
utilità era quell’elemento di intangibile amicizia e di puro godimento della
reciproca compagnia.
Solo cinque mesi dopo il nostro primo incontro, un editore
romano mi invitò a presentare una sostanziosa raccolta di poesie per l’immediata
pubblicazione. Feci la necessaria selezione: in tre settimane Pier-Franco tradusse
l’intero libro e in un’altra settimana arrivammo alla stesura finale dei testi.
Da tutto questo ho imparato molto Italiano, ma lo stesso dicasi per Pier-Franco. Le sue
versioni erano letterali e precise, ma spesso non tenevano conto dei riferimenti impliciti
nel testo e del retroterra storico e letterario in generale. Il suo Italiano è superiore
al mio, ma si basa per lo più sull’Italiano parlato corrente. Io fui in grado di
modificare il suo linguaggio per dargli una dimensione storica e una profondità
letteraria o filosofica. Egli correggeva i miei piccoli errori grammaticali (specialmente
le preposizioni e i tempi dei verbi) ma spesso io modificavo il suo ottimo Italiano per
includere echi di Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso e Leopardi. Penso che entrambi abbiamo
imparato qualcosa dall’altro. Quello che soprattutto mi impressionò fu il fatto che
non litigammo o avemmo mai momenti di tensione nervosa quando si trattava di modificare i
testi italiani. In alcuni casi abbiamo addirittura modificato e migliorato
l’originale Inglese. In particolare ci siamo dovuti occupare dei molti omofoni
inglesi che, sia che si compitassero identicamente o differentemente, mantenevano
significati e associazioni che contribuivano tutti, quale più quale meno, al contesto.
Come tutti coloro che leggeranno le note filologiche a Teorie e altre liriche
(Carlo Mancosu Editore, Roma 1990) capiranno subito, questo non è stato un compito
facile.
Il 30 novembre 1990 il libro era pronto. Mi ha fatto
conoscere in Italia ed è stato un punto di partenza per il nostro giovane autore. Da
allora non ci siamo più guardati indietro. È ancora una lotta sopravvivere (per
entrambi), ma abbiamo più incarichi di tipo letterario di quanti ne possiamo sopportare.
Donovan adesso collabora con molti autori importanti ed ha collaborato con diverse case
editrici ed alcuni professori universitari.
Ma tutto questo è abbastanza secondario anche per la
presentazione di un modesto primo libro di poesie. La mie prime critiche nei confronti dei
primi sforzi poetici di Donovan si basavano principalmente sulla assenza di immagini
concrete, di riferimenti cosmologici, storici e geografici, di suggestioni ed elaborazioni
filosofiche, psicologiche e linguistiche, dello scarso uso della similitudine, della
metafora e della metonimia, e della quasi totale assenza del simbolismo senza il quale il
poeta non può creare il mito del proprio mondo. C’era, dapprima, poco più di una
imitazione di eventi coloriti da una certa aspirazione ad un miglioramento morale. Il
poeta si deve chiedere "Chi sono io? Quale è lo scopo della mia vita?" e
facendo questo creare il proprio mondo, il proprio contesto, non tanto un mito di se
stesso o un mito del mondo in cui vive, quanto il proprio mondo mitico. Egli non faceva
altro che raccontare il mondo così come gli sembrava che fosse e come invece gli sarebbe
piaciuto che fosse diverso.
Il mio amico Donovan è cresciuto in un mondo dominato dai
mass-media, dal cinema, dalla televisione (i giornali e le riviste sono solo degli
accessori ausiliari), e questo evoca un modo di vedere la vita essenzialmente
pessimistico, negativo, anche vacuo. Il mondo è diventato immaginistico piuttosto che
immaginativo. Dopo la Rivoluzione francese (il trionfo della borghesia) nessuno ha più
preso seriamente un "Te deum laudamus" o un "Jubilate agno" (la Chiesa
meno di altri). Forse che solo le persone che veramente soffrono in questa vita possono
conoscere la vera gioia? Forse Primo Levi conobbe attimi fuggenti di vera gioia, ma
l’hanno mai conosciuta i poeti contemporanei?
In questo momento i piccoli dittatori del mondo letterario
sono squallidi, sottovalutati, senza passione. È il mondo ufficiale delle accademie, dei
Ministeri, dei giullari finanziari (i registri di cinema e teatro), dei comitati
artistici, degli "ufficiali" (cioè, commissari) artistici, e dei burocrati in
generale (quelli che assegnano fondi economici, premi, ecc.) che controlla il mondo
culturale e artistico. Vedono sotto una luce opportunistica ogni iniziativa artistica come
potenziale stimolo per un guadagno economico e come un sedativo sociale. Essi sono
spregevoli schiavi o servi dello Stato o dell’alta finanza (tanto più
"alta" di loro).
Senza mai formulare tutto questo Donovan lo ha capito, e
per questo motivo mi è molto caro. Egli è autentico, e umano, come non lo sono i nostri
scaltri professoroidi postmoderni.
Le singole parole, prima della articolazione con altre
parole, sono arbitrarie, equivoche. La parola inglese "dove" può essere il
parassita che distrugge le mie pannocchie mentre maturano oppure la colomba che discende
dai Cieli al battesimo di Gesù. L’immagine può presentare la forma esteriore con le
sue qualità sensorie, o può agire semplicemente come simbolo. La Colomba
equivale allo Spirito Santo. Nella poesia imagista (o nelle contaminazioni sub-imagistiche
come la poesia pubblicata dalla rivista inglese The Review negli anni 60) mi
aspetto di sapere subito se "dove" è un colombaccio, una palombella, una
tortora, un piccione gozzuto o uno con la coda a ventaglio. Se "dove" è solo un
segno per lo Spirito Santo esso sarà conforme alle convenzioni della tradizione
iconografica e libero da riferimenti ornitologici. Il Cavaliere della Croce Rossa è il
Coraggio nell’astratto, un contrassegno, o un segno univoco, che, articolato con
altri segni simili genera una Allegoria, che in un’epoca non-dogmatica come la
nostra, ha poco fascino. Il simbolo reifica l’immagine significativa nella coscienza
interiore, suggerisce delle origini, principi (arcai) o cause generali e universali,
mentre la musica della parola esprime l’essenza ultima o l’avvertimento
della Presenza di un qualcosa che trascende la nostra normale consapevolezza.
Prima o poi un poeta, come qualsiasi altro uomo degno di
considerazione, deve chiedersi: "Chi sono io? Quale è lo scopo della mia
vita?". Potrebbe concludere di essere un’anima immortale o una coagulazione
casuale di molecole. Entrambi questi punti di vista possono generare poesia. Ma il poeta
deve pensare a questo, anche se non arriva ad una conclusione definitiva. Forse è la
tensione o la più sobria dialettica tra questi punti di vista estremi che, sopra tutto,
producono questa sostanza misteriosa che chiamiamo poesia. È una attenzione generale
piuttosto che una conoscenza sistematica che dà al poeta la capacità di innescare nel
lettore, con una singola parola o con poche immagini, vaste aree di riferimenti
significativi, suscitando nella mente del lettore uno stato di "incantamento".
Ad un certo stadio di arricchimento, l’immagine comincia ad agire come simbolo.
L’immagine presenta la forma esteriore delle cose. Molti poeti si accontentano di non
andare oltre. "Nessuna poesia se non nelle cose" – mentalità dei poeti Red
Wheelbarrow. Ma come osservava Brancusi, "la realtà non è la forma esteriore ma
l’essenza interiore". Ma come si fa a rappresentare qualcosa di così
apparentemente astratto come l’essenza? L’immagine agisce attraverso i moduli
esteriori della sensazione, delle esperienze particolari, di un idioma. Il simbolo è una
immagine complessa che attiva la mente riflessiva o l’anima individuale, e così
agisce attraverso il sentimento o l’emozione psichica. Il movimento Red Wheelbarrow
affascina meravigliosamente le facoltà visiva e tattile, ma bisogna riconoscere che è
molto limitato nella sua portata di influenza e di esperienza. "La discesa della
Colomba" o l’immagine di San Sebastiano trafitto dalle frecce suggerisce un
campo infinitamente più vasto di esperienza o di coscienza, eppure entrambi questi
simboli sono limitati in quanto quasi esclusivamente simboli cristiani – l’uno
della salvezza individuale, l’altro della sofferenza o del sacrificio individuale.
In un senso molto ampio, e non mi sto riferendo ad un
qualche dogma, l’immagine "realistica", sensoriale e corporea, corrisponde
a quella concretezza dell’Inferno dantesco tanto ammirata da T.S. Eliot. Il
simbolo più complesso, la coscienza del generale, le emozioni corrispondenti
all’anima e ai suoi moti, è più tipico del Purgatorio. Ma c’è un
tipo di simbolo più profondo ed universale che risveglia il senso delle origini e dei
fini ("fini" sono sia le finalità che i motivi o
"significati"), e questo è tipico del Paradiso, il dominio del
metafisico, l’Empireo, che è oltre lo spazio e il tempo, e che concerne
l’intuito universale, il farsi intero (i.e. guarire) dello spirito attraverso
l’assimilazione estatica totale all’Uno. Tutto questo è apertamente mistico e
pertanto ignorato da quasi tutti gli accademici e schifato da quasi tutti i poeti. Ma è
l’essenziale.
Mi sono domandato come si fa a esprimere
"l’essenza". In parte, credo, attraverso l’uso giudizioso ma anche
spontaneo di questo tipo universale di simbolo, e – siccome usiamo il linguaggio come
mezzo – attraverso il tessuto e il ritmo del linguaggio stesso, che
sono entrambi simbolici quanto il simbolo universale e ovviamente rendono la poesia simile
a musica sacra come la Selva morale di Monteverdi, i Corali di Bach o il
Quartetto in La minore di Beethoven. Non c’è bisogno di essere cristiani
per sentire la bellezza e la verità assoluta di parole come quelle di Dante
Vergine madre, figlia del tuo figlio (Paradiso
XXXIII, 1)
o anche di Petrarca
Chiare, fresche e dolci acque
per avvertire che si è davanti a una Presenza
trascendente quando ci si sottomette semplicemente e totalmente a queste sublimi parole.
In ultima analisi è la musica delle parole, sempre combinata con il dato simbolo
universale, che raggiunge questo effetto miracoloso:
Some spirit which escapes
The learned doubt, the chatter of cultured apes
[Uno spirito che sfugge
Al dubbio dei sapienti, al ciarlare delle scimmie acculturate]
come scrive A.D. Hope.
Questo non è il luogo dove presentare una dissertazione
su quello che intendo come simbolismo. Basti citare le parole del Capitano Achab alla fine
del capitolo 70 di Moby Dick, subito dopo avere recitato una lunga invocazione
alla pretesa testa oracolare del capodoglio:
Oh Natura, e tu, anima umana! Come le
vostre analogie si distendono
oltre quanto è dicibile! non il più piccolo atomo si muove o vive nella
materia, che non abbia il suo sottile riscontro nello spirito.
Ovviamente questo è in completo contrasto con la teoria e
la pratica delle scuole di poesia principali degli ultimi trent’anni, le quali si
sono occupate del meramente ludico (come loro stessi dicono) e degli effetti.
Forse Donovan ed io siamo dei dissidenti e i poeti di The Review, del Times
Literary Supplement, i Marziani e i cosiddetti "Nuovi poeti" (1993) sono
conformisti istituzionali. Così sia.
* * *
Helen Dunmore, nel numero estivo del 1993 di Poetry
Review (Londra), nel presentare la nuova antologia del movimento Bloodaxe, The
New Poets, che introduce poeti delle isole britanniche e irlandesi nati nel o dopo il
1940, descrive la poesia contemporanea britannica come una grande festa di ubriachi in cui
tutte le barriere sono sparite e tutto è stare insieme e celebrazione, anche se non dice
di cosa. Ci sono enormi quantità di cibo e bevande, tutti sono contenti, e a nessuno
importa delle coppie che copulano negli angoli o dei mari di vomito sul pavimento. È una
descrizione stomachevole, ma immagino che da un punto di vista utopistico o istituzionale
vada tutto a vantaggio degli affari – Po Biz (vale a dire "Poetry Business"
espressione che tradotta in modo blando significa "industria della poesia" e che
è affine a "Show Business", "industria dello spettacolo" –
n.d.t.). Dubito che un vero poeta vada mai a quelle feste. È terreno per i tirapiedi
delle Arti, gli impostori, gli sfruttatori ed i pubblicitari.
Anche la raccolta di Donovan comincia con una festa
("La festa è finita"), e anche se non era un
raduno di sciattoni e ubriaconi e non c’era sesso o vomito pubblico (l’Italia è
molto arretrata), Donovan si sentiva comunque deluso. Come Socrate, lui era ancora in
piedi quando tutti gli altri si erano addormentati in terra, ed era deluso
dall’assoluta scipitezza e vacuità dell’insieme delle cose. E Donovan non è
affatto un puritano. Come me, si diverte a una bella festa ed ha un occhio di riguardo per
le belle ragazze. Ma se la mattina dopo non c’è niente della conversazione da
ricordare ne esce frustrato, come me. Dallo "stare insieme" si aspetta che possa
rimanere un ricordo significativo, lo sfogo di uno spirito di libertà che nella vita
normale è sempre e necessariamente limitato, – la libertà di espandersi e trovare
nuovi livelli di esperienza e potenziali di crescita. Egli è ottimista come me, e crede
nelle infinite possibilità di miglioramento, non in un falso scetticismo che crede che
non valga la pena di credere a niente, e che tutto vada non solo messo in discussione, ma
anche screditato. Lo scetticismo è una cosa (Shelley è stato uno scettico illustre); il
nichilismo è tutt’altro.
Donovan vede l’assoluta vacuità dei punti di vista
delle generazioni più recenti:
Il vuoto ha riempito tutto
e tu nel vuoto sei vuoto
È stato tolto tutto allo spirito, anche lo spazio ed il
tempo, dal denaro, dalle convenzioni, dagli intrattenimenti vacui e dalle chiacchiere.
Dopo tutto quel confortevole e sentimentale stare insieme alla festa, la mattina seguente
quelle stesse persone tornano ai loro uffici per continuare nella sciocca carriera di
arraffare denaro e potere. Sarà questa forse una legge della "società", ma è
una legge dell’Universo? È una legge dello Spirito?
Secondo me la poesia di Donovan è corretta nella sua
analisi della situazione (qui bisogna essere pragmatici, non teorici), ma prolisso
nell’esprimersi, e debole nella comunicazione dell’emozione concomitante.
C’è un tentativo di ridurre le parole ad un minimo ragionevole e di trovare
l’immagine forte che può parlare con più efficacia di qualsiasi opinione espressa.
Nella poesia seguente, "Rinascita", siamo già su un terreno molto più
solido.
Seppellite questo mio corpo
insieme ad un seme di quercia
e
Il mio spirito allora tornerà
"Seppellire" è allo stesso tempo un verbo
concreto, e indica una convenzione e un rito, entrambi significativi. "Quercia"
paragonato a frassino, olmo o salice, è corretto in quanto la "quercia" è
simbolicamente il Re del mondo vegetale, come il leone lo è del mondo animale e
l’aquila del mondo dei volatili. Tutto molto semplice, non sono necessari trucchi o
teorie. Se la festa della Sig.ra Dunmore suona come l’ultimo rantolo dei Pesci,
quella di Pier-Franco si avvicina più alle prime deboli note di una rinascita
dell’Acquario.
In "Cortili"
l’anima umana è sentita come una parte dell’universo, un qualcosa di cosmico.
La festa della Dunmore raccoglie intorno a sé la comunità degli imbrattacarte, il
Ministero della Cultura, i rappresentanti dei pubblicitari e le minoranze inglesi –
il mondo della Po Biz – ma è provinciale. Nel mondo di Pier-Franco sono
presenti galassie e atomi, animali e vegetali e minerali.
Capire che siamo uguali,
che siamo parte dell’insieme
che ci avvolge tutti nel suo grembo,
invisibile ma accogliente,
che accetta tutti e rifiuta nessuno.
Quella della Sig.ra Dunmore è una festa di ubriachi che
mantiene alti gli spiriti nell’ambiente londinese, quello di Pier-Franco è un antico
cortile aperto a tutto quello che c’è nell’Universo. Preferirei starmene in
quel cortile che andare alla festa da incubo della Dunmore. Mi sento a casa sotto le
stelle, ma mi sento alienato fra tutti quei giornalisti e pubblicitari. Le stelle sono un
grande mistero, i giornalisti dei familiari e brutti soprammobili che conosco fin troppo
bene. L’immaginazione reagisce ad una sfida, non alle contingenze o ai luoghi comuni.
I poeti oggi di moda in Gran Bretagna, e anche in Italia,
si occupano per la maggior parte di cose ed eventi comuni, cioè, delle contingenze della
normale vita urbana. Per loro le immagini televisive e cinematografiche, la science
fiction, la musica pop e i titoli dei giornali, sono "reali" (o anche di più)
quanto le cose e gli eventi costantemente ricorrenti della natura. La speculazione o la
visione metafisica è out. Le trivialità e il grottesco sono in.
In "Il punto"
Donovan parte dalla immagine del punto sulla pagina dal quale il computer forma le lettere
dell’alfabeto. Le parole, i pensieri e i sogni rappresentati sulla pagina sono
transitori ma il punto universale, che nella sua mente equivale al punto geometrico o al
centro del cerchio, è sempre presente. In sé niente eppure tutto, tutti "gli
intelletti possibili" ne traggono origine. Un millennio fa i mistici Sufi
introdussero l’idea che il punto sotto la prima lettera del Corano
"contenesse" o sussumesse l’intero Libro Sacro. Centocinquanta anni prima
Platone aveva scritto il dialogo Parmenide, un esame sulla questione
"L’Uno (cioè il Divino, l’Immobile che Muove – P.R.) è o non
è". Platone fa dimostrare a Parmenide che se l’Unità assoluta non esiste
allora il mondo fenomenico non può esistere. Questa Unità era l’origine di tutte le
cose sebbene non avesse attributi – nessuna forma, nessuna misura, nessun peso,
nessuna posizione nel tempo e nello spazio, nessun nome, nessun colore, e anche nessuna
entità. Era allo stesso tempo tutto e niente. Secoli prima di Platone l’autore della
Chandogya Upanisad aveva formulato lo stesso pensiero virtualmente con le stesse
parole di Platone. Sebbene figlio dell’era dell’elettronica e della cultura
urbana moderna Donovan riesce ad evocare questa tradizione secolare, nella quale non è
affatto istruito, semplicemente attraverso l’intuizione e l’immaginazione
creativa.
Donovan osserva gli effetti e ne ricerca le cause. Ricordo
una lettera rabbiosa che ho ricevuto nel 1970 da H.M. McLuhan nella quale diceva che a lui
importavano gli effetti, non le cause. D’altra parte William Blake, ovviamente in
armonia con Platone, sosteneva che "Ogni effetto corporeo ha una causa
spirituale". Le persone che si preoccupano unicamente degli effetti, (e sto pensando
ai poeti del Times Literary Supplement e del Sunday Times), hanno perso
contatto con l’Intelletto e deliberatamente lasciano che le loro anime si
atrofizzino.
Ovviamente, prendere una simile posizione nel mondo
contemporaneo, contaminato come è da filosofie superficiali e alla moda, vuol dire
rischiare molto. Produrre effetti bizzarri vuol dire giocare sul sicuro, come si può
vedere con l’antologia "New Poets" del Bloodaxe. La poesia di Donovan
"Canto d’amore" esprime questo genere di
serio rischio con una metafora estesa che è più ambiziosa di qualsiasi altra cosa che
avesse scritto durante il suo primo anno di lavoro poetico. I nostri contemporanei più
giovani arrischieranno una parola (generalmente una parola audace) o una immagine (spesso
bizzarra) ma raramente arrischiano un pensiero, o un modo di vivere.
La poesia "Domus"
è in qualche modo una estensione di tutto questo. Costruire una casa è certamente un
rischio. Ma è un rischio che, anche in giorni come questi di tassi d’interesse (usura)
mammoniani, la gente deve prendere. Ma ancora più importante è la qualità di quello che
si mette nella casa e come vi si vive.
Questo porta alla questione della dimensione religiosa,
una dimensione cospicuamente assente nei poeti d’oggi. È sempre stata forte nei
poeti più anziani – Kathleen Raine, R.S. Thomas ed Elizabeth Jennings, per nominarne
solo tre. È almeno presente in Heaney. Ma dopo Heaney non riesco, su due piedi, a
ricordare un poeta che sia in qualche modo orientato verso la religione, e certamente le
ortodossie religiose non hanno prodotto poesia. Pare che siamo arrivati ad un punto al
quale non si può più credere in una delle ortodossie o "credi" confessionali o
settari che appaiono tutti vuoti come gli slogan dei partiti politici da tempo screditati.
L’idea di Pound di una religione senza dogmi può attrarre molto di più. C’è,
penso, un residuo di bisogno religioso in quasi tutti noi. Se non appare nella antologia
del Bloodaxe (con Michèle Roberts come eccezione molto dubbia) è probabilmente dovuto al
fatto che i redattori hanno scartato qualsiasi cosa che presentasse un qualsiasi indizio
di carattere religioso. Per loro stessa ammissione essi si preoccupano "del sociale e
del realista", qualsiasi cosa quei termini generici possano significare, se
significano qualcosa.
Lo "Scienzianesimo"
di Donovan, una parola orrenda ma necessaria per distinguersi dal "Scientismo",
tratta di questo problema. Siccome non appartengo ad alcuna religione (anche se in qualche
modo appartengo a tutte), cioè sono di ampio temperamento religioso, e lo stesso vale per
Donovan, voglio far riferimento all’amico di Aldous Huxley, Gerald Heard, che scrisse
negli anni ’30:
"La fede è la scelta della ipotesi
più nobile. È la decisione
di dare il più alto significato ai fatti che osserviamo."
Nella scienza sperimentale la formula più
"economica" o "semplice" è considerata generalmente come la più
probabile. In termini di credo religioso perché non scegliere il più "alto"? I
poeti del Bloodaxe hanno scelto il più basso significato possibile, o addirittura nessun
significato. I loro redattori hanno optato per un pluralismo o un relativismo assoluti in
cui "il più alto" e "il più basso" sono variabilmente relativi, o
privi di significato. Nel mio mondo mentale "il più alto" e "il più
basso", come Nord e Sud, sono poli opposti. Questo non è un trattato filosofico
– uso questi termini semplicemente secondo una interpretazione comune. Se il lettore
non riesce a riconoscere la loro valenza generale posso solo concludere che egli sia
volontariamente testardo, oppure reso volontariamente testardo dai teoristi accademici e
dai propositori di uno "scetticismo" assoluto.
Se quanto detto sopra va oltre l’intellezione del
lettore posso solo integrarlo con altre due citazioni, e sperare che un po’ di luce
possa filtrare nel suo cervello e nella sua sensibilità umana.
"...il prodotto, presumo, di una
educazione razionalistica,
io rimango un agnostico che aspirava a essere uno gnostico –
ma uno gnostico solo sul livello mistico, uno gnostico
senza simboli, cosmologie o un pantheon..."
(Aldous Huxley, da una lettera del 1962)
"La realtà ultima non può essere
compresa che con l’intuito, attraverso
un atto della volontà e le affezioni. Plus diligitur quam intelligitur."
(Aldous Huxley, Eminenza grigia)
La poesia di Pier-Franco "Aspirazioni" merita attenzione. Se la poesia "Cortili" era una immagine abbastanza generalizzata,
leggermente vaga e non del tutto messa a fuoco, ed i suoi vari contenuti rimanevano le
varie cose concrete che erano, – come Pound giustamente sosteneva
"l’immagine naturale è sempre il simbolo adatto", – in "Aspirazioni" abbiamo l’immagine del serpente
che succhia un uovo che è concreta o "naturale" quanto qualunque cosa in Pound.
Finalmente Donovan ha trovato il suo "correlativo oggettivo" e non abbisogna di
parole o di idee astratte per spiegarsi. Siamo forse sulla soglia della poesia.
C’è un parallelo notevole tra questa poesia ed il
sonetto "Parabola" di Guido Gozzano (specialmente se si riferisce il tutto a
Dante, Paradiso XXVIII, 106 seg.):
Il bimbo guarda fra le dieci dita
la bella mela che vi tiene stretta;
e indugia – tanto è lucida e perfetta –
a dar coi denti quella gran ferita.
Ma dato il morso primo ecco
s’affretta:
e quel che morde par cosa scipita
per l’occhio intento al morso che l’aspetta...
E già la mela è per metà finita.
Il bimbo morde ancora – e ad ogni
morso
sempre è lo sguardo che precede il dente –
fin che s’arresta al torso che già tocca.
«Non sentii quasi il gusto e giungo al
torso!»
Pensa il bambino... Le pupille intente
ogni piacere tolsero alla bocca.
Con "Firenze"
abbiamo una poesia che è coerentemente ritmica con nove versi approssimativamente della
stessa lunghezza, ma che, a metà della poesia, presenta un verso che consiste di una sola
parola – fermo, nel senso di "immobile". In un certo senso questo
può essere considerato come una mimica del concetto di "immobilità" e immagino
che lo sia, se si razionalizza il concetto. Ma non penso che si "senta"
l’immobilità. "Fermo" o "immobile" non è altro che un segnale
per la mancanza del ritmo e del movimento che la poesia intende rappresentare. Non dà
l’emozione insita nella percezione della immobilità nel modo in cui, per esempio, la
danno i famosi versi di Coleridge della "Ballata del vecchio marinaio":
As idle as a painted ship
Upon a painted ocean
[A riposo come una nave dipinta
Su di un oceano dipinto]
Questo arriva alla vera essenza del sentire il tutto fermo,
immobile. Si entra nel regno del simbolismo piuttosto che nel semplice imagismo o, peggio
ancora, nella mera descrizione. L’isolamento della parola "fermo" in un
singolo verso può essere visto come una rappresentazione della qualità del "portato
ad uno stato di immobilità", ma in realtà la asserisce solo come proposizione. Non
è un fatto propriamente poetico.
Con "Nel meandro"
entriamo in un mondo in cui la figura insignificante del singolo poeta viene presentata
contro uno sfondo molto più ampio, davvero uno sfondo che è tanto cosmico quanto
letterario, storico e religioso. La poesia tratta del dramma dell’anima nel mondo,
"Angelo e Demone". Per quanto la poesia sia breve, essa è una poesia
"importante", se non una "grande" poesia. Possiamo paragonarla al
"Canto d’amore" di sei mesi prima, la quale
affronta un grande tema come quello Empedocle che si butta nel vulcano, ma che forse è
meno riuscita della poesia più recente. Quest’ultima è una cosa seria. Potremmo
chiederci se l’espressione "pareti di nulla" è una immagine concreta o
astratta. Il consiglio di Pound di non mischiare le due cose sembra essere stato
trascurato in questo caso. Il suo esempio sarcastico del genere mischiato, "tenue
terre di pace", mostrava chiaramente il pericolo di una dispersione di energie. Ma
"pareti di nulla" sembra trascendere questa limitazione e raggiungere un
conjunctio oppositorum solo perché non siamo più a un livello letterale, realistico, ma
in un qualche contesto spirituale (noetico). Le "pareti" sono concrete o
astratte? Il "nulla" è astratto o concreto? Certamente delle domande
irrilevanti, perché qui i due poli sono in armonia.
In "Tarocchi"
abbiamo una poesia in forma narrativa che adombra un sistema simbolico universale e
tradizionale. L’ampiezza dell’immaginazione è così considerevolmente estesa,
il suo significato molto accresciuto e approfondito. Il poeta ha fatto molta strada dopo
le sue riflessioni semplici e quasi ingenue di "La festa
è finita" di due anni prima. I simboli dei tarocchi hanno portato alla luce
qualcosa dalla profonda coscienza che Pier-Franco non avrebbe potuto conoscere a quella
festa mancata.
In "Una canzone inutile"
questo tema viene sviluppato oltre, anche se in una forma più verbosa. La visione
simbolista contro le opinioni e le convenzioni.
Bambino, sognavo d’avere una
bacchetta magica
per punire i cattivi e premiare i buoni;
ragazzo, sognavo di trovare un anello fatato
per diventare l’eroe che avrebbe salvato il mondo;
adulto, scrivo poesie per toccare i cuori degli uomini.
Ma per lo Stato Omero è solo parte di
un programma,
per la Chiesa Dante esiste solo dal 1921,
per Greenaway Shakespeare è uno spaventoso incubo,
per la società Ezra è ancora un nazi-fascista:
io sono nessuno alla ricerca di un fiore appassito.
Ho trovato soltanto una bestia stramba,
forse spirito benevolo o forse demonio,
un animale che parla in versi strani,
sfuggito ai trabocchetti del tempo e degli uomini,
confinato in un borro, ma libero nell’universo.
Laggiù i padri lo vanno a trovare e
consolare,
schiere di ninfe, ghiri e castori gli fanno compagnia,
fanciulli abbandonati, la notte, da lui trovano rifugio
e gli raccontano le loro storie, le loro sofferenze,
ripartendo all’alba per tornare tra gli uomini.
Se nella Parte I, verso 2°, Giove Pluvio è una mera
metonimia della pioggia, adesso, nella seconda metà della Parte II le figure mitologiche
e le persone reali e i luoghi vengono identificati – concreti e viventi. La vita
quotidiana di un vecchio poeta, un eremita leggermente ridicolo che potrebbe essere sia
Pan che Sileno, è stata trasformata dal poeta, durante le sue visite all’uomo
selvaggio, in una scena unica e visionaria.
Al lettore forse interesserà fare un paragone con la
visione di un altro poeta, di una generazione più vecchio di Donovan, di un altro anziano
che ha scelto di abbandonare la "scena" urbana elettronica McLuhanizzata:
DISCORSO DI COMMIATO
Questo tale è in piena ritirata,
ne ha piene le tasche, vuole andarsene,
non regge il trambusto, il lerciume,
gli scemi sulle mountain bike,
l’alta tecnologia ostile all’utente,
la sottocultura esoterica
dove "I Colletti piantano bacche bimeriggiane
che i Fratti proprio non sopportano!",
dove "Sacco a T incontra il Dott. Stransacco
e velocemente abbandona i pesci!",
dove ogni bollettino successivo
è più strambo, triste, osceno...
Questo tale ne ha piene le tasche,
vuole andarsene, ne ha piene le tasche.
Peter Reading
(Sunday Times, 18 ottobre 1992)
Per me il contrasto tra le due poesie indica non tanto il
contrasto tra giusto e sbagliato, tra intelligente e stupido, tra competente ed
incompetente, quanto un contrasto tra una mente che si preoccupa del cerchio ristretto
delle contingenze e del transitivo – una mente che esclude il 99%
dell’esperienza e delle potenzialità umane – e una che è virtualmente
omnicomprensiva, anche se purtroppo non è al corrente della vita di strada di un periodo
breve e fuggitivo.
"Il matto" dice
quello che credo che la maggior parte di noi vuole dire e realmente pensa, ma nel dettare
i propri valori penso che sia efficace. Mandel’štam in effetti ha detto le
stesse cose, ma in maniera tale che la sua poesia è meravigliosamente vigorosa:
Per l’alto valore dei secoli a
venire,
per la nobile stirpe umana ho rinunciato
anche ad alzare il calice al banchetto dei padri
e alla letizia e al mio stesso onore.
Mi incalza alle spalle il
secolo-canelupo,
ma non ho sangue di lupo nelle vene;
ficcami piuttosto come un cappello nella manica
della calda pelliccia delle steppe siberiane,
che io non veda il vigliacco, né il
gracile lerciume,
né le ossa insanguinate sulla ruota,
e per me tutta notte brillino volpi azzurre
nella loro bellezza primigenia.
Portami via nella notte, dove scorre
l’Enisej
e il pino si slancia a toccare la stella,
perché nelle mie vene non c’è sangue di lupo
e soltanto un mio pari potrà uccidermi.
Lo stesso si può dire di "Leggendo Quasimodo" anche se vi è una più grande
ricchezza di immagini che non in "Il matto". Qui
abbiamo il pensiero esemplare, il lamento appassionato per la stupidità e la cupidigia
dell’uomo che fanno di questo mondo un inferno, e meglio ancora, un profondo tema
morale e spirituale trattato con una semplicità fanciullesca da una mente pienamente
consapevole. Qui, per lo meno, c’è del buonsenso.
Una poesia come "La vetta"
sembrerebbe, credo, completamente irrilevante agli occhi dei poeti di moda oggi – la
deriderebbero senza esitazione per il suo contenuto. Comunque sia, credo che un poeta come
Donovan, il quale ha un senso dell’insieme e della unicità delle cose (in
opposizione alla frammentarietà e alla neutralità di tutti i fenomeni), ad un certo
punto deve scegliere tra il cammino del poeta, del santo o del mistico. Il mistico non si
occupa principalmente di comunicare la propria esperienza agli altri. Il santo dovrebbe
preoccuparsi di servire la divinità e di esortare gli uomini ad una migliore vita pratica
attraverso il proprio esempio. Il poeta si occupa innanzi tutto della tecnica delle parole
per il fine di comunicare ad altri le potenzialità della santità e della visione
mistica. Ed è nella tecnica delle parole che un poeta giovane come Donovan troverà la
via di una espressione più efficace. Questo può venire solo attraverso "il lavoro
sedentario / e l’imitazione dei grandi maestri". Questo richiede un grande
sforzo di volontà, come possiamo leggere in "E
pregherò in silenzio". Senza volontà il poeta non arriva da nessuna parte.
Pian di Scò,
24 agosto 1993