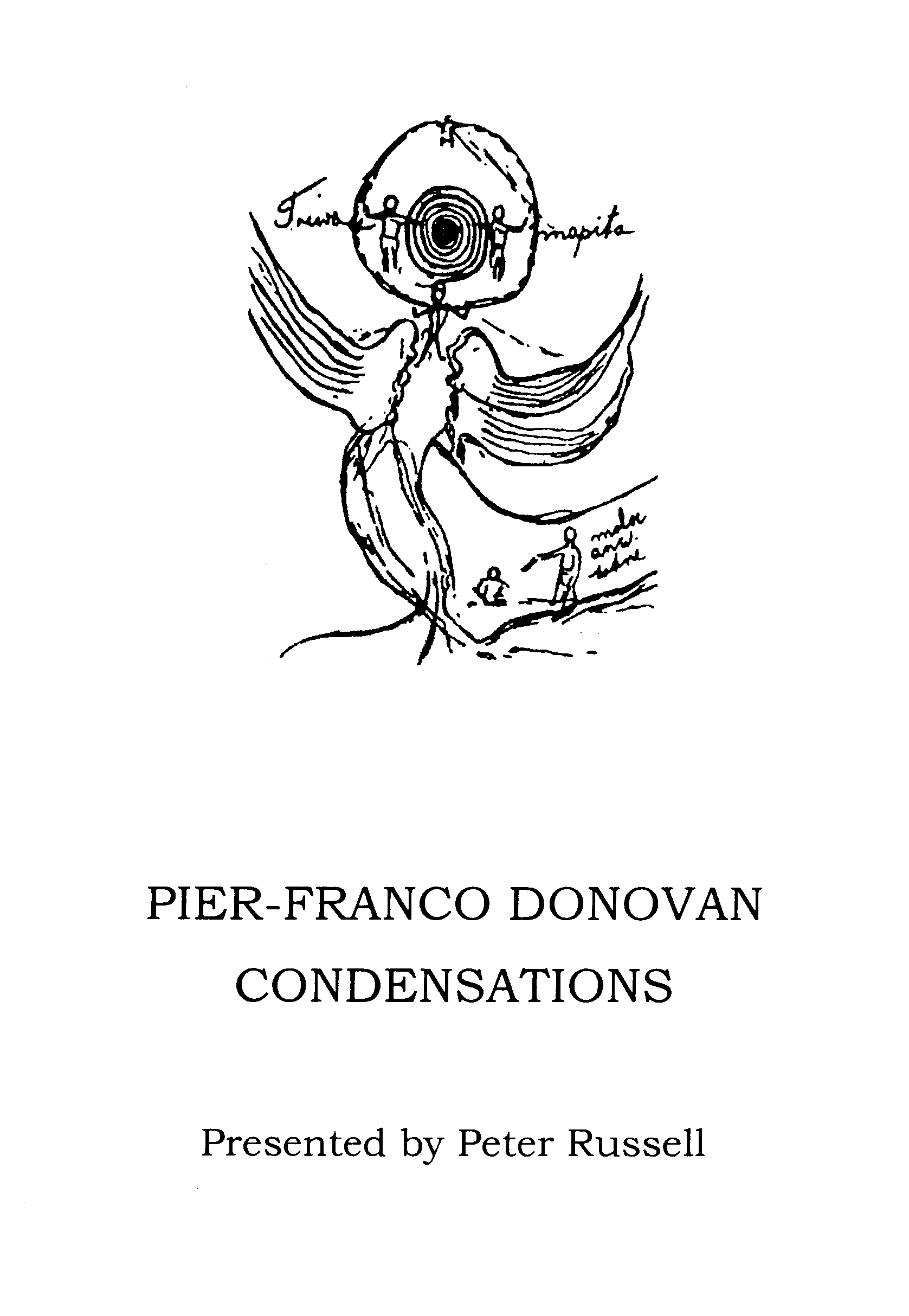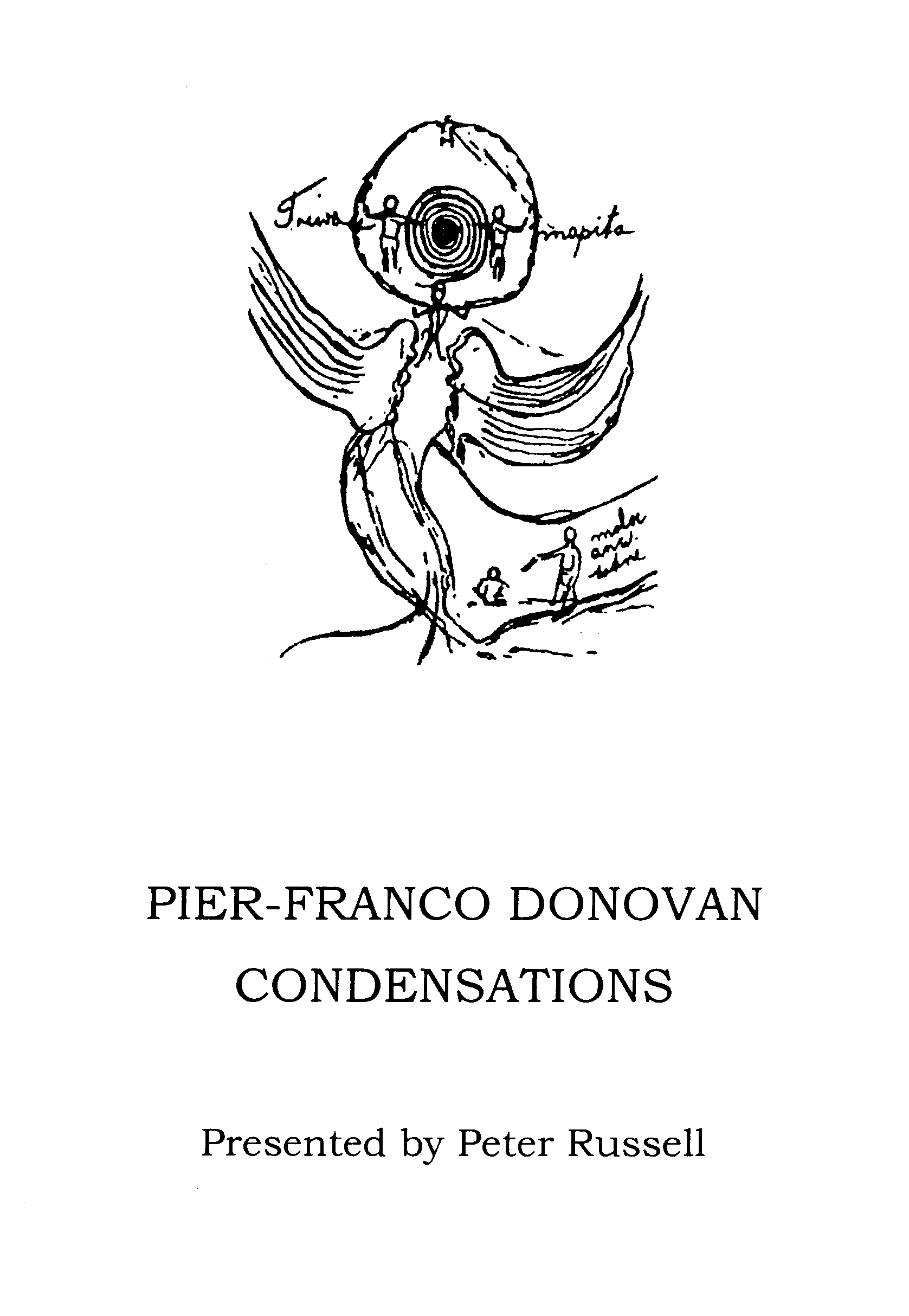Articolo pubblicato Domenica 17
dicembre 1995
La Poesia?
È un gioco con l'essenza
In tre libri di versi
le diverse anime del '900
di Franco Loi
Leggendo giorni fa alcuni scritti di Odisseas Elitis, mi ha colpito, fra
diversi altri, e ne parlerò presto, quello che recita: «La poesia è simile a un gioco,
pur senza esserlo affatto. Certamente anche nel gioco l'uomo si concentra, ma in maniera
tale da dimenticarsi dentro se stesso. Al contrario nella poesia, si concentra nella
profondità dell'Esserci». A me pare che qui Elitis voglia rammentare quello che Jung
chiama «il principio d'individuazione», cioè quel processo per cui l'Io porta la
propria consapevolezza all'interno del Sé. Ed è appunto questo il movimento che
distingue la poesia dalla chiacchiera, dall'enfasi sentimentale, dal ripiegamento
sdolcinato sulle memorie, e dal gioco mentale sulle parole.
Ne aveva, naturalmente, compresa l'avventura Giuseppe Ungaretti, quando nel
Primo Novecento, prescrisse il controllo della parola, il rispetto del silenzio, la
scarnificazione del dire. Anche se il suo fu poi interpretato, ancora una volta, come un
puro esercizio mentale, come un lavoro da compiersi su un prodotto della mente. Non mi
sembra perciò del tutto esatto affermare che «la Marniti accoglie di quella esperienza
(l'Ermetismo) la conquista fondamentale, l'essenzialità espressiva». Fu tra le sacche
della riduttività letteraria che l'Ermetismo trovò i suoi peggiori imitatori e i suoi
più disagevoli assertori. Biagia Marniti, molto elogiata negli anni Cinquanta e ora quasi
del tutto dimenticata dai media, scrive infatti versi come: «Non ha voce il
vento / che fa giocare le foglie» e «Anche nella buia terra / avrò il sorriso / per cui
piangevi» o «Cielo ti chiudi, / nel vento che corre e vano risuona» o, ancora, «Libera
luna dal volto costante / amore, pace non hai / nella distesa notte», versi tutt'altro
che controllati e spesso velati di sentimento. Certo, gli echi di Ungaretti sono ben
presenti in questo Racconto d'amore – c'è un intero vocabolario
ungarettiano in questa raccolta – che raccoglie poesie apparse su riviste fra il 1943
e il 1951 e che confluirono poi, sparse, nei libri Nero amore rosso amore e Più
forte è la vita, uscito nel '57 da Mondadori con prefazione, appunto, di Ungaretti.
Da tutt'altro versante proviene invece Gerardo Pedicini, un
beneventano-napoletano che ha attraversato le avanguardie, ma sembra rammentare le lezioni
di tanta poesia italiana del Novecento. D'altra parte, sarebbe interessante ribadire, da
parte di un critico, quanto tutta questa letteratura sia debitrice all'asse
Petrarca-Leopardi-D'Annunzio, e quanto dunque sia pretestuoso o spesso connesso al tempo e
alle sue attestazioni ideologiche stabilire delle differenze sostanziali. Ma, anche in
omaggio alla sua lunga disconosciuta militanza letteraria, voglio qui trascrivere alcuni
versi molto belli di questa nuova plaquette intitolata In attesa: «C'è
vento, vento d'aria / che scava l'ombra del digiuno / e nel sangue nuova meraviglia», «Per
noi il tempo / ha chiuso ogni dolcezza e accresce il lutto / il vivere in attesa», «Non
trovo più la strada, infilata / tra i rami ne è restata appena l'ombra / che sale come
nebbia e che dispare».
Infine voglio chiudere con un giovane poeta, Pier-Franco Donovan, di tutt'altra
estrazione. Scrive poesie in inglese e in italiano. È un americano che vive a Firenze,
molto amico di uno straordinario poeta inglese del tutto semi-ignorato in Italia, Peter
Russell, che qui è autore di una presentazione. Condensations è il titolo del
libretto, fatto stampare in due lingue da Institut für Anglistik und Americanistik
Universität Salzburg. Eccone pochi versi: «Il serpente succhia un uovo, / ne ha forato
il guscio e aspira, / succhia l'albume per arrivare al tuorlo» e «Fra gli scuri
accostati / il fumo di una sigaretta sale, / si incontra e si unisce a te».
Ma non si completa Elitis, se non si aggiunge: «Cosa significa il mito?
Primo, fiducia in quella luce che elude con un salto i procedimenti intellettuali e
afferra al volo quello che lo studioso riesce a chiarire e classificare solo dopo anni.
Secondo, l'amore per la materia non ha niente a che vedere con un amore materialistico per
la vita». Che si può anche tradurre, contro ogni ermetismo d'accatto, ma anche contro
ogni intellettualismo e gioco avanguardistico: «Ascolto dell'interezza del proprio essere
e della voce che si rivela attraverso l'intuizione, ma anche dare corpo e naturalità
materica attraverso la parola, compiere fino in fondo il movimento della creazione».
Poiché l'uomo è fatto di mente, ma anche di sensi e di emozioni. Ma l'uomo non può
prendere distacco, e quindi contemplazione, se non fondandosi sul tanto lavoro e la
rievocazione incessante della propria presenza, d'anima e di corpo.
Biagia Marniti, «Racconto d'amore»,
Greco & Greco Editori, via Sebenico 6, Milano 1995, pagg. 148, L. 10.000;
Gerardo Pedicini, «In attesa», con
segni grafici di Cosimo Budetta, Edizioni Etra/Arte e Laboratorio Ogopogo, Agromonte (Pz)
1995, S.i.p.;
Pier-Franco Donovan, «Condensations»,
Edwin Mellen Press, 240 Portage Road, Lewinston New York 14092 Usa 1995, pagg. 112, S.i.p. |