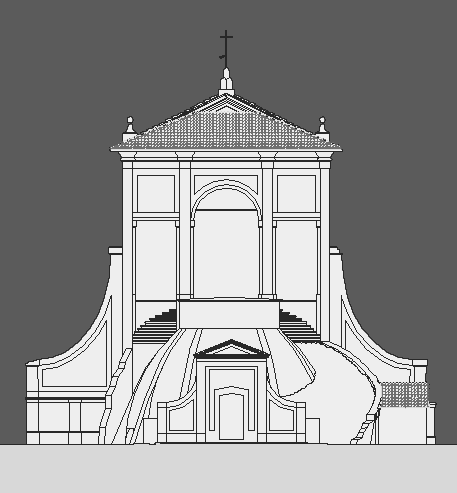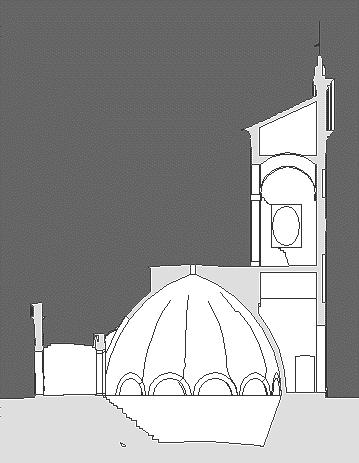LA GHIACCIAIA
La qualità primaria della ghiacciaia doveva essere quella di garantire la conservazione della maggior quantità possibile del prodotto in essa depositato. Per questo motivo la linea di sviluppo di questi edifici doveva tendere all’individuazione del massimo livello di isolamento termico. Ma questo discorso è vero solo in parte, in quanto si arrivò abbastanza presto all’individuazione della tipologia ideale (ghiacciaia tronco-conica coperta), che si rivelò però inadeguata alle nuove esigenze di capacità interna alla fine dell’800, quando, con l’utilizzo di ghiacciaie più capienti, l’inerzia termica della notevolissima quantità di ghiaccio riposto permise il superamento della limitazione formale della ghiacciaia tronco-conica. Come per le tipologie utilizzate nelle architetture preindustriali, le ghiacciaie più grandi potevano avere pianta rettangolare, grandi coperture in paglia o in cotto, a capanna o a padiglione, sorrette da grandissimi archi, da poderose capriate, da doppie file di altissimi pilastri che dividevano lo spazio interno in tre navate, come nelle grandi cattedrali.
Le prime ghiacciaie dovevano ricordare molto da vicino le antiche nevaie o neviere , cioè non erano altro che buche a forma di tronco di cono rovesciato scavate nel terreno, ricoperte nella parte esposta all’aria con strati di forte spessore di foglie con funzione di coibente. Questa forma non è né casuale e neanche frutto di particolari conoscenze geometriche e statiche, ma deriva da una attenta osservazione del comportamento del terreno ed è perciò il risultato di una ottimizzazione progressiva di tentativi empirici susseguitisi nel tempo. Infatti, ipotizzando di effettuare in un terreno di media coerenza uno scavo a pianta quadrata con pareti perfettamente verticali, dopo un certo periodo di tempo gli agenti esterni comincerebbero ad erodere le pareti dello scavo, provocando distacchi di materiale a partire dalle zone mediane dei lati del quadrato, ed il materiale tenderebbe ad accumularsi alla base della parete. Finché, dopo un po’, si otterrebbe una forma circolare in pianta e trapezoidale in sezione, con i lati obliqui inclinati secondo l’angolo di attrito del terreno. Si avrebbe, in altre parole, una buca a forma di tronco di cono rovesciato. Questa tipologia fu conservata anche successivamente, quando le pareti laterali ed il fondo furono costituiti da muratura in pietra, introdotta per evitare il contatto diretto del ghiaccio con il terreno permeabile all’acqua e all’aria e, conseguentemente, per limitare gli scambi termici. Scomparivano inoltre i fenomeni di erosione dovuti all’incoerenza del terreno ed agli agenti atmosferici. Infatti la pianta circolare rappresentava una buona soluzione statica per bilanciare la spinta del terreno sulla superficie laterale delle ghiacciaie. Tale spinta poteva considerarsi trascurabile nei periodi invernale, primaverile ed estivo, in quanto bilanciata dalla pressione interna del ghiaccio verso le pareti. Tuttavia nel periodo autunnale, quando la ghiacciaia era vuota, la spinta del terreno esterno, per di più reso pesante dalle ingenti piogge, diveniva considerevole ed in breve avrebbe danneggiato eventuali murature rettilinee, a meno che non avessero avuto uno spessore notevole ma antieconomico. La forma circolare invece scaricava le spinte centripete lungo le direttrici tangenziali alla circonferenza, con un comportamento assimilabile in pianta a quello di una serie di archi circolari disposti orizzontalmente lungo il perimetro. In questo modo era possibile limitare le dimensioni delle murature, che in genere non superavano i 60 centimetri anche in casi di ghiacciaie di 10-15 metri di diametro. Inoltre la forma tronco-conica era quella che, a parità di volume, sviluppava la minore superficie. Questo significa che veniva ridotta al minimo la superficie di contatto della massa ghiacciata con le pareti esterne, sulle quali erano esercitati gli scambi termici da limitare il più possibile. Al momento del passaggio dalla nevaia scavata nel terreno a quella in muratura sarebbe stato logico verticalizzare i muri di contenimento laterale, ed assumere come nuova tipologia il cilindro anziché il tronco di cono: oltre a semplificare la costruzione si sarebbe aumentata, a parità di diametro superiore, anche la capacità delle ghiacciaie. Il motivo per cui anche successivamente è stata in molti casi mantenuta l’inclinazione delle pareti si può spiegare come segue. La massa del ghiaccio, composta da blocchi di limitata dimensione saldati tra loro per la bassa temperatura, poteva essere assimilata ad un unico blocco congelato con la forma del suo contenitore. Nel periodo primaverile aumentava sensibilmente la temperatura dell’aria, e anche quella del terreno a partire dai livelli superiori, provocando lo scioglimento di una parte superficiale del ghiaccio. Nelle ghiacciaie tronco-coniche lo scioglimento del ghiaccio sul fondo permetteva un abbassamento della massa tale da riportare la superficie congelata a contatto con le pareti. In un’ipotetica ghiacciaia cilindrica, invece, l’abbassamento della massa avrebbe lasciato penetrare l’aria negli interstizi laterali, favorendo la formazione di fornelli di scioglimento, ed accelerando il processo di liquefazione. Il drenaggio dell’acqua di scioglimento avveniva attraverso una massicciata -o vespaio- costituita da grossi ciottoli di fiume sistemati l’uno accanto all’altro sul fondo della ghiacciaia. L’acqua veniva poi incanalata in piccoli condotti di scarico. Inizialmente le ghiacciaie a pianta circolare erano caratterizzate da coperture coniche leggere, con struttura portante in legno e rivestimento in paglia. La forte inclinazione del tetto -in genere superiore ai 45°- impediva che la neve vi si accumulasse. Le coperture di questo tipo necessitavano di continua manutenzione, soprattutto per la deperibilità del manto di rivestimento, facilmente attacabile dagli agenti esterni e dai parassiti. Questo sistema fu perciò abbandonato abbastanza rapidamente, ed in seguito vennero preferite le coperture a volta, a cupola o a falde. Sulla costruzione delle ghiacciaie
Riportiamo di seguito alcuni brani tratti da varie enciclopedie a cavallo del XIX e del XX sec. riguardo i vari sistemi costruttivi ed il miglioramento delle tecnologie. La Nuova Enciclopedia Italiana (Nuova Enciclopedia Italiana, a cura del Prof. Boccardo G., vedi voce Ghiacciaja, vol. X, Torino, 1880, p. 253.) approfondisce esaurientemente gli aspetti relativi al progetto e costituisce di per sé un prontuario contenente tutte le istruzioni per la costruzione di una ghiacciaja. (...) La prima cura da aversi nella costruzione di una ghiacciaja è di evitare che il calore esterno vi penetri: siccome però non si conoscono sostanze che isolino dal calore perfettamente o non abbiano per esso conducibilità alcuna, così riesce impossibile conservar tutto il ghiaccio che si raccogli, e se ne perde sempre una parte, la cui liquefazione coopera alla conservazione del rimanente. (...) La forma più comunemente adottata è quella di una specie di cono scavato nel terreno, con la punta in giù, e che viene coperto di tavole con sopravi canne. L’ingresso è sempre al norte, della forma di un piccolo corridojo con una porta al principio e al fine. Comunemente la ghiacciaja si costruisce in un boschetto, dovunque circondata da alberi che la difendano dai raggi del sole. (...) 1° Costruzione delle ghiacciaje ordinarie. - La prima avvertenza sarà quella di scegliere la posizione che offra un terreno alquanto elevato ed asciutto e difeso dai raggi solari. Si escava una fossa, ordinariamente colla imboccatura circolare, il cui diametro sia in relazione alla grandezza che dovrà avere l’ambiente; sia, per esempio, di metri 4 a 5; in tal caso la profondità sarà di circa metri 6, dando alla fossa la forma di tronco di cono rovescio con scarpa di m. 0,10 per metro; (...). È utile rivestire le pareti della fossa con un muro di mattoni o di pietre della grossezza di m . 0,30 a 0,50, unendo i materiali con buona malta di calce idraulica, e talora con semplice argilla. al centro del fondo si escava un piccolo pozzo del diametro di circa m. 0,6 e della profondità di un metro, destinato a ricevere l’acqua proveniente dalla fusione del ghiaccio. (...) Spesso si costruisce il tombino di scolo con una vaschetta, la cui capacità viene attraversata da un diaframma che parte dalla coperta del condotto e serve ad intercettare l’aria tostochè la vaschetta è ripiena di acqua. In un terreno molto permeabile e secco il fondo stesso della ghiacciaja può costituire il pavimento; allora basta tenere alquanto sollevato il ghiaccio, sopra legname e paglia, affinché non resti in contatto colla terra; ma se il fondo è umido, è necessario di stabilire un buon pavimento di laterizii in malta idraulica o di calcestruzzo. (...) Nella Lombardia trovansi molte ghiacciaje costrutte senza muratura, ma con una viminata per impedire lo scorrimento del terreno, e siccome scavando a poca profondità trovasi l’acqua, così si tiene elevato il fondo della fossa, e si compensa al difetto di profondità con un rialzo esterno all’ingiro, formato a scarpa, di bastante spessezza per mantenere una bassa temperatura. Sulla ghiacciaja si forma una grossa tettoja di paglia a cono diritto, sorretta da un’armatura di legnami che discende fino a m. 0,30 nel suolo e nel rialzo di terra. L’ingresso si pratica al nord mediante un vestibolo di circa m. 2,70 di lunghezza e m. 1,20 di larghezza, coperto pure di paglia da due serramenti di porte, l’una esterna, l’altra interna, per impedire la diretta comunicazione della ghiacciaja coll’aria esterna. Talora intorno alla ghiacciaja si costruisce un corridojo di m. 0,60 a 0,80 di larghezza con muri d’ambito della grossezza di m. 0,50, coperto col prolungamento del tetto della ghiacciaja, e serve a riporre le carni e gli altri oggetti da conservarsi. (...) Il vestibolo serve eziandio per tenere un piccolo deposito di ghiaccio, in quantità sufficiente pel bisogno di una giornata, risparmiando di entrare più volte al giorno nella ghiacciaja. Le ghiacciaje ordinarie sono talora coperte con una vôlta di muratura sostenuta dalle pareti della fossa; ed allora si può anche praticare sulla vôlta stessa un foro di ingresso da chiudersi ermeticamente con un coperchio di pietra. Allorché la volta riesce sepolta sotto il livello del terreno circostante, è utile rivestirla con uno strato di argilla battuta della grossezza di m. 0,30, onde allontanare il pericolo delle filtrazioni.(...) Allorché si costruisce una ghiacciaja in un terreno impermeabile od umido, ...può darsi si sia obbligati ad isolarla dal terreno circostante col mezzo di un muro di cinta lontano dal primo di metri 0,60. (...) Nel collocare il ghiaccio in queste ghiacciaje bisogna rivestire il fondo e le pareti di un denso strato di paglia, e coprirne ugualmente la massa quando è compiuta, coll’avvertenza che il ghiaccio sia bene stivato e compresso in modo da formare una massa il più possibile compatta, avvertendo di scegliere per tale operazione una bella giornata possibilmente fredda ed asciutta. (...) 2° Delle ghiacciaje americane. - M. Bordley, autore di questo sistema di ghiacciaje, ne parla all’incirca nel modo seguente (ndr. L’esperienza cui viene fatto riferimento è stata condotta nel 1771): « (...) ... anche nei pozzi più profondi il termometro segna circa 9° sopra la zero, e la ghiacciaja essendo ben chiusa, questi vapori ricadono sul ghiaccio non trovando fori pei quali possono uscire. Ne risulta: 1° che se una ghiacciaja non viene spesso aperta, essa non tarda a riscaldarsi, ed il ghiaccio vi si rammollisce alla superficie, fondendosi; 2° che nessuna profondità può preservare il ghiaccio dalla fusione, ed anzi troppa profondità è dannosa, perché il ghiaccio vi si trova più esposto al pericolo dell’umidità e quindi della fusione. (...) Coltivai l’idea di isolare dal terreno la massa di ghiaccio ponendola in un recipiente di legno elevato 3 decimetri dal suolo e distante 6 decim. dal recinto della ghiacciaja. La fossa fu escavata in un terreno esposto al vento ed al sole, allo scopo di mantenerla bene asciutta; la profondità fu di circa 3 metri; la cassa venne riposta nella fossa, e gli spazii tra questa e quella furono riempiti di paglia secca e pigiate, essendo questa il peggiore conduttore del calorico.... Coprii poscia la fossa con un piccolo tetto di tavole mal congiunte, più per preservarla dalla pioggia che per impedire l’accesso dell’aria. I fianchi di questa fabbrica erano elevati da 1,50 a 2 metri, e lasciai nel colmo del tetto uno spiraglio coperto. Anche sopra la cassa disposi uno strato di paglia, dopo introduzione del ghiaccio. ...esso si conservò senza fondersi, quanto una doppia quantità in altra ghiacciaja posta in un terreno secco ed arenoso, ma costruita col sistema ordinario ». (...) Per riempirla di ghiaccio si scelga un giorno freddo molto ed asciutto; prima di riporvelo vi si deve mettere al fondo un denso strato di paglia lunga incrocicchiata in tutti i versi, e devesi pur rivestire di paglia tutto l’interno, in guisa che il ghiaccio poggi sulla paglia e non tocchi le pietre. Stendesi prima uno strato di ghiaccio, che si batte bene per assodarlo. Sopra di questo se ne stende un altro successivamente, e così di seguito, procacciando che negli interstizii lasciati dai varii pezzi del ghiaccio non entri paglia; anzi si riempiono questi interstizii con pezzuoli di ghiaccio, e si adacquano un poco perché tutti gli strati formino una sola massa, e per estrarne il ghiaccio faccia d’uopo spezzarlo. riempita che sia la ghiacciaia copresi il ghiaccio con paglia, sopra cui pongonsi alcune tavole di pietre che tengono bene unita la paglia al ghiaccio. La neve può conservarsi ugualmente bene; si raccoglie in grossi mucchi, si batte, si comprime quanto è possibile in modo da non lasciarvi interstizii. Se la neve non si può consolidare come nei freddi eccessivi, è necessario aggiungervi un poco d’acqua, la quale unendosi alla neve e con essa congelandovi forma una sola massa. In Italia si scavano le ghiacciaje ai piedi di qualche monte e si fanno a cono, come abbiam detto. In una ghiacciaja appena costruita difficilmente si conserva bene il ghiaccio nel primo anno, principalmente se il muro non è asciutto abbastanza. Nella costruzione dei muri delle ghiacciaje devesi sempre adoperare la calce idraulica.
Analogamente si possono trovare descrizioni simili contenute nelle enciclopedie parigine di pochi anni dopo (Nouveau Larousse Illustré, Paris, 1898-1901 e La Grande Encyclopédie, H. Lamirault et C. Editeurs, Paris ):
Glacière - Encycl. Les glacières, destinées à conserver pendant plusieurs mois des approvisionnements de glace naturelle récoltée pendant l'hiver, sont constituées par des réservoirs dont les parois sont les plus souvent en briques. Ces glacières sont cylindriques et munies, à leur partie la plus basse, d'une sorte de puisard par où s'écoule l'eau provenant de la fusion de la glace emmagasiée. On donne encore le nom de glacière à des sortes d'armoires à compartiments, dans lesquelles on conserve des substances alimentaires, en faisant usage de glace naturelle placée en certains endroits de ces armoires . Glacière - Pour conserver la glace, on cherche à la mettre aussi complètement que possible à l'abri de la chaleur qui détermine sa fusion. Or, les corps qui entourent la glace peuvent lui céder de la chaleur, soit par conductibilité propre, soit par rayonnement. On doit done l'isoler per des matières qui réunissent aussi complètement que possible la double condition d'être mauvaises conductrices de la chaleur et athermanes. Le bois, ainsi que beaucoup d'autres substances d'un prix peu élevé, possède cette double propriété. La conservation de la glace n'offrirait donc aucune difficulté si l'on n'avait à s'occuper que de la chaleur transmise per les corps solides environnants, et cette condition se trouve réalisée dans certains cas. Ainsi, on a pu conserver de la glace pendant tout un été en l'enfouissant simplement sous un mètre de terre. Mais ce qui rend surtout la conservation de la glace difficile, c'est la présence des corps liquides et gazeux. Il faut qu'une glacière soit faite en materiaux aussi peu conducteurs que possible du calorique, veiller à ce qu'ils soient eux-mêmes à une température très basse au moment du dépôt et la garantir soigneusement de toute source de chaleur. On doit aussi tenir compte de ce fait que, proportionnellement, il se fond d'autant mions de glace que la glacière est plus grande et en contient davantage. Les glacières sont ordinairement des puits ayant la forme de troncs de cône renversés et dont les parois sont revêtues de maçonnerie. La partie supérieure est protégée soit par une petite voûte recouverte de terre, soit par une charpente de forme conique revêtue d'une couverture en chaume très épaisse. L'accès a lieu par une entrée unique placée au nord et munie d'une double porte. A la partie inférieure est ménagée une issue pour l'eau produite par la glace fondue. Sans cette dernière précaution, la contenu de la glacière serait bientôt mis en eau tout entir. Ces dispositions, bien que très fréquemment employées, ne sont pas les plus efficaces au point de vue de la conservation de la glace. Il n'est pas démontré, par example, que l'enfouissement soit toujours un avantage. Dans nos climats, en effet, le sol, à une très faible profondeur, offre une température supérieure à zéro dans toutes les saisons. La forme même en tronc de cône renversé paraît également mal choisie; car, si la chaleur vient principalement de l'extérieur, la plus grande surface de glace se trouve exposée de ce côté, il en fond proportionnellement une quantité plus grande. Enfin le conduit qui éloigne les eaux de fusion établit une communication permanente avec l'exterieur. Il conviendrait donc de placer la glacière au-dessus du sol, de donner à sa capacité la forme cubique ou cylindrique, de la construire plutôt en bois qu'en pierre, et surtout d'employer les doubles parois enfermant entre elles des couches d'air isolantes ou des matières très peu conductrices, telles que la paille, la mousse, le charbon, la sciure de bois. Cette sort de tour serait garantie au dehors par une masse de sable ou de terre sèche et couverte d'un plafond en charpente endiut des deux côtés, chargé et recouvert de paille. L'entrée, pratiquée dans la masse de terre, serait tournée au nord, garnie d'une porte double et précédée d'un appentis en paille. Le conduit d'évacuation des eaux de fusion serait disposé en siphon renversé, de manière à intercepter toute communication avec l'air extérieur. L’enciclopedia più recente che fa riferimento alle ghiacciaie risale al 1935, epoca in cui la produzione del ghiaccio comincia a diventare di tipo industriale; anche i materiali cambiano, vengono introdotti solai in ferro e laterizi, il cemento ed il calcestruzzo ( Grande Dizionario Enciclopedico Vol. V, UTET, Torino, 1935, p. 644.). Ghiacciaie - Le costruzioni, di carattere anche rudimentale, che hanno per iscopo di conservare durante la stagione calda il ghiaccio formatosi naturalmente durante l’inverno e di renderne possibile l’uso per scopi pratici, varii, prendono il nome generico di Ghiacciaie. (...) Ghiacciaie conservatrici del ghiaccio. - Quando la ghiacciaia è di questo tipo, si differenzia solamente per essere costruita o completamente sotterranea, o semisotterranea, o fuori terra. Nel primo caso, la parete esterna dei muri conviene rivestirla di pietrame, spalmandola di catrame o con un grosso strato di intonaco di cemento se la grossezza dei muri, tutto sommato, non è notevole, inferiore cioè ai cm 60. Nel terzo caso, e cioè quando la ghiacciaia sia fuori terra, è opportuno costruire invece le pareti relative a camera, cioè di legname, di cemento o di calcestruzzo, doppie, con interposte materie isolanti quali fieno, cascami, paglia, carbone di legna, ecc.. Nel secondo caso, si seguono accorgimenti concordanti con quelli precisati per le G. sotterranee e per quelle fuori terra. (...) Il pavimento deve essere preservato dalle irradiazioni del terreno, il che si ottiene nel modo migliore disponendo nelle fondamenta dei pilastri e su di questi girando delle voltine su piattabande gravanti in testa ai pilastri stessi. (...) ...le finestre devono essere ridotte ad un minimo, ad evitare che nella ghiacciaia entri un eccesso di aria esterna; l’unica porta dovrà avere accesso da tramontana ed i suoi battenti dovranno essere doppi o tripli, distanziati in modo da poterli aprire o chiudere consecutivamente ed alternativamente.... L’acqua piovana non deve entrare in ghiacciaia né superiormente, né lateralmente e tanto meno dal fondo, onde occorre raccoglierla in opportune grondaie; ...assai dannoso per gli scopi della ghiacciaia sarebbe il fatto che l’acqua, inevitabilmente condensata nel soffitto, ricadesse sul ghiaccio: siccome la quantità di acqua di condensazione producibile è massima, a parità di superficie, sulle pareti metalliche, non potendosi evitare tali generi di strutture, si dovranno adottare le imposte dei soffitti di speciali raccoglitori d’acqua. Circa il caricamento delle G. è indispensabile: a) effettuarlo nel periodo dei massimi geli; b) compierlo solo dopo di aver raffreddato completamente il locale, tenendo alcune ore ben aperta la porta; c) effettuarlo dall’alto, per mezzo di un’apertura ricavata nel soffitto, cosicché dalla stessa possa essere anche compiuta ogni ordinaria estrazione. (...)
|