

|
|
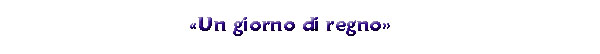 Torniamo ora alla prima esperienza
operistica del giovane Verdi e alle caratteristiche salienti di Oberto
conte di San Bonifacio. Nell’opera si riconoscono, anche se solo
parzialmente, alcuni elementi sia melodici sia ritmici L’esito dell’opera dovette comunque essere apprezzato da Merelli, se questi propose subito a Verdi un contratto per tre nuovi lavori, il primo dei quali avrebbe dovuto essere un’opera buffa. Le condizioni economiche proposte da Merelli furono allettanti per il musicista, che attraversava con la moglie Margherita, prostrata come e più di lui moralmente e fisicamente dopo la morte del piccolo Icilio, un momento difficilissimo. Verdi stesso scelse il libretto, un infelice testo intitolato Il finto Stanislao, già musicato vent’anni prima con modesto esito da un compositore boemo, Adalbert Gyrowetz. Narra lo stesso Verdi: Aveva comunque preso un impegno con l’impresario della Scala, aveva sottoscritto un contratto: doveva quindi rispettarlo. Un giorno di regno andò in scena il 5 settembre 1840 al Teatro alla Scala e segnò un clamoroso insuccesso, al punto che l’opera, dopo la prima rappresentazione, fu tolta dal cartellone e dal repertorio del Teatro. Il pubblico non risparmiò rumorosi dissensi che piovvero come fulmini sul capo del compositore. La critica non fu da meno: alle stroncature si alternarono feroci commenti ironici. L’opera, come si è detto, non ebbe alcuna replica e, ancor peggio, la ripresa di Oberto, che venne programmata subito dopo, sia a Milano sia in altre città italiane, ebbe accoglienze distratte e tiepide. In Un giorno di regno pare di riascoltare brani già noti, pessime imitazioni di Rossini e di Cimarosa, e scarse sono le pagine che contengono spunti interessanti o piacevoli. Il "fiasco" costituì per Verdi
una vera doccia fredda, tale da procurargli un periodo di acutissima crisi
e dal dissuaderlo totalmente dal comporre altre opere buffe, decisione
che il musicista mantenne valida almeno fino agli ultimi anni della sua
lunga vita, allorché, forte della grande esperienza, della fama
e del prestigio acquisiti e ormai incontestabili, riprenderà il
genere buffo, trattandolo con grande spirito e senso dell’ironia in quello
che sarà il suo ultimo capolavoro, Falstaff.
|
