
Lunghi mesi, per Verdi, seguirono
all’insuccesso e furono per lui molto penosi. Non riuscì a superare
scoraggiamento e depressione: nulla, pareva, avrebbe potuto distogliere
il musicista dal suo solitario dolore.
Una sorta di abulia gli impediva
di mangiare, di cercare il conforto e la compagnia degli amici, perfino
di lavorare. In questo stato d’animo, come avrebbe affrontato il prossimo
impegno che l’attendeva e che gli derivava dal contratto sottoscritto con
Merelli? Un nuovo libretto, infatti, gli era stato proposto, dal titolo
Il
proscritto, ma Verdi per lungo tempo non vi mise mano.
Ma nuove circostanze avrebbero contribuito
a risollevare lo spirito del musicista da una situazione per lui tanto
angosciante.
Merelli aveva affidato un libretto
di Temistocle Solera, riguardante la storia del re babilonese Nabucodonosor,
al musicista tedesco Nicolai, il quale tuttavia non aveva accettato di
musicarlo. L’impresario pensò allora di attuare uno scambio tra
i soggetti destinati ai due musicisti: diede a Nicolai il libretto del
Proscritto
e si incontrò quindi con Verdi. Secondo quanto riferirà lo
stesso Verdi, Merelli gli disse:
Ecco qui il libretto di Solera!
Un così bell’argomento, e rifiutarlo! [...] Prendi, leggilo [...]
e poi me lo riporterai.
Prosegue il musicista:
Rincasai e con un gesto quasi violento
gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomici ritto in piedi davanti.
Il fascicolo cadendo sul tavolo stesso si era aperto: senza sapere come
i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia
questo verso: "Va pensiero sull’ali dorate". Scorro i versi seguenti e
ne ricevo una grande impressione [...] Leggo un brano, ne leggo due: poi,
fermo nel proposito di non scrivere, faccio forza a me stesso, chiudo il
fascicolo e me ne vado a letto! [...] Il sonno non veniva; mi alzo e leggo
il libretto, non una volta, ma due, ma tre, tanto che al mattino si può
dire che io sapevo a memoria il libretto di Solera.
Verdi si entusiasmò per quelli
che gli parvero i due pregi più rilevanti del soggetto, ossia la
bellezza della storia narrata e la grandiosità di alcune scene.
Ben presto la decisione fu presa e il musicista iniziò alacremente
a mettere in musica le vicende di Nabucco.
Com’era già accaduto per Oberto,
Verdi ebbe l’appoggio efficace e prezioso di Giuseppina Strepponi, che
avrebbe interpretato nella nuova opera il ruolo femminile principale, quello
di Abigaille, ruolo che, richiedendo tra l’altro notevole temperamento
drammatico, la cantante considerò particolarmente congeniale ai
suoi mezzi vocali, quasi fosse stato progettato su misura per le sue caratteristiche
tecniche ed espressive.
Qualche controversia sorse con Merelli
circa la data di rappresentazione dell’opera. L’impresario intendeva infatti
diluire le spese di gestione della stagione scaligera, procrastinando la
messa in scena di Nabucco e spostando di conseguenza la "prima"
dal marzo 1842 all’inizio dell’anno successivo. Dopo reiterate insistenze
e accese discussioni con l’impresario, Verdi ottenne infine la riconferma
della data originaria; Merelli, dal canto suo, gli annunciò che,
per contenere le spese, avrebbe utilizzato per l’opera costumi e scenari
"di seconda mano", provenienti cioè da altri allestimenti teatrali.
Le prove iniziarono nella seconda
metà di febbraio. Si instaurò subito nel teatro, tra professori
d’orchestra e cantanti, un clima di tensione, di attiva partecipazione
e di straordinario impegno; la prima esecuzione, che ebbe luogo il 9 marzo
1842, riscosse grande successo, fu un vero e proprio trionfo. Verdi stesso
ne fu entusiasmato:
Con quest’opera si può veramente
dire che ebbe principio la mia carriera artistica: e se dovetti lottare
contro tante contrarietà è certo però che il Nabucco
nacque sotto una stella favorevole giacché anche tutto ciò
che poteva riuscire male contribuì invece in senso favorevole [...]
costumi raffazzonati alla meglio riescono splendidi! Scene vecchie, riaccomodate,
sortono invece un effetto straordinario [...]. La prima scena del tempio
in specie produce un effetto così grande, che gli applausi del pubblico
durano dieci minuti!
 Si
rafforzano, in Nabucco, alcune delle peculiarità già
fuggevolmente delineate in Oberto e che avrebbero in seguito contraddistinto
e caratterizzato l’opera del maestro: una tensione drammatica che scaturisce
da profonda connessione e compenetrazione fra il testo e la sua espressione
musicale, attraverso le quali Verdi realizza una perfetta sintesi espressiva;
l’utilizzazione del coro in ruoli di primo piano, con funzioni narrative
fortemente accentuate. Si
rafforzano, in Nabucco, alcune delle peculiarità già
fuggevolmente delineate in Oberto e che avrebbero in seguito contraddistinto
e caratterizzato l’opera del maestro: una tensione drammatica che scaturisce
da profonda connessione e compenetrazione fra il testo e la sua espressione
musicale, attraverso le quali Verdi realizza una perfetta sintesi espressiva;
l’utilizzazione del coro in ruoli di primo piano, con funzioni narrative
fortemente accentuate.
Inoltre, la sinfonia che introduce
l’opera racchiude in sé i principali temi musicali che, nello svolgimento
della vicenda teatrale, ne rappresenteranno i punti salienti che puntualizzeranno
il percorso narrativo. Si rilevano peraltro, nell’opera, momenti imitativi
di autori all’epoca già noti e stimati dal pubblico dei teatri di
tutta Italia, come Bellini e Donizetti; tuttavia la personalità
di Verdi acquista una maggiore consistenza e originalità.
Lo straordinario successo di Nabucco
(8)
rappresentò anche l’inizio della progressiva, crescente celebrità
di Verdi. Il pubblico si impossessò immediatamente dei brani più
orecchiabili, li diffuse e ne decretò la popolarità. Ma c’è,
nella nuova opera, un altro elemento che, senza dubbio – e molto probabilmente
senza che il musicista stesso l’avesse scientemente evocato – contribuì
in modo determinante a convogliare verso Verdi simpatie e favori del pubblico.
Il reale protagonista di Nabucco è, infatti, il popolo ebreo
che esprime, con il suo canto, la nostalgia per la patria perduta e il
dolore per l’oppressione a cui era sottoposto a causa della schiavitù
impostagli da un oppressore straniero.
Ebbene, nelle vicende narrate nell’opera,
e soprattutto in quei "clivi" e "colli" invocati dal coro nel "Va pensiero",
chi assistette all’opera di Verdi individuò le proprie terre, i
propri luoghi conquistati e dominati da popoli stranieri; la gente di Milano
riconobbe se stessa, sottomessa al giogo austriaco. E tutto ciò
in un periodo già fortemente segnato da accese aspirazioni all’indipendenza
nazionale.
Ciò che emerge, dopo l’esperienza
di Nabucco,
sono i sentimenti elementari del
Risorgimento che trasposti in un’allegoria di immediata risonanza popolare
diventano dialettica di valori morali [...] È il procedimento che,
con i più diversi contenuti, si ritrova in tutto Verdi fino all’Aida
compresa e che fa delle sue opere il solo fatto socialmente unitario che
l’arte italiana dell’Ottocento abbia conosciuto, il solo in cui il quarto
stato abbia fatto sentire la sua voce senza complessi di inferiorità.
(9)
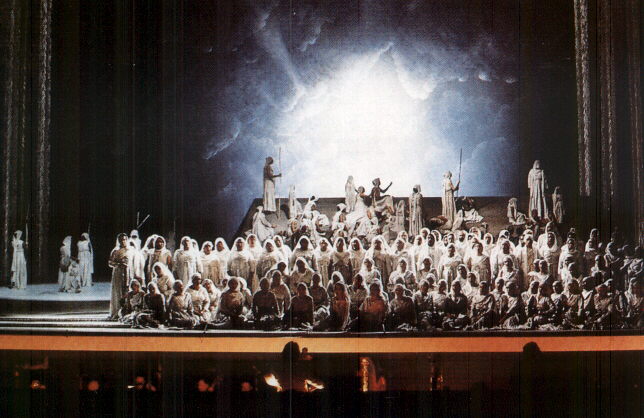 Verdi
rappresentò in tal modo, e fu di fatto l’interprete, della prima
fase del nascente Risorgimento italiano, e il coro del Nabucco divenne
il simbolo di una patria ridotta in schiavitù, ma attraversata da
una potente volontà unitaria di liberazione. Verdi
rappresentò in tal modo, e fu di fatto l’interprete, della prima
fase del nascente Risorgimento italiano, e il coro del Nabucco divenne
il simbolo di una patria ridotta in schiavitù, ma attraversata da
una potente volontà unitaria di liberazione.
Oltre alla popolarità, e al
traguardo artistico raggiunto dal compositore, altri aspetti furono gratificanti
per Verdi: Nabucco venne incluso nel cartellone scaligero del 1843,
in apertura di stagione e se ne realizzarono ben 57 repliche. Per la ripresa
dell’opera Merelli gli propose un contratto nel quale la cifra del compenso
non venne precisata: fu indicata dallo stesso Verdi, dopo che questi ebbe
chiesto consiglio a Giuseppina Strepponi – con la quale il rapporto di
amicizia e stima si era nel frattempo fatto sempre più stretto –
in 8000 lire austriache, che corrispondevano a quanto percepito da Bellini,
peraltro già famoso, per la sua Norma.
Dopo Nabucco, inoltre, Verdi
fu ospite contesissimo di parecchie famiglie dell’aristocrazia milanese,
oltre che degli editori Ricordi e Lucca. Fu accolto nel salotto della contessa
Maffei, come in quelli delle contesse Appiani, Marignano, Emilia Morosini
e di sua figlia Giuseppina, futura contessa Negroni Prati. (10)
Il musicista instaurò in tal
modo una serie di rapporti che si tramutarono anche in profonde amicizie
che avrebbe coltivato, anche epistolarmente, per lungo tempo, in alcuni
casi – come in quello con la contessa Maffei – per tutta la vita.
L’eco dell’accoglienza riservata
a Nabucco giunse rapidamente anche ad altri teatri: entro breve
tempo la direzione della Fenice gli chiese di comporre un’opera per Venezia,
invito che il musicista accolse con entusiasmo.
Infine, dopo Nabucco, Verdi
fece una breve apparizione a Busseto, dove fu letteralmente osannato.
 Andò
pure a Bologna per assistere a una esecuzione dello Stabat Mater
di Rossini diretto da Gaetano Donizetti. In tale occasione conobbe il musicista
pesarese, e su questo incontro scrisse alla contessa Emilia Morosini: Andò
pure a Bologna per assistere a una esecuzione dello Stabat Mater
di Rossini diretto da Gaetano Donizetti. In tale occasione conobbe il musicista
pesarese, e su questo incontro scrisse alla contessa Emilia Morosini:
[...] Sono stato a visitare
Rossini il quale mi ha accolto assai gentilmente e l’accoglienza mi è
parsa sincera. Comunque sia, io ne sono stato contentissimo. Quando penso
che Rossini è la reputazione vivente, io mi ammazzerei e con me
tutti gli imbecilli... Oh, è una gran cosa essere Rossini! (11)
____________________
(8) L'opera venne stampata
da Ricordi con questa dedica: “Posto in musica e umilmente dedicato a S.A.I.
la serenissima Arciduchessa Adelaide d'Austria, il 31 marzo 1842, da Giuseppe
Verdi”. Il musicista ricevette da Ricordi un compenso di 3000 lire austriache.
(9) F. D'Amico, “I casi della
musica - Verdi e il quarto stato”, in L'opera italiana; riportato in R.
Tedeschi, “Verdi. Risorgimento e decadenza”, in Storia d'Italia, Einaudi,
Torino 1973.
(10) Nei “salotti” milanesi
dell'epoca, vere e proprie “fucine culturali” più che luoghi d'incontro
mondani, si riunivano spesso letterati, pittori, scultori, musicisti e,
specie in quello della Maffei, alcuni patrioti italiani, impegnati nelle
nascenti società segrete - come la “Giovane Italia” di Mazzini -
che cospiravano in favore della liberazione e dell'unità d'Italia.
(11) In tempi successivi,
pare che anche Rossini, con quel particolare senso dell'umorismo che lo
contraddistingueva, abbia espresso un giudizio su Verdi, definendolo “compositore
con l'elmetto”; alludeva probabilmente al copricapo dei numerosi guerrieri
spesso presenti nelle opere di Verdi e a una certa qual “rudezza” sonora
da lui rilevata nei lavori verdiani. A proposito di una partitura di Verdi
(pare si trattasse di quella dell’opera Attila) Rossini disse: “Se
non mi fosse stato noto il nome del compositore, avrei scommesso che si
trattasse di un colonnello di artiglieria”.
____________________
|
Stai ascoltando l'Ouverture
dal Nabucco
|
|