..
 Nuovi
impegni si prospettavano frattanto per Verdi: anzitutto avrebbe dovuto
comporre una nuova opera per il teatro La Fenice di Venezia. Il musicista
riprese in considerazione il teatro di Shakespeare
dal quale, come già accennato, si sentiva particolarmente attratto. Nuovi
impegni si prospettavano frattanto per Verdi: anzitutto avrebbe dovuto
comporre una nuova opera per il teatro La Fenice di Venezia. Il musicista
riprese in considerazione il teatro di Shakespeare
dal quale, come già accennato, si sentiva particolarmente attratto.
Sapete che non bisogna fare del
Re
Lear un dramma colle forme presso a poco fin qui usate, ma trattarlo
in una maniera del tutto nuova, vasta, senza riguardo a convenienze di
sorta
scrisse nel febbraio 1850 a Cammarano,
al quale intendeva affidare la redazione di un libretto tratto dalla tragedia
shakespeariana. L’impresario Escudier gli propose anche, sempre nel 1850,
di musicare La tempesta, e Verdi, a sua volta, gli scrisse:
Sta nelle mie idee di musicare
La
tempesta, come sta pure nelle mie idee di fare lo stesso dei principali
drammi del gran tragico.
E ancora, rivolgendosi a Giulio Carcano,
traduttore di Shakespeare, Verdi dichiarò a proposito di Amleto:
Mi sarebbe stato carissimo associare
il mio nome al tuo, persuaso che se tu mi proponi di musicare l’Amleto,
deve essere riduzione degna di te [...]
Ora se il Re Lear è
difficile, l’Amleto lo è ancor più; e stretto come
sono da due impegni, ho dovuto scegliere argomenti più facili e
brevi per poter adempiere ai miei obblighi.
In realtà, Verdi realizzerà
solamente al termine della propria carriera, e grazie alla collaborazione
con un prestigioso poeta, musicista egli stesso, Arrigo Boito, il desiderio
di trasporre in musica, realizzando altrettanti capolavori, Otello
e
Falstaff,
tratti da altre opere (18) del grande drammaturgo inglese.
Per approntare la partitura destinata
al teatro La Fenice, il musicista scelse un dramma di Victor Hugo, Le
roi s’amuse, al quale diede, in un primo momento, quale nuovo titolo
La
maledizione.
Il soggetto si incentrava principalmente
sul libertinaggio di un sovrano ed era un’opera letteraria vietata a Parigi,
cosicché anche a Venezia intervenne la censura, nella persona del
governatore militare austriaco Gorzowsky il quale aveva tra le sue prerogative
appunto quella di esercitare la censura preventiva sugli spettacoli e sulle
pubblicazioni.
Sequestrò il libretto di Piave
tre mesi prima della rappresentazione dell’opera alla Fenice, inoltrando
il seguente messaggio:
Gorzowsky [...] deplora che il
poeta Piave ed il celebre Maestro Verdi non abbiano saputo scegliere altro
campo per far emergere i loro talenti, che quello di una ributtante immoralità
e oscena trivialità qual è l’argomento del libretto intitolato
La
maledizione [...]
Verdi scrisse a sua volta a Marzari,
nuovo presidente della Fenice:
Senza questa maledizione quale
scopo, quale significato ha il dramma? Il Duca diventa un carattere nullo:
il Duca deve essere assolutamente un libertino; senza di ciò non
si può giustificare il timore di Triboletto che sua figlia sorta
dal suo nascondiglio, senza di ciò è impossibile questo dramma
[...] Non capisco perché siasi tolto il sacco: cosa importava del
sacco alla polizia? Temono dell’effetto? Ma mi si permetta dire, perché
ne vogliono sapere in questo più di me? [...] Tolto quel sacco non
è probabile che Triboletto parli una mezza ora a un cadavere prima
che un lampo venga a scoprirlo per quello di sua figlia. Osservo infine
che si è evitato di fare Triboletto brutto e gobbo! Per qual motivo?
Un gobbo che canta, dirà taluno! E perché no?... Farà
effetto? non lo so, ma se non lo so io, non lo sa, ripeto, neppure chi
ha proposto questa modificazione [...] dico francamente che le mie note
o belle o brutte che sieno non le scrivo a caso, e che procuro sempre di
darle un carattere.
La controversia si risolse alla fine
– dopo un interminabile scambio di lettere tra Busseto, dove Verdi si era
rifugiato per lavorare in un ambiente che gli garantisse quiete e tranquillità,
e Venezia – con una serie di cambiamenti concordati con i funzionari della
censura che, tra l’altro, prevedevano che
1. L’azione si trasporterà
dalla Corte di Francia a quella d’uno dei Duchi indipendenti di Borgogna,
di Normandia, o di taluno dei piccoli Principi assoluti degli Stati italiani,
e probabilmente alla Corte di Pier Luigi Farnese ed all’epoca che converrà
meglio di assegnarvi pel decoro e la riuscita della scena.
2. Si conserveranno i tipi originali
dei caratteri di Victor Hugo del dramma Le roi s’amuse, cangiando
i nomi dei personaggi a seconda della situazione ed epoca che verrà
prescelta.
3. Si eviterà affatto la scena
in cui Francesco [che diverrà, nell’edizione definitiva, il Duca
di Mantova], si dichiarava risoluto di profittare della chiave di cui era
in possesso per introdursi nella stanza della rapita Bianca [il personaggio
cambierà il suo nome in Gilda]. E ciò sostituendovi altra
scena, che conservi la necessaria decenza, senza togliere l’interesse del
dramma.
4. Al rendez-vous amoroso nella taverna
di Magellona [Maddalena] il Re o Duca andrà invitato da un inganno
del personaggio che sostituirà Triboletto [il nome del personaggio
verrà mutato in quello di Rigoletto, che darà infine il titolo
all’opera].
5. Alla apparizione del sacco contenente
il corpo della figlia di Triboletto, si riserva il Maestro Verdi all’atto
pratico quelle modificazioni che saranno reputate necessarie.
 La
maledizione, ribattezzata Rigoletto,
andò in scena a Venezia, al teatro La Fenice, l’11 marzo 1851 ed
ebbe un’accoglienza trionfale. Quest’opera segnò per il musicista
l’inizio di un nuovo periodo creativo nel quale Verdi pose la musica totalmente
al servizio dell’espressione di una gran varietà di sentimenti e
di situazioni emotive, dalla gioia al dolore, dalle lacrime al sorriso.
In ciò Verdi dimostrò, come prima non era ancora avvenuto,
la sua appartenenza al Romanticismo, obbedendo esattamente a precetti indicati,
tra gli altri, dallo stesso Hugo, in virtù dei quali il teatro romantico
doveva racchiudere in sé motivi, accenti e generi diversi, ispirandosi
sostanzialmente alle quotidiane realtà più che alle vicende
contemplate dai soggetti trattati nella tragedia classica. Contemporaneamente,
i brani lirici, le arie, hanno, allo stesso modo dei recitativi, la loro
sostanza nella materia drammatica, e forniscono quindi una tensione continua
all’opera musicale, dandole di conseguenza un’unitarietà e una vitalità
complessiva molto accentuate. La
maledizione, ribattezzata Rigoletto,
andò in scena a Venezia, al teatro La Fenice, l’11 marzo 1851 ed
ebbe un’accoglienza trionfale. Quest’opera segnò per il musicista
l’inizio di un nuovo periodo creativo nel quale Verdi pose la musica totalmente
al servizio dell’espressione di una gran varietà di sentimenti e
di situazioni emotive, dalla gioia al dolore, dalle lacrime al sorriso.
In ciò Verdi dimostrò, come prima non era ancora avvenuto,
la sua appartenenza al Romanticismo, obbedendo esattamente a precetti indicati,
tra gli altri, dallo stesso Hugo, in virtù dei quali il teatro romantico
doveva racchiudere in sé motivi, accenti e generi diversi, ispirandosi
sostanzialmente alle quotidiane realtà più che alle vicende
contemplate dai soggetti trattati nella tragedia classica. Contemporaneamente,
i brani lirici, le arie, hanno, allo stesso modo dei recitativi, la loro
sostanza nella materia drammatica, e forniscono quindi una tensione continua
all’opera musicale, dandole di conseguenza un’unitarietà e una vitalità
complessiva molto accentuate.
Al pubblico piacque questo nuovo
modello di rappresentazione teatrale, mentre la critica, soprattutto a
Londra e a Parigi, tardò a comprendere i nuovi stilemi di cui l’opera
stessa era portatrice. La "Gazette musicale" di Parigi, per esempio, accusò
apertamente Verdi di ... chercher à modeler son harmonie sur
les grands maîtres de l’école allemande. (19)
Infine, con l’intransigenza e la
scarsa attitudine alla musica che lo contraddistinguevano, Victor Hugo
proibì che l’opera di Verdi fosse messa in scena in Francia. Fu
necessario intentare un’azione legale perché Rigoletto, dopo
sei anni dalla sua trionfale rappresentazione a Venezia e dopo che l’opera
era apparsa, ottenendo altrettanti successi, in numerosi teatri italiani
e a Londra, potesse infine venire allestita anche a Parigi, dove riscosse
un plauso senza precedenti ed ebbe cento repliche nel corso di un solo
anno. Molto tempo dopo questo nuovo trionfo, anche Hugo volle assistere
a una rappresentazione di Rigoletto: fu particolarmente colpito
dal "Quartetto" del terzo atto (20) e si rese conto che l’opera, ben lungi
dal nuocere al suo lavoro letterario, era una creazione artistica degna
perfino della sua ammirazione...
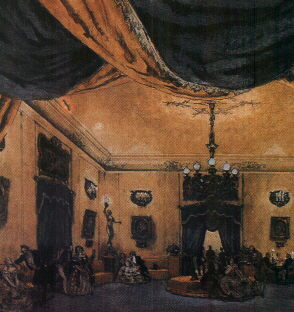 Dopo
un breve periodo di riposo a Sant’Agata, in dicembre Verdi partì
con Giuseppina Strepponi per Parigi, dove assistette, nel successivo mese
di febbraio, a La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio.
L’effetto suscitato dalla commedia sul musicista dovette essere straordinario,
se gli fece nascere repentinamente l’idea di trasporre in musica il lavoro
teatrale. Ben presto il progetto prenderà forma, e si tradurrà
in una nuova opera, La traviata, che
Verdi comporrà per il teatro La Fenice di Venezia. Dopo
un breve periodo di riposo a Sant’Agata, in dicembre Verdi partì
con Giuseppina Strepponi per Parigi, dove assistette, nel successivo mese
di febbraio, a La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio.
L’effetto suscitato dalla commedia sul musicista dovette essere straordinario,
se gli fece nascere repentinamente l’idea di trasporre in musica il lavoro
teatrale. Ben presto il progetto prenderà forma, e si tradurrà
in una nuova opera, La traviata, che
Verdi comporrà per il teatro La Fenice di Venezia.
Nel corso del 1852 Verdi lavorò
a un’altra opera teatrale: da El Trobador, dello spagnolo Gutiérrez,
il musicista diede incarico a Cammarano di trarre il libretto: Cammarano,
però, morì il 17 luglio 1852, dopo aver portato a termine
solamente i primi tre atti del dramma; per la stesura del quarto e ultimo
atto del Trovatore venne incaricato
un giovane poeta, Leone Emanuele Bardare. L’opera avrebbe dovuto essere
rappresentata a Napoli; le trattative con gli impresari napoletani non
ebbero però buon esito e Verdi sottoscrisse nuovi accordi per la
messa in scena dell’opera con Jacovacci, dirigente del Teatro Apollo di
Roma, dove in effetti Il trovatore verrà allestito il 19
gennaio 1853.
Malgrado l’atmosfera complessivamente
tetra e cupa, per taluni aspetti addirittura macabra – con tutti quei morti
avvelenati, decapitati e bruciati, sfuggiti non si sa come alle maglie
della censura pontificia, peraltro intervenuta su altri aspetti relativi
al libretto – l’opera ebbe un successo entusiastico.
Gli impresari parigini si interessarono
immediatamente a quest’ultimo lavoro, ancora oggi considerato tra le massime
creazioni del genio verdiano: trattative e accordi si intrecciarono e infine
Il
trovatore venne allestito al Théâtre Italien di Parigi
il 23 dicembre 1854.
Era caratteristico, a Parigi, lo
stile cosiddetto del "Grand-opéra": (21) nel 1857, Il trovatore
verrà rappresentato al teatro dell’Opéra e, proprio per obbedire
ai canoni del genere in voga nella capitale francese, Verdi vi inserirà
quattro azioni coreografiche.
A Roma, all’epoca in cui si svolgevano
le prove del Trovatore e mentre Verdi si dedicava all’allestimento
della partitura orchestrale, il musicista lavorò alacremente a una
nuova opera: commissionatagli dal teatro 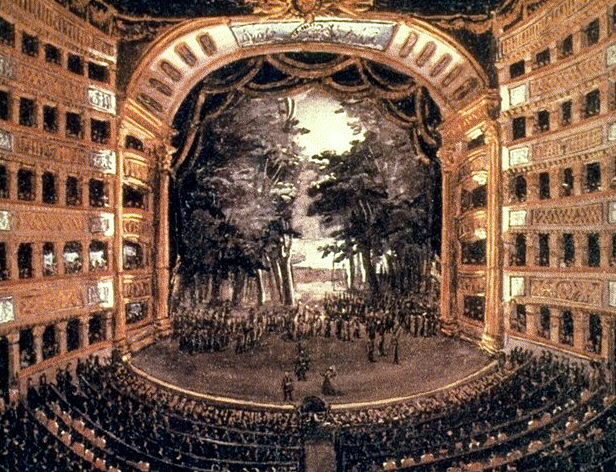 La
Fenice, sarà La traviata, il dramma di Dumas, alla cui rappresentazione,
come si è detto, Verdi aveva assistito in occasione di un precedente
soggiorno parigino. (22) La
Fenice, sarà La traviata, il dramma di Dumas, alla cui rappresentazione,
come si è detto, Verdi aveva assistito in occasione di un precedente
soggiorno parigino. (22)
Ancora una volta Verdi dovette affrontare
le obiezioni della censura. L’ostacolo fu però in questa occasione
superato abbastanza agevolmente ambientando l’azione teatrale nel Settecento
e cambiando nome ai personaggi originari.
Un’altra preoccupazione angustiava
tuttavia il compositore: quella riguardante la compagnia di canto ingaggiata
dalla direzione del teatro veneziano. A questo proposito, Piave scrisse
al presidente della Fenice riferendogli quanto Verdi stesso gli aveva dichiarato:
La presidenza [...] artisticamente
ha torto, perché non solo la Salvini (24) ma l’intera compagnia
è indegna del Gran Teatro La Fenice [...]. Dichiaro che nel caso
si dia l’opera, non ne spero niente sull’esito [...].
La traviata andò in scena
il 6 marzo 1853 e registrò uno degli insuccessi più clamorosi
nella storia del melodramma. Dopo la prima replica di Traviata,
Verdi stesso, in una lettera a Vincenzo Luccardi (24) si espresse in questi
termini:
Non ti ho scritto dopo la prima
recita della Traviata: ti scrivo dopo la seconda. L’esito è
stato fiasco! Fiasco deciso! Non so di chi sia la colpa: è meglio
non parlarne. Non ti dirò nulla della musica e permettimi che nulla
ti dica degli esecutori [...].
Amareggiato, il musicista si ritirò
poi a Sant’Agata, e successivamente partì per Parigi, dove soggiornò
a lungo e dove avvierà una nuova e proficua fase di collaborazione
con il teatro dell’Opéra.
Frattanto, alcuni amici del musicista,
Antonio Somma, Cesare Vigna e Antonio Gallo, gestore di un altro teatro
veneziano, il San Benedetto, convinti della eccellente qualità di
Traviata
e del fatto che l’insuccesso fosse da attribuirsi solamente all’apporto
negativo fornito dai cantanti, progettarono di rimettere in scena l’opera:
la riproposero, infatti, con cinque pezzi nuovi, "alcuni trasporti di tono,
e qualche puntatura" (25) e ovviamente con una compagnia di canto del tutto
inedita La nuova rappresentazione, che ebbe luogo il 6 maggio 1854, ricevette
ampi consensi. La "Gazzetta ufficiale di Venezia" dell’8 maggio riportava:
Il tempo, prima o dopo, rende giustizia
a’ grandi ingegni [...] il carattere particolare di questa musica è
la somma eloquenza delle sue frasi, quel sublime magistero di suoni, onde,
col dialogo e il discorso degl’istrumenti, il maestro, se non vi dipinge
il pensiero, vi svolge le situazioni del dramma, ve ne suscita, senza uopo
della parola, la passione tutta [...] Chi tiene qui asciutto il ciglio,
egli non ha in petto umano cuore e tiene della rupe e del macigno.
Le tre opere, Rigoletto, Il
trovatore, La traviata, composte in rapida successione, e divenute
notissime come «trilogia popolare»,
contrassegnano la raggiunta maturità artistica del musicista
e sanciscono inequivocabilmente la sua concezione drammaturgica, oltre
a dare piena dimostrazione di quanto Verdi padroneggiasse ormai in maniera
perfetta i propri mezzi espressivi. La profonda diversità dei tre
drammi musicali costituisce una ulteriore conferma di tali affermazioni.
In Rigoletto, la figura del
padre-baritono, più volte magistralmente delineata nelle opere precedenti,
si presenta con caratteri ancor più drammaticamente approfonditi:
alle tenerezze e ai sentimenti di ansia e di preoccupazione presenti
nell'immagine che Verdi offre della figura paterna, si assommano, nel buffone
deforme (e la musica ne dà efficace espressione), altri sentimenti
contrastanti e per alcuni aspetti inquietanti e contraddittori. Nell'opera,
si precisa anche, con il tema della «maledizione», quello del
«fatalismo», dell'ineluttabilità del destino. L'affresco
complessivo, poi, che Verdi propone della Corte del Duca di Mantova con
le sue dissolutezze, le sue prepotenze, le sue superficialità, pare
avere come preciso riferimento le piccole, provinciali Corti che agivano,
ai tempi del musicista, nei piccoli staterelli a dominio assolutistico
nei quali l'Italia era smembrata.
Con Il trovatore è
in primo piano il grande amore romantico, cioè tra «le due
voci» (tenore e baritono) che caratterizzano due personaggi maschili,
che rivaleggiano per conquistare l'amore di una donna (un altro tema ricorrente
nella produzione artistica verdiana, ma anche proprio di un filone esaltato
dal Romanticismo), che, quale elemento aggiuntivo in senso tragico, si
scoprono fratelli. Ma di altrettanto rilievo, nell'opera, è la figura
della madre, drammaticamente lacerata dagli avvenimenti crudeli e raccapriccianti
che l'hanno vista, e la vedono, protagonista assoluta della terribile vicenda.
Verdi compie una vera e propria «rivoluzione»
teatrale con La traviata: il realismo e la contemporaneità
del soggetto trattato (un «fatto di cronaca», avvenuto all'epoca
dei soggiorni parigini di Verdi), e l'esaltazione dei più intimi
sentimenti, segnano indelebilmente la narrazione degli avvenimenti della
vita di Violetta.
Si tratta del personaggio femminile
che il musicista ha saputo ritrarre, con la musica, e con grande
affetto, in tutta la sua estrema fragilità, nonché del suo
profondo e totale coinvolgimento nell'esperienza amorosa, nelle gioie e
nei sacrifici di un sentimento che, nella vita di Violetta, risulta certamente
totalizzante.
____________________
(18) Il primo incontro
di Verdi con il teatro di Shakespeare diede, con Macbeth - come
si ricorderà - un risultato solo parzialmente soddisfacente. Le
due opere che Verdi comporrà, traendo i soggetti da capolavori del
teatro di Shakespeare, saranno Otello (1887) e Falstaff (1893).
(19) ... tendere a plasmare
la propria armonia sul modello dei grandi maestri di scuola tedesca.
(20) Il famoso Quartetto (Duca-Maddalena-Rigoletto-Gilda)
di Rigoletto è un esempio mirabile di come siano fusi in
un unico brano, armonicamente perfetto, quattro caratteri, descritti con
la musica, profondamente differenti fra loro.
(21) Il genere si era affermato
soprattutto a opera di alcuni musicisti quali Auber (La muta di Portici,
1828), Rossini (Guillaume Tell, 1829), Meyerbeer (Roberto il
diavolo, 1831; Gli Ugonotti, 1836), Halévy (L'ebrea,
1835); anche Donizetti si era cimentato con il Grand-opéra (La
favorita, 1840). Il Grand-opéra si caratterizzava in particolare
per la sfarzosa sovrabbondanza di scenografie e di grandi masse operanti
sul palcoscenico, per i ricchi costumi, i balli resi fastosi anche da elaboratissime
coreografie, i soggetti di contenuto storico, religioso, esotico. Imponente
per durata, prevedeva inoltre opere comprendenti fino a cinque atti (e
comunque non meno di quattro).
(22) La vicenda si ispira
a quella di Maria Duplessis, morta in giovane età, la quale aveva
avuto parecchi amanti, fra i quali lo stesso Dumas che l'aveva infine abbandonata.
Alexandre Dumas scrisse il romanzo La dame aux camélias nel
1848, adattandolo per le scene nel 1852.
(23) Il soprano Fanny Salvini-Donatelli
era l'interprete designata a sostenere il ruolo principale nell’opera.
(24) Scultore romano, amico
di Verdi.
(25) Verdi stesso, in una
sua lettera da Parigi, fa cenno a questi ritocchi e modifiche.
____________________
|
Stai ascoltando il Brindisi
dalla Traviata
|
|