| Chi ha visitato Firenze negli ultimi mesi non ha più visto, nella Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, un'immagine notissima anche a tutti coloro che non si erano mai recati in quella città. Le più tradizionali rappresentazioni iconografiche di Firenze, infatti, non mancano mai di mostrare il Ponte Vecchio, il panorama ripreso da Piazzale Michelangelo, la facciata di Santa Croce, la Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria; proprio in quest'ultima faceva bella mostra di sé la statua del Perseo. Chi raggiungerà la bella città toscana si risparmi però un infarto: il bel giovane eroe di Benvenuto Cellini non è stato sottratto da ignoti o distrutto dagli insulti del tempo anche se, evidentemente, questi sono stati così rilevanti da richiedere una minuziosa opera di restauro della statua. |
 ............................ ............................ |
| La scelta del capolavoro del Cellini, tra le tante opere da restaurare a Firenze, non è casuale. Il Perseo mostra la sua bellezza dal 1554 ed è considerato da tutti gli storici e appassionati di storia dell'arte la statua in bronzo più significativa della sua epoca. Cellini ha infatti utilizzato, innovandole, tutte le tecnologie disponibili al tempo per realizzare un progetto nel quale sono riconoscibili i valori promossi dalla cultura umanistica: il rigore della forma in competizione con le opere degli antichi, il richiamo ai significati della mitologia classica, il messaggio di forza giusta e pacificatrice che voleva trasmettere Cosimo I de' Medici, signore di Firenze e committente dell'opera. |
|
|
| L'opera è stata
spostata in una sala degli Uffizi.
Dopo i primi mesi necessari ai restauratori per le indagini preliminari
sulla statua, attualmente il restauro del Perseo sarà visibile al
pubblico; dall'alto di una balaustra, infatti, si potrà osservare
l'équipe dei restauratori all'opera. Contemporaneamente all'apertura
del restauro al pubblico verrà inaugurata, in una stanza attigua,
una mostra multimediale interattiva. Questa iniziativa, curata dallo studioso
dell'arte Dario Trento, prevede l'uso delle nuove tecnologie per presentare
gli aspetti più significativi dell'opera del Cellini e la sua affascinante
genesi.
A questa mostra "reale" si affiancherà anche una "mostra virtuale". Gran parte dei contenuti della mostra saranno infatti disponibili su Internet. Gli utenti della rete potranno vedere in tempo reale le immagini del restauro, ricevere notizie sull'andamento dei lavori, dialogare con i restauratori attraverso una casella di posta elettronica. La mostra sarà articolata in 12 postazioni multimediali sulle quali verrà installato un programma "navigabile" dai visitatori i cui due temi fondamentali saranno: "Benvenuto Cellini e la creazione del Perseo" e "Il Restauro del Perseo". La prima sezione permetterà al visitatore di scegliere un percorso nella storia della Firenze del Cinquecento, facendogli conoscere le origini del mito di Perseo, le fasi di creazione dell'opera (durate oltre dieci anni), il rapporto tra Cellini e i suoi committenti. Il secondo gruppo di informazioni sarà dedicato alle tecnologie: quelle dell'epoca, utilizzate dal Cellini, e quelle di oggi che permettono di indagare e ricostruire la genesi del capolavoro e di restaurarlo. |
|
e la fusione del Perseo |
| Benvenuto
Cellini (Firenze 1500-71) fu orafo e scultore. Ebbe una vita avventurosa,
migrando da Firenze a Bologna, a Napoli, a Mantova, a Parigi, a Roma, dove
soggiornò dal 1523 al 1540 protetto da Clemente VII e da Paolo III.
Partecipò nel 1527 alla difesa di Castel Sant’Angelo.
Coinvolto in omicidi e scandali, nel 1540 andò in Francia al servizio di Francesco I, per il quale cesellò la "Saliera", tipica realizzazione di gusto manierista e di virtuosismo tecnico. Nel 1545 tornò a Firenze, dove eseguì per Cosimo il celebre "Perseo". Cellini scrisse una sua "Vita" che è tra le autobiografie più tipiche del Rinascimento. Dalla "Vita" sono tratti e qui di seguito riportati due brani: uno descrive con impietosa minuzia una scultura di Baccio Bandinelli, l’"Ercole e Caco", tuttora visibile (all’entrata di Palazzo Vecchio, a Firenze, fa da pendant – a destra – alla riproduzione del "David" di Michelangelo); il secondo brano riguarda le fasi avventurose della fusione in bronzo della statua di Perseo, dal 1545 nella Loggia della Signoria a Firenze (come si è detto, dallo scorso anno in una delle Sale degli Uffizi per il restauro). 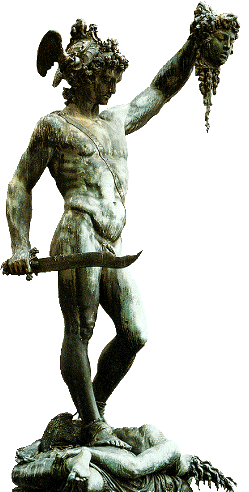 Quando
la statua apparve sotto la Loggia fu oggetto di grande ammirazione da parte
dei fiorentini: non vi fu giorno in cui ai piedi del Perseo non fossero
posti decine di messaggi di lode, poesie, frasi di elogio per l’autore
di tale artistica bellezza. Quando
la statua apparve sotto la Loggia fu oggetto di grande ammirazione da parte
dei fiorentini: non vi fu giorno in cui ai piedi del Perseo non fossero
posti decine di messaggi di lode, poesie, frasi di elogio per l’autore
di tale artistica bellezza.
I capitoli sulla fusione del "colosso" di bronzo (insieme a quelli sulla difesa di Castel Sant'Angelo a Roma) sono certo fra i più famosi e fra i più artisticamente significativi del libro. Dato il temperamento impetuoso e aggressivo dell'artefice, l'esecuzione della statua viene a configurarsi come una difficile, movimentata battaglia, ove lo scultore è il comandante in capo e i garzoni, che per l'occasione sembrano essersi moltiplicati, diventano l'esercito, docile ai suoi ordini. L'intero episodio è sotteso in un arco che si può definire epico, in cui ogni particolare – il divampare delle fiamme, il soffiare del vento, lo scroscio della pioggia, l'incendio che si estende alla bottega, le frasi d'incitamento di Benvenuto, e quindi il pericolo che la statua non riesca bene e l'accorrere dell'autore febbricitante a salvare in tempo l'opera sua... – concorre a creare un’aura di tensione drammatica, verso cui sembra convergere, quasi "torrente ch'alta vena preme", la carica narrativa dell'autobiografia. La figura di Benvenuto Cellini appare, nell’episodio della fusione del suo massimo capolavoro, energica e robusta; ma è da notare che il suo non è un eroismo programmatico, ma che si tratta, invece, della risonanza e dell'elevazione naturalmente eroica, cui riesce ad assurgere una potente personalità, interamente manifesta nella narrazione dell’episodio e si pensi ad alcuni particolari che giovano a sottolineare l'umanità di questo, o a ristabilirne l'equilibrio complessivo, attenuando opportunamente le impennate da epopea e gli accenti, per dirla nel linguaggio della musica, "in fortissimo", spia e quasi emblema del "diabolico furore" del protagonista. La vicenda della fusione della statua bronzea è preceduta da un’altra citazione dalla "Vita" di Benvenuto Cellini: un episodio nel quale Cellini critica la statua Ercole e Caco di Baccio Bandinelli. La "lingua" utilizzata dal Cellini è il "volgare" in uso nella sua stessa epoca. . . dal Capitolo LXX . In mentre che io così piacevolmente intrattenevo lo Duca [Cosimo de’ Medici] avenne che un paggio uscì fuori della guardaroba e che, nell’uscire il detto, entrò il Bandinello. Vedutolo ‘l Duca, mezzo si conturbò e con cera austera gli disse: "Che andate voi facendo?" Il detto Bandinello, sanza rispondere altro, subito gittò gli occhi a quella cassetta dove era la detta statua scoperta [si trattava di una cassetta contenente una statuetta greca in marmo, dono di Stefano Colonna dei principi di Palestrina a Cosimo] e con suo mal ghignaccio, scotendo ‘l capo, disse, volgendosi inverso ‘l Duca: "Signore, queste son di quelle cose che io ho tante volte dette a vostra Eccellenzia illustrissima. Sappiate che questi antichi non intendevano niente la notomia, e per questo le opere loro sono tutte piene d’errori". Io mi stavo cheto e non attendevo a nulla di quello ch’egli diceva, anzi gli avevo volte le reni. Subito che questa bestia ebbe finita la sua dispiacevol cicalata, il Duca disse: "O Benvenuto, questo si è tutto ‘l contrario di quello che con tante belle ragioni tu m’hai pure ora sì ben dimostro: sì che difendila un poco". 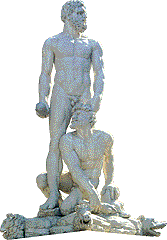 A
queste ducal parole, portemi con tal piacevolezza, subito io risposi e
dissi: "Signor mio, vostra Eccellenzia illustrissima ha da sapere che Baccio
Bandinelli è composto tutto di male, e così ei è stato
sempre: di modo che ciò che lui guarda, subito a’ sua dispacevoli
occhi […] subito le si convertono in un pessimo male. Ma io, che solo son
tirato al bene, veggo più santamente ‘l vero: di modo che quello
che io ho detto di questa bellissima statua a vostra Eccellenzia illustrissima
si è tutto il puro vero, e quello che n’ha ditto ‘l Bandinello si
è tutto quel male solo, di quel che lui è composto". […]
mentre io dicevo queste cose il Bandinello si scontorceva e faceva i più
brutti visi del suo viso, che era bruttissimo che imaginar si possa al
mondo […] A
queste ducal parole, portemi con tal piacevolezza, subito io risposi e
dissi: "Signor mio, vostra Eccellenzia illustrissima ha da sapere che Baccio
Bandinelli è composto tutto di male, e così ei è stato
sempre: di modo che ciò che lui guarda, subito a’ sua dispacevoli
occhi […] subito le si convertono in un pessimo male. Ma io, che solo son
tirato al bene, veggo più santamente ‘l vero: di modo che quello
che io ho detto di questa bellissima statua a vostra Eccellenzia illustrissima
si è tutto il puro vero, e quello che n’ha ditto ‘l Bandinello si
è tutto quel male solo, di quel che lui è composto". […]
mentre io dicevo queste cose il Bandinello si scontorceva e faceva i più
brutti visi del suo viso, che era bruttissimo che imaginar si possa al
mondo […]
Bandinello cominciò a favellare e disse: "Signore, quando io scopersi il mio Ercole e Caco, certo che io credo che più di cento sonettacci ei mi fu fatti, i quali dicevano il peggio che inmaginar si possa al mondo da questo popolaccio". Io allora risposi e dissi: " Signore, quando 'I nostro Michelagniolo Buonaroti scoperse la sua Sacrestia, dove ei si vidde tante belle figure questa mirabile e virtuosa Scuola, amica della verità e del bene, gli fecie piu' di cento sonetti, a gara l'un l'altro a chi ne poteva dir meglio; e così come quella del Bandinello meritava quel tanto male che lui dice che della sua si disse, così meritava quel tanto bene quella del Buonaroti, che di lei si disse". A queste mie parole il Bandinello venne in tanta rabbia che ei crepava, e mi si volse e disse: "E tu che le sapresti apporre?" "Io te lo dirò, se tu arai tanta pazienza di sapermi ascoltare […] Sappi ch'ei m'increscie di averti a dire e' difetti di quella tua opera; ma non io dirò tal cose, anzi ti dirò tutto quello che dice questa virtuosissima Scuola. […] Questa virtuosa Scuola dice che, se e' si tosasse i capegli a Ercole, che e' non vi resterebbe zucca che fussi tanta per riporvi il cervello; e che quella sua faccia e' non si conoscie se l'è di orno o se l'è di lionbue; e che la non bada a quel che la fa, e che l'è male appiccata in sul collo, con tanta poca arte e con tanta mala grazia che e' non si vide mai peggio; e che quelle sue spallaccie somigliano dua arcioni d'un basto d'un asino; e che le sue poppe e il resto di quei muscoli non son ritratti da un omo, ma sono ritratti da un saccaccio pieno di poponi, che diritto sia messo, appoggiato al muro. Così le schiene paiono ritratte da un sacco pieno di zucche lunghe; le due gambe e' non si conosce in che modo si sieno appiccate a quel torsaccio: perché e' non si conosce in su qual gamba e' posa o in su quale e' fa qualche dimostrazione di forza; né manco si vede che ei posi in su tutt'a dua, sì' come e' s'è usato alcune volte di fare da quei maestri che sanno qualche cosa: ben si vede che la cade innanzi più d'un terzo di braccio; che questo solo si è 'I maggiore e il più incomportabile errore che faccino quei maestracci di dozzina plebe. Delle braccia dicono che le son tutt'a dua giù distese senza nessuna grazia, né vi si vede arte, come se mai voi non avessi visto degl'ignudi vivi, e che la gamba dritta d'Ercole e quella di Caco fanno a mezzo delle polpe delle gambe loro; che se un de' dua si scostassi dall'altro, non tanto l'uno di loro, anzi tutt'a dua resterebbono senza polpe da quella parte che ei si toccano; e dicono che uno de i piedi di Ercole si è sotterrato, e che l'altro pare che gli abbia il fuoco sotto. Sulla fusione del Perseo dai
Capitoli LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI .
dal
Capitolo LXXVIII.
|
|
Benvenuto
Cellini
|
|
|
 Il
blocco di Medusa è un capolavoro di virtuosismo manierista: il corpo
poggia su un cuscino al di sopra del quale sta anche il mantello di Perseo.
I bordi del mantello modellati fluidamente e definiti con minuzia, cadono
sui lati della statua. Sopra il mantello è collocato lo scudo ed
è su di esso che poggia il piede sinistro dell'eroe, mentre il destro,
leggero, poggia sul corpo di Medusa.
Il
blocco di Medusa è un capolavoro di virtuosismo manierista: il corpo
poggia su un cuscino al di sopra del quale sta anche il mantello di Perseo.
I bordi del mantello modellati fluidamente e definiti con minuzia, cadono
sui lati della statua. Sopra il mantello è collocato lo scudo ed
è su di esso che poggia il piede sinistro dell'eroe, mentre il destro,
leggero, poggia sul corpo di Medusa.
 Lasciato
che io ebbi dua giorni freddare la mia gittata opera, cominciai a scoprirla
pian piano; e trovai, la prima cosa, la testa della Medusa, che era venuta
benissimo per virtù degli sfiatatoi, si' come io dissi al Duca che
la natura del fuoco si era l'andare all'in su; di poi seguitai di scoprire
il resto e trovai l'altra testa, ciò è quella del Perseo,
che era venuta similmente benissimo; e questa mi dette molto più
di meraviglia perché, sicome e' si vede, l'è più bassa
assai bene di quella della Medusa. E perché le bocche di detta opera
si erano poste nel disopra della testa del Perseo e per le spalle, io trovai
che alla fine della detta testa del Perseo si era appunto finito tutto
'I bronzo che era nella mia fornace.
Lasciato
che io ebbi dua giorni freddare la mia gittata opera, cominciai a scoprirla
pian piano; e trovai, la prima cosa, la testa della Medusa, che era venuta
benissimo per virtù degli sfiatatoi, si' come io dissi al Duca che
la natura del fuoco si era l'andare all'in su; di poi seguitai di scoprire
il resto e trovai l'altra testa, ciò è quella del Perseo,
che era venuta similmente benissimo; e questa mi dette molto più
di meraviglia perché, sicome e' si vede, l'è più bassa
assai bene di quella della Medusa. E perché le bocche di detta opera
si erano poste nel disopra della testa del Perseo e per le spalle, io trovai
che alla fine della detta testa del Perseo si era appunto finito tutto
'I bronzo che era nella mia fornace.
